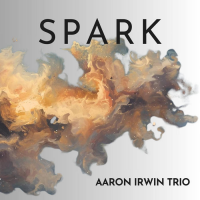Home » Articoli » Live Review » Umbria Jazz 2025
Umbria Jazz 2025

Courtesy Roberto Cifarelli
Varie sedi
Perugia
11—20 luglio 2025
Basta scorrere il cartellone di Umbria Jazz 2025—soprattutto gli appuntamenti succedutisi al teatro Morlacchi, al Teatro Pavone e alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria, ma anche le serate jazzistiche all'Arena Santa Giuliana—per rendersi conto di quanto quest'anno la programmazione fosse nutrita e di qualità elevata. Ho fatto il possibile per partecipare a quattro giorni del festival, sui dieci totali, il che permette di dare solo un resoconto parziale, tutt'altro che esaustivo della varia gamma di proposte. D'altra parte posso considerare il mio bicchiere mezzo pieno, visto che nella mia permanenza a Perugia, a differenza di tutti gli altri anni, non ho avuto il piacere d'incontrare nessun altro critico in rappresentanza di testate specializzate. Nella scelta delle giornate, ho seguito un filo rosso che mi permettesse di ascoltare e mettere a confronto alcuni grandi sassofonisti, tutti tenoristi ed esponenti dell'attuale scena statunitense, anche se purtroppo ho dovuto perdere il concerto di Immanuel Wilkins. Altro filone che ho previlegiato è stato quello dei pianisti, pur non essendo riuscito ad ascoltare le performance di molti di loro, compreso l'atteso Craig Taborn.
All'Arena Santa Giuliana ha pienamente convinto Stefano Bollani, in veste di compositore e leader oltre che di pianista ovviamente. Il quintetto pressoché inedito, alla sua terza apparizione, era completato da due californiani, Larry Grenadier al contrabbasso e il batterista Jeff Ballard, attualmente residente in Italia, dal francese Vincent Peirani alla fisarmonica e dal brasiliano Mauro Refosco alle percussioni. Una sorta di all stars, come si può ben vedere, per i membri della quale il leader ha concepito nuovi brani ben caratterizzati, giocati su un senso melodico seducente, spesso dai sapori brasiliani e/o ispirato alla loro provenienza d'origine. Gli impianti ritmici, per lo più sostenuti, si sono acquietati in ballad intimiste, come avviene in "Peiranite" dedicato al fisarmonicista. Ballard non poteva che essere il plausibile dedicatario di "Umbria Jeff," mentre per Refosco è stato scritto "Choro in the Light"; nel finale non sono mancate una rivisitazione di "And I Love Her" di Paul McCartney e una briosa madley in cui si intrecciavano quattro canzoni famosissime tratte dai paesi d'origine dei membri del gruppo. Il quintetto ha trovato quell'intesa, quell'interplay efficiente come solo i grandi interpreti sono in grado di raggiungere all'istante ed ognuno ha goduto dei suoi spazi d'esposizione: Peirani con il suo eloquio spiritato e visionario, che ha preso movenze insinuanti all'accordina, il contrabbassista, dotato di un pizzicato solido ed elegante, mentre Ballard e Refosco hanno fornito un sostegno ritmico sempre spumeggiante e pertinente. Quanto a Bollani, ha saputo compenetrare con trascinante autorevolezza appunto i ruoli di compositore e leader, emergendo in spunti pianistici di notevole spessore, evocativi, percussivi e fluidi al tempo stesso.
L'incipit del concerto di Herbie Hancock, sempre all'Arena, si è svolto all'insegna di una stratificazione di stranianti sonorità elettroniche, per poi lasciare il posto ad un composito affresco, in cui si sono succedute ed incrociate situazioni diversificate e suggestive: temi più o meno occulti, spunti pianistici percussivi e perentori come un tempo, sovrapposizioni di voci omologhe, accelerazioni e diradamenti dinamici, alternanze fra sonorità acustiche ed elettroniche, brevi spazi solistici... Nel complesso tutto ha funzionato, procedendo con un convinto e compatto interplay, grazie al carisma del leader e ad interventi individuali che hanno costituito un valore aggiunto: soprattutto quelli della tromba sforzata di Terence Blanchard, ma anche gli spunti del giovane batterista Jaylen Petinaud e del basso costante ma mai invadente di James Genus. Immancabile è arrivato l'omaggio a Wayne Shorter, con la riproposizione di una versione di "Footprints" nell'arrangiamento di Blanchard. In questa performance generosa come sempre e piena di valide idee, che ha registrato il tutto esaurito, l'ottantacinquenne maestro ha costruito un'autocelebrazione di se stesso, affiancato da un manipolo di fedeli partner. Eppure, a giudizio del tutto personale, non sono mancate alcune trovate di dubbio gusto; mi riferisco in particolare allo spazio del tutto solitario affidato alla chitarra e alla voce sdolcinate di Lionel Loueke e ad altrettanti espedienti di deformazione elettronica di effetto scontato di cui si sono ammantate le parole e le tastiere dello stesso leader.
Un altro pianista, Sullivan Fortner, che avevamo imparato a conoscere come caposaldo del gruppo di Cecile McLorin Salvant e negli ultimi anni anche come solo-performer, si è presentato al Teatro Morlacchi alla testa di un trio comprendente Tyrone Allen II al contrabbasso e Kayvon Gordon alla batteria. Il suo è un pianismo enciclopedico, non solo nei confronti del suo background jazzistico, ma anche perché attinge da un repertorio composito, affrontando pertinenti ed apprezzabilissime versioni di arie pucciniane o di canzoni di varie origini culturali, come "Estate" del nostro Bruno Martino. La conduzione delle sue improvvisazioni, citazionista, discontinua e imprevedibile, si avvale di soluzioni armoniche, dinamiche e timbriche eccentriche. Inaspettatamente, al pianoforte Fortner ha alternato l'organo Hammond, esibendo una diteggiatura frammentaria e saltellante, senza rinunciare alle soluzioni sonore gonfie e risonanti, d'immediato impatto, tipiche dello strumento. Sta di fatto che il fantasioso mondo poetico di questo singolare personaggio si è rivelato propulsivo e motivante nei confronti dei due partner che lo assecondavano, strumentisti non geniali, ma dotati della giusta carica espressiva; in un noto standard il leader ha azzardato perfino di lasciare al contrabbassista l'esposizione iniziale del tema, limitandosi lui a pochi, isolati accordi. Alche a capo di un trio, Fortner ha quindi dato dimostrazione di essere in grado di gestire una performance non solo godibilissima, ma anche carica di sorprese e di invenzioni tecniche, espressive ed emotive.
Ascoltai e intervistai Melissa Aldana agli esordi della sua carriera internazionale; oggi l'ho ritrovata nella pienezza della sua maturità, autrice di un linguaggio d'indubbia coerenza ed estremamente caratterizzato. I suoi original si configurano quasi sempre come ballad circonvolute e meditative, che evolvono nel senso dinamico-ritmico, raggiungendo rare concentrazioni di energia, per altro affidate per lo più ai fidati partner, sempre pertinenti e professionali, in linea con l'impostazione della leader: Pablo Held al pianoforte, Pablo Menares al contrabbasso e Kush Abadey alla batteria. Questa visione compositiva si connette strettamente alla sonorità del tutto personale del suo tenore: ad attacchi morbidi fanno seguito continui e sensibili aumenti e diminuzioni del volume all'interno della stessa frase. A proprio agio nel registro grave come in quello acuto, la cadenza compassata del suo fraseggio presenta le analogie maggiori con la pronuncia di Greg Osby, che fu uno dei suoi insegnanti, e quella narrativamente più mossa di Charles Lloyd. Tutto è emerso coerente e di tenace personalità quindi nella musica della trentaseienne sassofonista cilena, anche se nell'arco dei due set replicati alla Sala Podiani il suo mondo poetico-espressivo è apparso un po' uniforme, sorretto da un puntiglioso perfezionismo piuttosto che dalla volontà di esternare forti emozioni; una sorta di appagante manierismo fa sì che vengano evitati brani dal ritmo sostenuto, in grado di avviare uno slancio interpretativo estroverso e avvincente.
Per certi versi analoga alla musica saggiamente costruita della Aldana è stata la proposta del quartetto di Mark Turner. In questo caso tutto il senso melodico del pianoless quartet era sostenuto dal dialogo costante sviluppato dai due fiati: il tenore del leader e la tromba di Jason Palmer, che hanno dato forma a unisoni, controcanti, deviazioni e chase, in un'alternanza o in una stretta compenetrazione dei ruoli da protagonista. A fronte del sound e del fraseggio levigati di Turner, si è contrapposta o coniugata la pronuncia relativamente più scabra e sdrucciola del trombettista. Il loro raffronto incessante ha costituito il carattere particolarissimo di questa anomala formazione, che si è avvalsa anche del contributo assolutamente consonante dei due partner: il notevole contrabbassista Joe Martin, dotato di un suono morbido, scuro e ovattato, nonché di un procedere controllato ma estremamente tonico nei crescendo più veloci, e il batterista Jonathan Pinson, responsabile di un drumming fitto, continuo, incalzante ma giocato su una minuta e cangiante trama timbrica. Fra l'altro quest'ultimo ha goduto di un lungo assolo nel primo brano, contraddicendo l'abitudine che esso venga collocato verso la fine del concerto come il botto finale dei fuochi d'artificio. Mark Turner, individuato fin dagli esordi come un esponente dell'attuale corrente neo-cool, in questo progetto ha evidenziato uno specifico impianto tristaniano, nel modo di concepire i temi aperti e stimolanti, di ottenere un sinergico interplay nell'intreccio delle voci ed anche uno swingante senso ritmico. La musica originale e raffinatissima, compatta e vitale offerta da questo gruppo ha rappresentato il vertice estetico fra tutte le proposte da me ascoltate al festival perugino.
Del tutto diverse, e per certi aspetti fra loro assimilabili, si sono rivelate le performance di altri due tenoristi presentati in questa edizione di Umbria Jazz. Il concerto di Isaiah Collier and the Chosen Few al Teatro Morlacchi è stato aperto da un accordo tyneriano della pianista Liya Grigoryan, da una sventagliata sulle campane sospese e da un deciso colpo di gong da parte del leader: incipit che sembrava introdurre a una "festa coltraniana." Nella realtà gli sviluppi hanno preso poi un andamento diverso, e a ragione, considerato che sono passati sessant'anni dai documenti memorabili lasciati da uno dei maestri del jazz che tuttora rimane un punto di riferimento. Le progressioni del tenorista, inerpicandosi verso note strozzate nel registro acuto, hanno inscenato una certa ritualità; ma a ben vedere il carattere predominante della sua pronuncia è consistito nell'emissione di brevi frasi in successione, ben disegnate e replicate più volte. Il drumming di Tim Regis, impetuoso nelle fasi veloci, è rimasto giustamente appartato nei passaggi musicali più pacati, mentre attinente e senza strafare è risultato il lavoro della contrabbassista Emma Dayhuff e della già citata pianista. Il repertorio, tutto basato sui brani del recente disco The World is on Fire, si è concluso con la title track, in cui si è stagliato un infuocato duo fra sax e batteria, questo sì decisamente coltraniano. In definitiva la proposta jazzistica di Collier si è presentata per lo più autentica, diretta e onesta, come pure i suoi discorsi di forte impegno politico che, alternati ai brani, ne hanno esplicitato i contenuti; tuttavia si ha l'impressione che, replicati di concerto in concerto, questi mezzi possano correre il rischio di celebrare una ritualità un po' convenzionale, cadendo nella routine.
Dopo quasi dieci anni—la prima volta che ascoltai Kamasi Washington fu nel novembre 2015 al Locomotiv Club all'interno di Bologna Jazz —sentivo l'esigenza di verificare dal vivo la consistenza del suo linguaggio e del suo messaggio. Nella sua apparizione perugina ho trovato ben poco di nuovo, anzi penso che il Washington di oggi abbia semplificato e schematizzato la sua proposta, sacrificando parte della presunta autenticità originaria. La larga formazione prevedeva tre fiati—il suo tenore era affiancato da un trombettista e dal soprano e flauto tuttora affidati al padre—tastiere, contrabbasso e batteria, oltre a una vocalist saltuariamente utilizzata e a un DJ, addetto anche all'elettronica e alle percussioni. Questo ottetto, a cui si è aggiunta occasionalmente il canto della moglie del leader, ha perlustrato un repertorio di temi semplici e protratti, comprendente anche una composizione basata su una scala tracciata sul pianoforte dalla figlia di due anni. Se il valore espressivo dei singoli musicisti a volte si è rivelato dubbio—è il caso di salvare almeno l'esperto ed efficiente bassista Miles Mosley, oltre al fraseggio del leader nelle sequenze veloci, puntute e dagli ampi intervalli—lo spiritual jazz del quarantaquattrenne sassofonista di Los Angeles avrebbe dovuto far rivivere un forte senso comunitario, cercando di creare una trama collettiva rituale e pulsante. Al contrario tutto è risultato per lo più autocompiaciuto, frammentario, ripetitivo e artificiale, con poca sostanza da comunicare, raggiungendo l'opinabile espediente, poco deontologico, di far sfilare sul palco tutta la famiglia.
Esaurita la schiera dei sassofonisti, concludo questo resoconto riferendo di Honey From A Winter Stone, progetto fortemente strutturato e complesso di Ambrose Akinmusire, già sul pregevole disco omonimo edito dalla Nonesuch. Sono molteplici gli umori e i meandri compositivi che compongono questo lavoro dell'autorevole leader, che alla tromba si è riservato non frequenti ma pregevolissimi sprazzi dal piglio stentoreo e bruciante, raggiungendo note liriche e brusche nel registro acuto. Più spesso invece si è dedicato a una tastiera elettronica producendo in sottofondo linee melodiche distese ed evocative. La sezione ritmica corposa e mobile, chiamata ad insistere su metriche quasi funky come a tramare consistenti collettivi free, era composta dagli insostituibili Sam Harris al pianoforte, Reggie Washington al basso elettrico e Justin Brown alla batteria. In questo contesto le parole e i testi erano assegnati esclusivamente al canto veloce ed esagitato del rapper Kokayi, già con i Five Elements di Steve Coleman. La prorompente blackness di questo quintetto era affiancata dagli interventi di un quartetto d'archi, ora interagenti con l'intera formazione ora in evidenza in propri episodi, le cui partiture inserivano un indubbio ingrediente "colto," a volte contrapposto all'elemento jazzistico, ma più spesso occasione per fornire colori cangianti e alieni o spunti di aggiornato minimalismo. Con questo organico Akinmusire ha quindi coordinato una performance ambiziosa e articolata, innervata da una sensibilità trasversale e attuale, dagli esiti ammirevoli, se percepita con il cuore e la mente, con partecipata disponibilità.
Tags
Live Review
Mark Turner
Libero Farnè
Italy
Perugia
Immanuel Wilkins
Craig Taborn
Stafano Bollani
Larry Grenadier
Jeff Ballard
Vincent Peirani
Mauro Refosco
Herbie Hancock
Terence Blanchard
Jaylen Petinaud
James Genus
Wayne Shorter
Lionel Loueke
Sullivan Fortner
Cecile McLorin Salvant
Melissa Aldana
Pablo Held
Pablo Menares
Kush Abadey
Greg Osby
charles lloyd
Jason Palmer
Joe Martin
Jonathan Pinson
Isaiah Collier
Tim Regis
kamasi washington
miles mosley
ambrose akinmusire
Reggie Washington
Justin Brown
Kokayi
Steve Coleman
PREVIOUS / NEXT
Mark Turner Concerts
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.