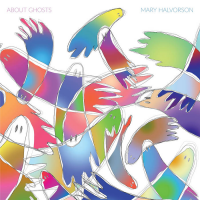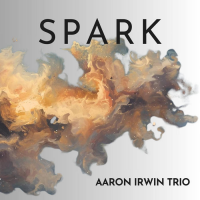Home » Articoli » Live Review » AngelicA 35 a Bologna e Modena
AngelicA 35 a Bologna e Modena

Courtesy Massimo Golfieri
Festival Internazionale di Musica
Bologna, Modena
Varie sedi
30 aprile—31 maggio 2025
Da sempre il festival bolognese permette di assistere alle più varie esperienze musicali dell'attualità, senza vincolarsi a generi, autori o prassi esecutive. Ma forse un limite se lo è imposto Massimo Simonini, infaticabile e coerente direttore artistico: quello di evitare sempre qualsiasi espressione del già affermato mainstream, del "popular" ormai troppo consolidato e riconosciuto. Una prerogativa di AngelicA è quella di presentare quasi sempre produzioni originali in prima assoluta, oppure progetti in prima italiana, affidando l'organizzazione dei concerti di volta in volta al lavoro competente di diversi curatori. Di questa edizione del festival, partito nel lontano 1991 e seguito da un fedele pubblico di ascoltatori curiosi e disponibili, ho selezionato alcuni concerti secondo me particolarmente interessanti; mi rimane il rammarico però di aver escluso per varie ragioni gli altri appuntamenti.
Appunto con una prima assoluta si è aperto il festival del 2025 nell'abituale sede del Centro di Ricerca Musicale al Teatro San Leonardo, presentando il binomio Charlemagne Palestine & Rhys Chatham in "Two forrrrr AngelicA." Come in certi dipinti monocromi uniformi ma vibranti, in cui trapelano minime variazioni timbriche, frutto di varie stesure di colore lente e ponderate, così l'incipit del concerto è stato caratterizzato da velature sonore, da tenui cromatismi elettronici, atti a favorire uno stato di meditazione. Il lento ma solidale impasto fra il pianoforte di Palestine e le chitarre e i flauti di Chatham, entrambi anche alle tastiere elettroniche e al loop, ha determinato un graduale movimento dinamico, una leggerissima increspatura sonora, sempre a volume molto trattenuto. Nel finale un improvviso canto ben modulato da Palestine, con inflessioni vicine alla tradizione indiana, ha preceduto la conclusione del concerto nel segno dello spegnimento, troppo repentino, delle tessiture elettroniche. In definitiva si è sviluppata una performance che, per gli esecutori come per gli ascoltatoti, sembrava reggersi su un'ambiguità di fondo, o meglio sulla conciliazione degli opposti: musica della stasi estenuata o dell'estasi? Lenta evoluzione o immersione incondizionata nella materia sonora? Trance ipnotica o controllo della consapevolezza?
Poche sere dopo, al Teatro Comunale di Modena, Rhys Chatham ha ripreso il suo A Secret Rose for 35, nell'inedita versione per 33 chitarre, basso elettrico e batteria. Rispetto al duo dell'inaugurazione, più imponente è risultata la massa sonora creata dall'ampia formazione di chitarre, anche per la tessitura più densa; sempre in evidenza l'ossatura ritmica fornita dalle metriche infallibili del batterista Jonathan Kane e dai riff di volta in volta variati del basso elettrico di Myriam Stamoulis. Col procedere della performance si sono andate complicando le articolazioni combinatorie degli interventi chitarristici, fino a raggiungere, nel finale "Movement 5—G33," un crescendo parossistico con fasi di monolitica fissità protratte ad libitum, esasperando la dimensione rituale di questo tipo di performance. Certamente l'operazione deve essere stata un'esperienza laboratoriale indimenticabile per i 33 allievi dei vari conservatori dell'Emilia-Romagna che componevano l'orchestra, suddivisi in due gruppi a destra e sinistra del palco e guidati da due colleghi coetanei, mentre Chatham al centro della scena, ieratico e metronomico, dirigeva il tutto.
Il 13 maggio Charlemagne Palestine è ricomparso in solo, misurandosi con l'organo della Basilica di Santa Maria dei Servi per riproporre Schlingen Blängen, opera seminale risalente agli anni Sessanta e in seguito riadattata a contingenze sempre diverse. Il pubblico è stato accolto da un flebile accordo fisso e incantatorio emesso dall'organo, che è perdurato anche quando il performer, immobile e al buio al centro esatto dell'ultima campata della navata centrale, ha atteso e ottenuto il silenzio degli spettatori, prima di intonare un canto un po' sofferto, spiegato e mutevole che sembrava evocare certe modulazioni dei nativi d'America. Spostatosi poi all'organo ha via via inspessito la trama armonica ottenendo battimenti e risonanze voluminose, misteriose, avvolgenti, dalle quali a tratti sembravano emergere semplici e sotterranee linee melodiche. Altri accordi più decisi si sono aggiunti e la massa sonora si è fatta sempre più rigogliosa, incombente e inquietante. Tutta la progressione, beneficiando dell'acustica della chiesa gotica, ha portato ad una pienezza sonora assoluta, incontenibile ed esaltante, che nel finale è andata scemando abbastanza repentinamente.
Altri aspetti eccentrici e personalissimi di una concezione minimalista di ieri e di oggi sono emersi in altri concerti che hanno rappresentato una rarità nell'odierno panorama italiano. L'omaggio a Tom Johnson, compositore e critico musicale scomparso nel dicembre 2024, ha riproposto il suo singolare Nine Bells, composizione del 1979 in cui nove campane, allineate a tre a tre e sospese su supporti metallici secondo una griglia quadrata, vengono percosse dall'interprete che, con percorsi prestabiliti e a velocità diverse, anche di corsa, utilizzando di volta in volta mazze differenti, ottiene nove mini-viaggi sonori di maggiore o minore complessità. I passi del cammino del percussionista diventano quindi l'unità di misura su cui vengono costruite le metriche ritmiche sempre diverse delle nove scene compositive, definite anche dalle intensità e dai colori conferiti dai colpi sulle singole campane, le cui risonanze si sovrappongono nel tempo. È evidente che in una performance come questa la componente musicale si coniuga con un parallelo e veemente aspetto ginnico-visivo. Ammirabile l'interpretazione del reggiano Simone Beneventi, Leone d'Argento alla Biennale Musica di Venezia nel 2010, che a Bologna ha dato consistenza sonora e visiva alla composizione, percorrendo più di quattro chilometri.
Un deciso cambio di rotta si è verificato con la prima italiana del duo Naïny Diabaté -Eve Risser, rispettivamente cantante e pianista. Molti aspetti in questo sodalizio, ormai annoso ma certo non logorato dalla routine, si sono rivelati interessanti. La pianista francese, lontana dalle sue proposte più sperimentali e sempre di grande originalità, in solo o a capo di agguerrite compagini, ha saputo estrarre dallo strumento, sapientemente preparato in alcune sezioni della tastiera, sequenze di sicura efficacia, ora struggenti e narrative ora più contrastate e martellanti. Il senso ritmico è sempre stato tracciato con sicurezza, spesso ricorrendo a pedali ripetitivi scanditi con la mano sinistra, ricordando gli andamenti tipici del Dollar Brand delle origini. D'altra parte, in questo contesto il ruolo sostenuto dalla pianista è stato prevalentemente quello di accompagnatrice, in quanto la componente più caratterizzante di questo duo è risultata quella autenticamente etnico-africana portata dalla cantante maliana: non solo per le cadenze ritmiche, ma anche per la sua voce un po' ingolata, che si è estesa stentorea su un registro medio-alto, oltre al contenuto impegnato dei testi, certo non comprensibili ma in precedenza spiegati sinteticamente. In definitiva è risultata convincente la convivenza fra la matrice immediata, terrena, ancestrale della tradizione africana e la consapevole e creativa espansione pianistica in più direzioni.
Anche un altro esponente della ricerca europea più originale, il clarinettista polacco Waclaw Zimpel, si è misurato con una tradizione lontana da quella delle sue origini musicali. Il progetto Saagara infatti, nato nel 2012, lo vede dialogare con tre virtuosi esponenti della musica Carnatica del sud dell'India: Giridhar Udupa al ghatam, Aggu Baba al khanjira e Mysore N. Karthik al violino indiano, tutti anche alla voce e affiancati da Camilo Tirado responsabile del suono. Senza dubbio la componente indiana ha prevalso nettamente, con la tipica sonorità dei suoi strumenti a percussione, le linee melodiche protratte e la fitta poliritmia. Eppure in questi collettivi si sono inseriti con un atteggiamento esuberante sia il clarinetto di Zimpel, che ha dialogato all'unisono con il violinista, sia i suoi interventi all'elettronica; anzi sono stati proprio questi ultimi con le loro trame ipnotiche a costruire il tessuto connettivo del tutto. Alcuni brani più lenti e meno virtuosistici hanno concretizzato atmosfere avvolgenti e meditative, ma l'andatura è diventata travolgente quando le cadenze ritmiche si sono fatte più veloci e incalzanti, mettendo in evidenza soprattutto le impennate free d Zimpel e i trascinanti interventi di Udupa, che nel finale, assieme a Khanjira, ha intrapreso uno scambio nel tipico canto Kannakol. Si può sostenere che anche l'organico di questo progetto, frutto di un profondo confronto culturale, abbia dato esiti di grande affiatamento.
Uno degli impatti più sorprendenti del festival è venuto dal Iancu Dumitrescu & Hyperion International Ensemble, frutto di una residenza di pochi giorni, in cui una formazione cosmopolita ha messo a punto le istruzioni dell'ottantenne compositore e leader rumeno. La musica è iniziata forse ancor prima dell'ora prevista, senza presentazione, a mo' di gentile invito, mentre il pubblico stava ancora entrando alla spicciolata, poi la performance ha gradualmente preso corpo. Dumitrescu, seduto al centro del palco ha gestito una sorta di conduction con una serie di gesti ricorrenti, ora trattenuti ora imperiosi, ma indirizzati alle sezioni dell'affiatatissimo ottetto o ai singoli musicisti, che a loro volta hanno recepito all'istante le indicazioni traducendole in una musica estremamente motivata.
Tutto è risultato ruvido, primitivo, materico, con imprevisti effetti stranianti: dall'andamento strutturale della performance al tipo di interplay, dalle trame timbriche al contributo dei singoli... Fra tutti sono emersi in particolare evidenza gli interventi perentori dei due percussionisti -Chris Cutler e Simone Beneventi—disposti davanti alle estremità destra e sinistra del palco, oltre al particolare uso della chitarra da parte di Dan Antoniu, appoggiata in verticale e per lo più sfregata con l'archetto. Tim Hodgkinson dal suo clarinetto basso ha ottenuto squittii di grande efficacia, mentre il polistrumentista Andrei Kivu si è alternato alla tromba, al flauto e al violoncello. Ma le sonorità più misteriose e avvolgenti sono provenute non dagli strumentisti della front line, ma dal pianoforte preparato e dai dispositivi elettronici, nascosti sul fondo del palcoscenico e manovrati rispettivamente da Octav Avramescu e da Dyslex. Se di composizione istantanea si parla da ben oltre mezzo secolo in diversi ambiti musicali, la performance bolognese ha rappresentato un esempio perfetto di questo metodo musicale. La trama sonora mutevole e coinvolgente, che avrebbe potuto protrarsi ad libitum, è durata nella realtà due ore, ma il tempo percepito è risultato molto inferiore.
Un paio di proposte erano attribuibili all'ambito jazzistico più attuale. Per verificare il peso dell'improvvisazione in performance diverse della medesima formazione, può essere utile il confronto fra il concerto bolognese del trio Circular Pyramid di William Parker, completato da Ava Mendoza e Hamid Drake, e la sua apparizione della sera precedente a Vicenza Jazz (vedasi recensione). Innanzi tutto le condizioni ambientali hanno fatto sì che, rispetto al Teatro Comunale vicentino, il raccolto Teatro San Leonardo, ex chiesa, favorisse un contatto più immediato fra platea e musicisti, creando una situazione quasi da club. In questo contesto ha inciso soprattutto il livello dell'amplificazione, a detta di molti troppo elevato: il che da un lato ha prodotto un senso di tutto pieno, di impatto sonoro soverchiante, portando l'ascoltatore in una immersione rituale e indiscriminata nella massa sonora. D'altro canto questo volume sonoro ha impedito di distinguere e valutare tutti i passaggi della pronuncia dei singoli strumentisti, soprattutto del contrabbassista e del batterista. A metà concerto l'intensità sonora è un po' diminuita, quando Parker ha imboccato l'algaita, accennando, assieme alla Mendoza, a una cadenza di blues e ad atmosfere "africane," mentre Drake prima ha continuato con un drumming pervadente per poi imbracciare il tamburo a cornice, ma senza che si potesse apprezzare del tutto il sublime gioco delle sue mani.
Ben strana, in quanto perentoria, senza mezzi termini, l'interpretazione del mondo musicale di Anthony Braxton da parte del quintetto inglese The Locals, che nella formazione è rimasto invariato dal 2006 quando è apparso al festival Konfrontationen di Nickelsdorf, lasciandone documentazione nell'incisione discografica apparsa solo nel 2021. Il forte impatto della proposta è stato determinato dalla componente ritmica, regolare e pesante, ben poco braxtoniana e vicina piuttosto alle scansioni del free-funk, cadenzata dal basso elettrico di Dominic Lash e soprattutto dal monolitico batterista Darren Hasson Davis; tale fissità si è in parte attenuata solo quando Lash ha imbracciato il contrabbasso. La coppia dei fratelli Thomas -il sessantacinquenne Pat, pianista e animatore del progetto, e il più giovane Evan alla chitarra elettrica—è risultata imperterrita nel tracciare con solidale unitarietà un contesto formicolante, perennemente free, lasciando emergere a tratti pregevoli spunti solistici. Il clarinettista Alex Ward, con la sua voce acuta, sforzata, spigolosa, sempre secondo una pronuncia free, si è messo in evidenza come l'interprete più volitivo, seguendo un tracciato ora geometrico, ora più sfrangiato. In questo paesaggio sonoro prevalente, quasi costante, sono spuntati alcuni episodi relativamente più rarefatti, ma pur sempre intensi, come per esempio la brevissima introduzione di un brano, e la simmetrica chiusura, da parte di pianoforte e clarinetto.
Il festival si è chiuso con una bizzarra prima assoluta, voluta da Massimo Simonini che ha messo insieme due duetti preesistenti: il recente sodalizio fra Cristina Zavalloni ed Enrico Zanisi e il più collaudato duo Vincenzo Vasi—Giorgio Pacorig, nato nel 2009 proprio su commissione di AngelicA. L'enigmatico titolo del concerto, "Senza voce (dal dentista)," si riferiva soprattutto all'intenzione cabarettistica della messa in scena: il palco era immaginato come la sala d'aspetto di un studio odontoiatrico; un'infermiera chiamava a turno i due cantanti, che, dopo essersi assentati a lungo, tornavano in scena doloranti e dissennati per aver perso il dente del giudizio. Si è trattato di un espediente simpatico, anche se non indispensabile, per introdurre il percorso musicale, tutto basato sulla parodia di un repertorio composito e senza pregiudizi. Dopo un lungo e raffinato duo Zavalloni-Zanisi alle prese con uno dei Canti Polacchi di Chopin e con "I Wonder as I Wander" e dopo che l'intero quartetto ha intonato un travolgente, oltre che nostalgico "Papà ha la bua" di Paolo Zavallone, ha preso la scena il duo Vasi-Pacorig, blandendo o strapazzando brani dei Telex, di Claudio Villa, dello stesso Vasi... Di seguito, fino alla fine del concerto, essendo tornati entrambi i cantanti dallo studio dentistico, si è esibito l'intero quartetto rivisitando il tema del film Un uomo, una donna, canzoni della tradizione romana o napoletana, ma anche l'intrigante "Something Stupid" o "Tempesta" di Honsinger—Cavazzoni.
Parodia dunque, umoristica e piena di sorprese interpretative, ma non direi smaccata e dissacrante, in quanto tesa a scoprire ed esaltare una dimensione già insita nelle composizioni stesse. È evidente che i due cantanti hanno tenuto la scena come i veri mattatori, dialogando e scambiandosi i ruoli con ammiccamenti, unisoni, trovate gestuali, controcanti...: decisamente teatrale e virtuosistica la Zavalloni, ironico e più soft, a tratti quasi intimista, Vasi. Determinante e più "professionale" è risultato il contributo dei due tastieristi dall'alto della loro esperienza jazzistica: al pianismo elegante e dinamico di Enrico Zanisi ha fatto riscontro la pronuncia più corrusca e "sperimentale" di Pacorig alle tastiere elettriche ed effetti.
Tags
Live Review
William Parker
Libero Farnè
Italy
Bologna
Massimo Simonini
Charlemagne Palestine
Rhys Chatham
Naïny Diabaté
Eve Risser
Dollar Brand
Wacław Zimpel
Chris Cutler
Tim Hodgkinson
Ava Mendoza
Hamid Drake
anthony braxton
Alex Ward
Cristina Zavalloni
Enrico Zanisi
Vincenzo Vasi
Giorgio Pacorig
PREVIOUS / NEXT
William Parker Concerts
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.