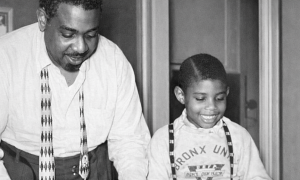Home » Articoli » Live Review » Brda Contemporary Music Festival 2024
Brda Contemporary Music Festival 2024

Courtesy Ziga Koritnik
Sala Cinematografica Medana
Medana, Slovenia
12-14 settembre 2024
Festival unico nel suo genere, interamente dedicato com'è all'improvvisazione più libera, il Brda Contemporary Music Festival era quest'anno alla sua quattordicesima edizione, la seconda svoltasi nel piccolo paese di Medana, una manciata di chilometri dalla frontiera italiana e il medesimo nel quale il Festival Jazz&Wine of Peace, nelle sue prime edizioni, svolgeva il tradizionale concerto oltreconfine. E proprio al fondatore e direttore artistico di quella rassegna, Mauro Bardusco, scomparso pochi mesi fa (clicca qui per leggere un suo ricordo), era quest'anno dedicato il festival sloveno, il cui direttore artistico Zlatko Kaućić era legato a Bardusco da forti sentimenti di stima e amicizia.
Aperto alle collaborazioni con altre arti, anche quest'anno il festival è iniziato con l'inaugurazione di una mostra fotografica, allestita nella sala stessa dove si sono poi svolti tutti i concerti: quella delle foto che Žiga Koritnik ha dedicato a Peter Brötzmann, raccolte nel bel libro Brötzmann in My Focus. Progettato ben prima della scomparsa del sassofonista tedesco, tanto che doveva includere scatti già concordati ma che poi non è stato possibile fare, il libro ha poi preso il significato di un epitaffio; la sua presentazione doveva essere accompagnata da un concerto in solo della chitarrista statunitense Heather Leigh, che all'ultimo momento non è però potuta intervenire (il Covid colpisce ancora...), sostituita dallo stesso Kaučič che, in omaggio al lavoro del fotografo sloveno, si è esibito in un solo di batteria breve ma ricchissimo, delicato e pieno di narratività.
La rassegna ufficiale è iniziata subito dopo, alle 20,00 di giovedì 12 settembre, con uno dei nomi di maggior lustro in cartellone, la pianista Kaja Draksler, in duo con batterista polacco Szymon Gasiorek. In realtà la brillante artista slovena il pianoforte l'ha usato in questo caso con il contagocce, dedicandosi molto più all'elettronica e al campionatore, con i quali ha costruito un set minimalista di suoni infantili e un po' meccanici, che richiamavano quasi la musica dei cartoni animati; Gasiorek interagiva in contrappunto con la batteria, usando però anche la voce, spesso artefatta con filtri elettronici. Aldilà del giudizio estetico, del resto molto soggettivo, il tutto ha destato l'impressione di un arretramento di fronte alla responsabilità di affrontare l'improvvisazione in piena libertà: inserire sequenze campionate, giocare con la mimesi vocale e con suoni ludici è parso un modo per sostituire la costruzione coerente e all'impronta di un discorso coerente. E i pochi, suggestivi, momenti in cui la pianista ha realmente usato la tastiera hanno lasciato un po' d'amaro in bocca per ciò che avrebbe potuto fare e invece non ha fatto.
Ben diverso impatto ha avuto il concerto successivo, quello del trio multinazionale composto dal sassofonista sloveno Bostjan Simon, dal vibrafonista italiano Luigi Vitale e dall'altosassofonista spagnolo Alfonso Munoz. la formazione ha messo in scena una musica tecnicamente assai raffinata e dalla grande varietà stilematica: Simon passava da un uso tradizionale, ancorché sofisticato, del suo sax tenore, alla modulazione del suono con un lavoro sull'ancia, fino alla percussione delle chiavi amplificata sull'uscita del chiver privo del bocchino; Vitale, oltre a sfruttare la ricchezza del suono del suo strumento, giocava con le eco e con vari oggetti posti sulle tessere, tra i quali un tamburello e alcune coppette, usando a margine anche una kalimba; Munoz, infine, era quello che si discostava maggiormente —e forse un po' troppo univocamente —dall'uso "ordinario" dello strumento, non suonando quasi mai frasi e neppure note, ma viceversa emettendo suoni in respirazione circolare e modulandoli attraverso la manipolazione di barattoli e vari altri oggetti posti sulla e nella campana. Il suono complessivo che ne scaturiva era estremamente vario e frastagliato, con lo spagnolo che fungeva da perno fisso attorno al quale i due compagni disegnavano linee cangianti con le loro molteplici forme espressive. Un affresco complesso, a momenti tormentato, ma decisamente interessante e originale.
A concludere una giornata dal tasso tecnico sorprendente è stato il duo dell'altosassofonista francese Christine Abdelnour e del chitarrista elettrico inglese Andy Moor. Anche in questo caso, la sassofonista ha usato il proprio strumento in modo decisamente atipico, anche lei abbondando nella respirazione circolare, alternandola a deformazioni dei suoni operata su ancia e bocchino; dal canto suo, il chitarrista—noto per la sua militanza negli Ex—si produceva in sonorità dense e avvolgenti, che costruivano uno sfondo trascendente per il lavoro espressivo della compagna. A chi scrive è servito un po' di tempo per abituarsi al contesto sonoro e all'emissione "sporca" e un po' monotona della Abdelnour, ma una volta entratovi dentro l'effetto è stato molto positivo, a momenti entusiasmante, specie quando l'interazione tra le due sonorità, per molti aspetti antipodiche, ne faceva brillare la complementarità. Anche in questo caso, un concerto non facile né immediato, ma decisamente interessante e originale, a concludere una giornata davvero brillante e interessantissima.
Il venerdì era il giorno degli workshop, momento centrale del festival che Kaučič, attivissimo e apprezzato didatta, ha cura di organizzare fin dalla prima edizione, per ampliare la cultura dell'improvvisazione e permettere ai propri allievi, ma anche a chiunque voglia avvicinarsi a quest'arte (tant'è che da qualche anno anche chi scrive vi partecipa attivamente), di fare esperienze con musicisti di altissimo livello. Quest'anno ne erano in programma ben due, con altrettanti artisti presenti in cartellone: la mattina uno più breve, dedicato alla voce, condotto da Iva Bittova; il pomeriggio quello più ampio, proseguito anche il giorno successivo, che preparava il concerto conclusivo della rassegna, condotto da Frode Gjerstad.
La cantante e violinista ceca ha lavorato con un gruppo di una dozzina di persone assai diverse per preparazione musicale e per strumento (erano presenti due soli cantanti), costruendo con grande leggerezza una relazione di gruppo attraverso prima un dialogo con ciascuno dei partecipanti, poi la narrazione di alcuni aspetti, anche molto personali, della propria esperienza artistica, tra i quali merita di menzionare l'importanza da lei data alla comunicazione emozionale, attraverso il canto anche non idiomatico, di esperienze di vita, e l'attenzione che dà al significato comunicativo di ciascuna delle diverse espressioni fonematiche. Di seguito, Bittova ha mostrato una sua breve performance improvvisativa, costruita in modo da illustrare chiaramente la varietà del materiale, le cesure, le transizioni, quasi a porsi da esempio per il lavoro che ha poi richiesto agli altri, che ha diviso in due parti: nella prima, posti i partecipanti in circolo, li ha accompagnati in una serie di improvvisazioni vocali di gruppo, sulla reiterazione delle quali ciascuno, a turno, doveva effettuare una propria improvvisazione individuale; nella seconda, invece, si è avvalsa degli strumenti di alcuni dei partecipanti (clarinetto, flauto e tamburello) per far improvvisare tutti in solo, a turno e accompagnati da un singolo strumento, iniziando anche in questo caso con una sua esemplare improvvisazione accanto al clarinetto. La conclusione, assai bella, festosa e coinvolgente, è stata un'improvvisazione collettiva, costruita attraverso il progressivo ingresso di tutti i partecipanti. Tre ore di lavoro, informale e molto caloroso, che ha fornito ai partecipanti piccoli ma interessantissimi elementi su come impiegare la voce e costruire con essa una performance.
Dopo il pomeriggio di lavoro con Gjerstad, del quale parleremo più avanti, i concerti sono iniziati alle 20,00 con il solo del batterista francese Toma Gouband, collaboratore di vari importanti improvvisatori tra cui Evan Parker, presentatosi con un set definito "litophone": una serie di sassi di vari dimensioni che, posti sulla cassa e/o sul piatto, l'artista sfregava e percuoteva con movimenti piuttosto scenografici, dando vita a un complesso affresco di suoni e a uno spettacolo indubbiamente suggestivo. Verso la metà della performance, inoltre, Gouband ha a lungo fatto uso di un folto mazzo di fronde d'albero, con le quali operava su cassa e piatti, da un lato ottenendo suoni decisamente atipici, dall'altro diffondendo in tutta la sala una marcata fragranza erbacea. Complessivamente, quindi, un concerto assai singolare sia musicalmente, sia scenicamente, ma che se per il secondo aspetto è stato suggestivo per l'intera sua durata (una cinquantina di minuti), dando l'idea di una musica che nasceva e si combinava con la natura, per il primo è rimasto invece interessante solo per i primi dieci minuti, dopo i quali gli stilemi e le forme espressive si erano esaurite, lasciando spazio solo alla ripetitività e alla ridondanza. Un'idea e delle tecniche, quelle di Gouband, interessanti, dunque, ma da sfruttare entro un progetto musicale più strutturato di quello visto in quest'occasione.
Ben altra ricchezza il secondo concerto della giornata, uno dei migliori della rassegna, che vedeva di scena il contrabbassista italiano da anni residente a Berlino Antonio Borghini e l'altosassofonista francese Pierre Borel. I due si conoscono molto bene, in quanto suonano assieme in molteplici progetti allargati, ma raramente si esibiscono in duo; tecnicamente entrambi straordinari, hanno presentato un set variopinto sia per scelte musicali, sia per forme espressive, che attingeva alla tradizione europea dell'improvvisazione musical-teatrale e che, per certi aspetti, richiamava alla mente il Clusone Trio: si alternavano infatti improvvisazioni piuttosto libere e articolate a temini e citazioni che venivano variati e finanche storpiati con forte ironia, il tutto cambiando continuamente la posizione sul palco —Borel a suonato persino seduto o steso a terra e, alla conclusione, i due si sono inseguiti in platea, salendo fino in galleria —senza con ciò mai abbassare il livello della musica. Che complessivamente è stata bellissima, oltre che estremamente stimolante e costantemente sorprendente. Che volere di più?
La conclusione era affidata proprio a Iva Bittova, per un concerto in solitudine nel quale si avvaleva anche delle proprie qualità di violinista, ma che si incentrava sulla voce. La cantante vi ha mostrato enormi doti sceniche e interpretative, costruendo un vero e proprio "spettacolo" attraverso l'alternanza di canzoni popolari —non sempre cantate e in alcuni casi solo vocalizzate —e improvvisazioni effettuate con le più diverse tecniche vocali—oltre alle tradizionali emissioni e i salti di ottave, anche suoni gutturali, schiocchi, sovracuti e quant'altro —, interpretando le diverse situazioni musicali con il movimento del corpo e talvolta cercando sonorità diverse cantando rivolta agli angoli del palco. Interessante il fatto che le parti più drammatiche, con emissioni abrasive della voce, siano state perlopiù affrontate senza il violino, che invece accompagnava i momenti più narrativi e delicati. Una performance elaboratissima, di grande maestria, che qualcuno ha trovato un po' ridondante —le forme espressive in effetti si ripresentavano di quando in quando —, altri un po' troppo tendente al melodismo, ma che per chi scrive e per i più è parsa soprattutto di straordinaria suggestione, oltre che di qualità tecnica e musicale fuori del comune.
La giornata conclusiva, sabato 14, s'è aperta a metà pomeriggio con un doppio concerto dedicato all'incontro della musica con la poesia, di scena due coppie di pianisti e poeti: una italiana, formata da Giorgio Pacorig e Cristina Micelli, l'altra slovena, con Ingrid Macus e Iztok Osojnik. Qui tralasceremo ogni commento relativo alla parte poetica (nel secondo caso anche per l'incomprensibilità della lingua), limitandoci all'aspetto musicale e a quello performativo complessivo. Che in entrambi i casi è stato positivo, perfino ottimo nel caso della coppia italiana. Pacorig, infatti, è stato eccezionale al piano, operandovi in modo perlopiù libero, atonale e poliritmico, variando tempi e intensità così da aprire opportunamente gli spazi per la recitazione della sua partner, che comunque veniva quasi sempre accompagnata, e fornendole a momenti persino delle cadenze ritmiche che ne favorissero la musicalità espressiva. In tal modo la musica ha potuto eccellere entro un contesto interattivo più che buono. Un po' diverso il caso della coppia slovena, che è parsa meno organica, separando maggiormente la musica dalla recitazione con quest'ultima un po' più lunga e monotona. La Macus, tuttavia, ha offerto un pianismo molto raffinato, di estrazione classico-contemporanea e ricco di chiaroscuri, che ha comunque tenuto alto il livello complessivo della performance.
È stata poi la volta del concerto di Frode Gjerstad, che si è esibito assieme al padrone di casa, Zlatko Kaučič, in un set breve e molto "europeo": il primo ha mostrato un fraseggio frammentato, nervoso e perlopiù irruente, nella tradizione del free continentale e nella lezione di Brötzman, ancorché mai eccessivo, brillando in particolare al clarinetto; il batterista, come suo solito, ha dialogato alla pari, ma ha anche dettato cambi di scena, rallentando e accellerando tempi e dinamiche, così da sfaccettare ulteriormente il discorso complessivo della performance. Un concerto a suo modo classico e un'improvvisazione espressiva ed elegante.
Ha viceversa destato non poche perplessità —e perciò piuttosto deluso —l'atteso concerto del duo di archi del violinista ungherese Szilard Mezei e del contrabbassista sloveno Jošt Drašler. Due eccellenti musicisti che, però, in questo caso hanno messo in scena una musica tanto frammentaria da apparir confusa e finanche priva di legame reciproco, oltretutto marcatamente cerebrale e perciò incapace di produrre una significativa comunicazione emotiva. A sorpresa, uno dei concerti meno significativi della rassegna.
La conclusione della quale, come da tradizione, è spettata all'orchestra del laboratorio, che aveva lavorato per due pomeriggi sotto la guida di Gjerstad. L'artista norvegese aveva prima spiegato la sua idea di improvvisazione, anche in riferimento ad alcune delle sue molte esperienze con musicisti di alto livello, facendo poi svolgere ai partecipanti vari di esercizi, perlopiù mirati a sviluppare un'indipendenza ritmica atta a costituire più gruppi interni all'orchestra reciprocamente autonomi. Ciò è tornato utile anche nella struttura utilizzata poi per il concerto, sebbene questa non prevedesse la divisione in gruppi dei dodici elementi dell'orchestra (voce, pianoforte, melodica, flauto, tuba, due sax soprani, tamburello e tre batterie, oltre il sax contralto di Gjerstad): l'esordio è stato infatti collettivo —prima con libere note lunghe ripetute, poi con altrettanto libere note brevi —mentre il prosieguo prevedeva improvvisazioni individuali turnate, che gli altri accompagnavano mimeticamente, a formare la parte centrale del concerto, piuttosto vivace e colorata. L'ingresso di un riff variato e reiterato faceva poi da cesura per l'ingresso in uno scenario inizialmente più ordinato e ritmicamente coinvolgente, in seguito anch'esso caratterizzato da assoli individuali, a chiamata di Gjerstad, in una sorta di conduzione. Il ritorno del riff, stavolta ripetuto un numero minore di volte, conduceva all'improvviso finale a effetto del concerto, durato complessivamente poco meno di quaranta minuti e —per quanto parso a chi scrive, che si trovava sul palco —apprezzato dal pubblico presente.
Anche quest'anno, quindi, il BCMF si è confermato una incomparabile vetrina per le più innovative proposte della musica improvvisata, ma —grazie alle sue modalità organizzative, evolutesi da quando la rassegna si è spostata a Medana —anche un'incantevole occasione di incontro, del pubblico con gli artisti e di questi tra di loro. Il festival si svolge infatti in una piccola sala, il cui foyer si presta all'esposizione dei dischi dei musicisti in programma, alla quale è affiancato un cortile recintato —ove quest'anno si è aggiunto un gazebo-bar quanto mai opportuno —nel quale il pubblico si ritrova durante le pause, mentre un bel gruppo di giovani musicisti, perlopiù facenti capo alla scuola di Nova Gorica ove insegna Kaučič, si prende cura degli ospiti, effettuando anche un servizio mensa con modalità antiche e ormai perse nella memoria di chi ha qualche anno di troppo. Una piccola gemma, quindi, dal punto di vista sia artistico —gran parte di quel che si può ascoltare qui sarà ben difficile incontrarlo nei "tradizionali" festival, quantomeno in Italia —, sia culturale —dove trovare una simile fusione di musica, poesia, arte figurativa e anche impegno politico, che traspariva da molte delle comunicazioni dal palco e dalle poesie? —, sia infine relazionale —appunto grazie allo spirito comunitario con cui è gestito e organizzato il festival, che si trasmette a tutti coloro che vi prendono parte. Una gemma che infatti ha anche quest'anno avuto un buon successo di pubblico, nonostante il maltempo che, specie il primo giorno, ha flagellato la zona, e che meriterebbe di essere molto imitata in forme e contenuti anche altrove. Ne va del futuro della musica e anche del tessuto sociale, entrambi sempre più in sofferenza nell'era del mercantilismo e delle relazioni via social network.
Tags
Live Review
Neri Pollastri
Slovenia
zlatko kaucic
Peter Brötzman
Heather Leigh
Kaja Draksler
Szymon Gasiorek
Bostjan Simon
Luigi Vitale
Alfonso Munoz
Christine Abdelnour
Andy Moor
Iva Bittova
frode gjerstad
Toma Gouband
evan parker
Antonio Borghini
Pierre Borel
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.