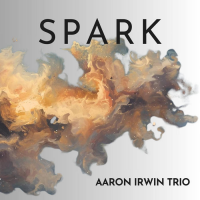Home » Articoli » Live Review » XV Brda Contemporary Music Festival
XV Brda Contemporary Music Festival

Courtesy Ziga Koritnik
Brda Contemporary Music Festival
Medana, Slovenia
11-13.9.2025
Come ci diceva nell'intervista che ci ha rilasciato poco tempo fa il suo ideatore e direttore artistico Zlatko Kaućić, non era scontato che un festival piccolo, nato con pochissimi fondi e interamente dedicato all'improvvisazione radicale riuscisse ad arrivare alla quindicesima edizione, un traguardo piuttosto lusinghiero tagliato felicemente quest'anno dal Brda Contemporary Music Festival, con un programma come al solito stimolante e vario, che affiancava giovani musicisti e maestri dell'improvvisazione europea, a due dei quali erano assegnati altrettanti workshops gratuiti e aperti a tutti —uno strumentale, guidato dal clarinettista e sassofonista Michael Moore, e uno vocale, condotto dalla tedesca Ute Wassermann.
L'apertura della rassegna, alle 19,00 di giovedì 11 settembre, è spettata al duo del clarinettista basso sloveno Enej Gala e della percussionista giapponese Moe Yoshida, che hanno dato vita a un intimo dialogo nel suggestivo sottosuolo della Casa Commemorativa di Gradnik e Zorzut, cosparsa di oggetti artistici. Si è poi passati nella sede del festival, la ex sala cinematografica di Medana, ove il primo a esibirsi è stato il Soča trio, vale a dire Daniele D'Agaro a sax tenore e clarinetto, Giovanni Maier al contrabbasso e Gal Furlan alla batteria, che in questo caso prendeva il posto di Kaučič dando alla musica una direzione significativamente diversa da quella ascoltata in alcuni dischi registrati in passato dalla formazione. Il batterista s'è infatti posto al servizio dei due italiani, sostenendone le invenzioni e arricchendone i timbri con ascolto e leggerezza, ma senza assumere quasi mai un ruolo paritetico, laddove invece D'Agaro —memore delle sue esperienze in terra olandese —portava avanti un discorso impetuoso e spumeggiante al tenore, più spigoloso e ironico al clarinetto, sospinto dal robusto suono del contrabbasso dell'antico compagno di strada Maier, che si è preso più volte la scena con sontuosi assoli dei suoi, spesso usando anche l'archetto.
Ha poi fatto seguito una formazione un po' atipica per il festival, il Music Lab Quartet di Igor Bezget, cinquantasettenne chitarrista di Maribor che ha proposto una musica più strutturata e composta rispetto alla libera improvvisazione che costituisce la cifra della rassegna. In parte debitrice alla tradizione rock, la musica ruotava principalmente attorno alle corde del leader, il quale —sostenuto dal contrabbasso di Jošt Drašler (che sostituiva il previsto Zsofi Klacmann) e dalla batteria di Aleš Zorec—produceva riff brevi e reiterati, moderatamente distorti, in equilibrio tra tensione dinamica e spirito narrativo, quest'ultimo ampliato dagli interventi del trombettista Filip Dihpol. Un episodio appunto un po' diverso, ma certo anche lontano dal mainstream e che nel contesto, comunque, non sfigurava.
La serata si è infine conclusa con il Frika Trio, composto da tre ormai affermati allievi di Kaučič: Anton Lorenzutti alla chitarra, all'elettronica e ad altri oggetti, di nuovo Drašler, stavolta al basso elettrico, e Marek Fakuč alla batteria e anch'egli all'elettronica. Formazione decisamente singolare, che ha aperto con un lungo brano altamente suggestivo: introdotto da Lorenzutti al kazoo e alla voce, si è poi sviluppato attraverso scenari onirici di impianto elettronico, distorsioni del basso, fraseggi della chitarra, con ispirazioni tratte da molteplici tradizioni musicali e momenti davvero emozionanti. Un po' più classiche le improvvisazioni successive, sempre comunque molto vitali e imprevedibili negli sviluppi, per un concerto godibile, interessante e tutt'altro che ordinario nel modo in cui veniva gestita l'elettronica.
La seconda giornata, venerdì 11, s'è aperta presto per i partecipanti ai due seminari, che nel primissimo pomeriggio hanno iniziato il loro lavoro con Moore nella sala cinematografica e con la Wassermann in quella della Casa Commemorativa di Gradnik e Zorzut. I concerti sono invece iniziati alle 19,00 con il solo della sassofonista Lotte Anker, che ha alternato soprano e contralto. Al primo, che è parso oggi il suo strumento principale, l'artista danese si è prodotta in una meditazione spigolosa, con pochissime frasi e molti effetti speciali —schiocchi, armonici, soffi, sovracuti, sonorità sporche e stridenti —tecnicamente pregevoli, ma anche piuttosto ridondanti e non sempre chiaramente funzionali al quadro musicale; con il contralto è invece stata meno "estrema," sviluppando un percorso leggermente più rilassato e con qualche fraseggio relativamente tradizionale. Un set complessivamente ostico, ancorché stimolante, che ha diviso il pubblico tra chi la riteneva emblema di una libertà improvvisativa senza compromessi e chi, invece, ne trovava carente la poetica.
A seguire è salita sul palco la Wassermann, che ha sfoggiato il campionario di stilemi messi a punto nei suoi quarant'anni di carriera —vocalismi ora gutturali, ora acutissimi, ma anche gorgheggi, eco palatali, fischi nasali, vibrazioni, oltre a continue variazioni dinamiche —ai quali si affiancavano "giochi" con molteplici "oggetti" —piattini e piccoli tamburelli sui quali far risuonare le emissioni vocali, oggetti con cui produrre ritmi, richiami per uccelli —così da poter realizzare un discorso drammaturgico complesso, capace di dar vita a uno spettacolo che andava ben oltre il semplice solo. Una performance nella quale c'era anche molta teatralità, ma che non smarriva mai la direzione musicale, con invenzioni continue, cambi di scena, artifici tecnici sorprendenti. Set entusiasmante, che ha incuriosito riguardo agli esiti del workshop che l'artista stava conducendo e che si sarebbe concluso il giorno dopo con il concerto.
Il terzo set della serata vedeva di nuovo in scena la Anker, stavolta però in duo con il conduttore dell'altro workshop, Michael Moore, impegnato al sax contralto e al clarinetto. Un concerto molto interessante, anche alla luce del precedente solo della sassofonista, perché la presenza del ben più duttile compagno ha spinto la musica in direzioni diverse, da un lato mostrando il contrasto dei due approcci, dall'altro permettendo la valorizzazione delle caratteristiche della Anker in contesti meno estremi. Se infatti la danese ha tendenzialmente riproposto la sua musica dura e spezzettata, l'americano —e olandese d'adozione —l'ha ora assecondata, dialogando però con stilemi meno estremi e una maggiore "dolcezza," ora contraddetta, proponendo fraseggi morbidi e scenari lirici, con ciò costringendola a uscire dalla sua comfort zone e a interagire su un piano sempre improvvisato, ma di formato diverso. Il risultato —esplorato anche cambiando a ogni brano la coppia di strumenti —è stata una musica più sfumata e godibile, con momenti persino teatralmente umoristici, che ha fuso virtuosamente le diverse personalità artistiche dei due protagonisti.
Ha concluso la serata un concerto tra i più belli dell'intera rassegna, quello del trio composto dal violinista Emanuele Parrini, dal contrabbassista Giovanni Maier e dal batterista Urban Kušar. La formazione ha sfoggiato un'intesa straordinaria, probabilmente frutto dell'antico e consolidato rapporto artistico esistente tra i due italiani, ma che si è avvalsa anche della sensibilità dello sloveno, che suonava con loro per la prima volta ma che si è integrato perfettamente, prendendosi responsabilità e fornendo pariteticamente il suo apporto tanto di colori, quanto di aperture su scenari diversi. La parte del leone l'ha comunque fatta Parrini, apparso particolarmente emozionato per la sua prima partecipazione al BCMF e, forse anche per questo, in forma smagliante: l'artista toscano ha alternato passaggi nervosi e dinamicamente incisivi ad altri più lirici, dialogando con i compagni, ma prendendosi lunghi ed entusiasmanti spazi di assolo —alcuni dei quali straordinariamente coinvolgenti e commoventi. Maier, dal canto suo, non gli è stato da meno, mostrando pienamente il suo magistero al contrabbasso —anche a dispetto di un piccolo incidente a un dito, capitatogli a metà concerto, ma che visibilmente non lo ha penalizzato. Incroci di suoni, dialoghi, imprevedibilità che hanno affascinato il pubblico e concluso nel modo migliore la serata.
L'ultima giornata, quella del sabato, ha visto nel primo pomeriggio il proseguimento dei due workshops e, dalle 17,00, i primi due set, dedicati all'incontro tra musica e poesia. Il primo —denominato Zlato Jajce (Uovo d'oro) —vedeva in scena interpreti sloveni, la pianista Mojca Zupančič e la poetessa Petra Koršič, che recitava un suo poemetto (del quale erano state distribuite le traduzioni). lasciando da parte ogni considerazione sull'aspetto letterario, musicalmente la cosa avrebbe anche funzionato —grazie sia all'abilità e alla varietà stilematica della pianista, sia a una certa attitudine teatrale della poetessa —se non fosse stato per la lunghezza decisamente eccessiva, che a un certo punto ha appesantito l'ascolto. Il secondo aveva invece per protagonisti due italiani, il trombettista Sandro Carta e la poetessa Patriza Dughero; qui, anche omettendo ogni commento sull'aspetto poetico, musicalmente le cose funzionavano assai meno bene, perché gli stilemi della tromba e ancor più l'uso dell'elettronica non erano particolarmente originali o emozionanti, mentre la recitazione era piuttosto piatta e in pochi passaggi si fondeva armonicamente con la musica.
Alle 20,00 il programma principale prevedeva il set solitario della vocalist e —soprattutto —performer elettronica Maja Osojnik & Band, quarantanovenne slovena che vive e lavora a Vienna, pluripremiata per il suo lungo lavoro di ricerca nel campo della musica elettroacustica. Dietro ai due metri di un'impressionante consolle di fili, tasti e cursori, sulla quale spiccava anche un laptop, la Osojnik ha iniziato con un interessante lavoro alla voce, distorta in molti modi sia fisici, sia elettronici, ma si è poi lasciata andare a un lunghissimo montaggio di loop e rumori parassiti, piuttosto monotono ed entro il quale era difficile rintracciare un chiaro discorso drammaturgico. Non sono tuttavia mancati né artifici interessanti, né momenti coinvolgenti, ma alla fine la sensazione dominate era quella del classico "catalogo": l'esposizione un po' raccogliticcia di molte delle possibilità espressive disponibili all'artista, alla quale mancava tuttavia una significativa identità poetica.
Totalmente diverso il concerto successivo, che vedeva in scena il trio composto dal sassofonista inglese John Butcher, dal pianista catalano Agusti Fernandez e dal "padrone di casa" Zlatko Kaučič. Il pianista è frequente collaboratore di entrambi gli altri musicisti e ha fatto valere la sua intesa con loro, favorendo la perfetta interazione del trio. Il quale è risultato di fatto imperniato sulle ance dell'inglese, che ha alternato soprano e tenore, musicista dalle straordinarie capacità tecniche—notevoli, specie al soprano, l'uso della respirazione circolare e degli armonici, i suoni soffiati e le ribattute con le chiavi —, dall'amplissimo vocabolario stilematico e con una singolarissima identità artistica. Tendenzialmente molto presente e con modesta disponibilità per il silenzio, Butcher ha sì riempito ogni spazio residuo, ma ne ha tuttavia lasciato a sufficienza per i compagni: Fernandez —artista superlativo del quale abbiamo recentemente recensito il cofanetto celebrativo dei settant'anni, Aesthetic of Prisms, e che ascoltavamo per la prima volta dal vivo —ha alternato interventi sulle corde, passaggi percussivi dinamicamente ed emotivamente intensi, momenti di rarefazione, variando gli scenari impostati da Butcher; Kaučič, confermando la sua sensibilità e la capacità di rinnovare la musica in ogni momento, ha da un lato assecondato le proposte dei compagni, arricchendole di timbri e accenti, dall'altro ha come suo costume stoppato certi sviluppi proponendo subito dopo improvvise sterzate verso direzioni diverse, rendendo oltremodo imprevedibile il decorso dell'improvvisazione. Spettacolo incantevole, che ha avuto nel secondo, lungo brano il suo apice e che è risultato uno dei migliore della rassegna.
Quest'ultima è poi andata a concludersi, come ogni anno, con i concerti degli workshops, che tuttavia stavolta erano due, uno dei quali come vedremo anche un po' particolare.
Il concerto del workshop vocale si è tenuto nella sala sotterranea della Casa Commemorativa di Gradnik e Zorzut, penalizzando un po' il pubblico (erano pochi i posti a sedere) ma valorizzando senz'altro lo spettacolo: i sei vocalist "in erba" (in realtà c'erano un paio di esperti, tra i quali anche la compagna di Michael Moore) si sono schierati sul fondo della sala con al centro la Wassermann, che ha interagito con loro, e hanno dato vita a una performance di circa un quarto d'ora, molto teatrale e incentrata su una sorta di dialogo conflittuale turnato: a coppie, che talvolta si ampliavano a trii o quartetti, i vocalist battibeccavano modulando la voce, spingendosi ora verso toni acuti, ora verso borborigmi, oppure sbottando in scoppiettii vocali, passando poi la scena ad altri, talvolta congiungendosi in un corale complessivo per poi disperdersi e riprendere a coppie. Scenograficamente, grazie anche alla location, lo spettacolo è stato convincente; poteva essere forse usato un maggior numero di stilemi (che, a quando ci hanno detto alcuni dei partecipanti, erano stati sperimentati durante il workshop), ma forse la Wassermann ha ritenuto che il lavoro svolto non fosse sufficiente a farli usare con sicurezza. Certo i partecipanti sono sembrati entusiasti dell'esperienza e anche il pubblico ha gradito molto.
Il concerto del secondo workshop era diviso in due parti, anche perché riuniva due ben diversi gruppi di lavoro: il primo includeva i sei musicisti (dei quali chi scrive faceva parte) che avevano lavorato con Moore i due pomeriggi precedenti, soffermandosi su molteplici possibilità di sviluppare un'improvvisazione collettiva, sulla postura che ciascun musicista deve assumente di fronte all'improvvisazione e provando assieme alcune di esse in vista del concerto, che comunque non era stato "montato" con precisione; l'altro era invece una compagine orchestrale giovanile, la Baby Big Band, che con lo stesso Moore aveva precedetemene tenuto un laboratorio di due giorni a Sedegliano (UD), grazie all'Associazione Musicale e Culturale Armonie APS e alla collaborazione di Musica in Villa. Moore ha deciso di riunire i due gruppi, facendo introdurre il concerto dai sei improvvisatori, con i quali ha lavorato su uno schema-guida semplice e molto aperto: caotica improvvisazione collettiva seguita da duetti e da una nuova improvvisazione più dialogica, con chiusura su un tema di Misha Mengelberg. Proprio il tema conclusivo costituiva la congiunzione con il più lungo concerto della Big Band, che si è articolato su una serie di brani di varia provenienza —Ellington, lo stesso Moore, Sean Bergin con il suo celebre "Lavoro" —nel quale trovavano spazio improvvisazioni dei singoli. Lo stile non era esattamente quello delle classiche Big Band, ma rimandava almeno in parte alla tradizione olandese, di cui Moore è stato ed è tuttora parte attiva. Un po' a latere rispetto alla cifra del festival, e tuttavia convincente. Commovente la dichiarazione di un portavoce dell'orchestra, che ringraziava Moore e l'organizzazione per l'opportunità di cimentarsi in un contesto comunque piuttosto diverso da quello in cui ordinariamente opera l'organico.
Non meno commovente, al termine, la passerella di ringraziamento per i giovani allievi di Kaučič, "manovali" volontari di tutta l'operazione, tecnicamente (oltre che artisticamente) perfettamente riuscita, con servizi di ristoro autogestiti per musicisti e ospiti, spazi a disposizione per conversazioni tra un concerto e l'altro, vendita di dischi e gadget —insomma un festival "alla vecchia" di cui ormai si sente molto la mancanza e che è sempre un immenso piacere rivivere. Grazie a tutti e lunga vita al BCMF!
Tags
Live Review
zlatko kaucic
Neri Pollastri
Slovenia
Ljubljana
nell'intervista che ci ha rilasciato
Michael Moore
Ute Wassermann
Enej Gala
Moe Yoshida
Daniele D'Agaro
Giovanni Maier
Gal Furlan
Igor Bezget
Jošt Drašler
Zsofi Klacmann
Aleš Zorec
Filip Dihpol
Anton Lorenzutti
Marek Fakuč
Lotte Anker
Emanuele Parrini
Urban Kušar
Mojca Zupančič
Sandro Carta
Patriza Dughero
Maja Osojnik
John Butcher
Agusti Fernandez
Aesthetic of Prisms
Misha Mengelberg
Sean Bergin
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.