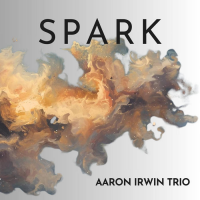Home » Articoli » Interview » Anaïs Drago, un violino solo che non vuole essere solista
Anaïs Drago, un violino solo che non vuole essere solista

Courtesy Max Monticone
Per sviluppare un linguaggio e un’estetica personali è necessaria una pratica molto lunga e, per quanto mi riguarda, questo lavoro di sviluppo l’ho fatto in solo
All About Jazz: Inizierei dal concerto di stasera, una performance per violino solo decisamente particolare, costruita su una molteplicità di cose diverse, ma soprattutto, come ben si percepiva, con la volontà di raccontare qualcosa. Introducendo la musica hai accennato al fatto di essere partita da un racconto di Friedrich Dürrenmatt, Il minotauro; puoi dirci come l'hai tradotto in musica?
Anaïs Drago: Sono partita dalla lettura, che mi ha fortemente colpita, poi man mano ho lavorato sulle figure e sulle parole chiave del mito e della sua ambientazione. Quindi in primo luogo il Minotauro e la sua deformità, che in fondo è insita nell'essere umano; poi l'imprigionamento, rappresentato come qualcosa di costretto che urla sommessamente, che mi ha spinto verso un'ambientazione sonora a tratti eterea, a tratti estremamente violenta, che però è in qualche modo anche soffocata —e questo cerco di descriverlo nella terza e quarta stanza, con un andamento che vuol significare l'urlo disperato di chi però rimane segregato negli abissi; e ancora il concetto di labirinto, luogo in cui ci si perde, dove non si riesce più a ritrovarsi, nel quale si ritorna al punto di partenza senza mai avanzare, ma anche nel quale tutto questo andare e tornare, questa circolarità, a un certo punto invece inizia a salire, come fosse una spirale, in modo da poter attingere a una via d'uscita. E infine proprio quella via d'uscita, da ricercare, che può essere intesa in senso orizzontale oppure, come ho voluto provare a raccontare, in quello verticale, cioè verso l'alto, e questo ho cercato di tradurlo con varie libertà prese qua e là, ma soprattutto con l'utilizzo di un registro da molto grave —quando si è dentro il labirinto —ad acuto —nel momento in cui si riesce a uscirne verso l'alto, ossia verso il cielo.
In altre parole, ho immaginato un labirinto sì chiuso, ma solo lateralmente, mentre è aperto verso l'alto —infatti la maggioranza dei labirinti sono a cielo aperto. Inoltre, un altro aspetto chiave che ho utilizzato come elemento musicale è quello dello specchio, del riflesso: ci sono molte cellule che utilizzo in maniera seriale, riversandole, e uso molto la scala esatonale, specie nella prima parte.
Mi sono anche appigliata a un'altra storia, che fa sempre parte del mondo antico: quella narrata da Aristofane nella commedia Gli uccelli. In essa dei cittadini, stufi del degrado sociale, decidono di fondare un'altra città a metà tra la Terra e il Cielo, dedicata al mondo degli uccelli, e la chiamano Nubicuculìa, per provare a entrare in quell'altro mondo. La fase di transizione, cioè la parte in cui uso anche la voce, è in realtà un pezzo del compositore polacco Zbigniew Seifert, che avevo dovuto preparare per partecipare alla Seifert Competition di Cracovia: erano richieste due sue composizioni e quella fu una delle mie scelte. La melodia quindi non è mia, anche se l'arrangiamento è totalmente diverso dall'originale, ma l'ho voluta tenere anzitutto perché mi ci sono affezionata e l'ho trovata particolarmente nelle mie corde, in secondo luogo perché il suo stesso titolo, Stillness, mi faceva gioco nella narrazione per descrivere un momento di stasi, in cui non succede nulla: sono infatti due accordi che si ripetono —mi bemolle/fa -e quindi danno il senso di stasi che mi serviva come transizione di questo movimento. L'ultima cosa, la voce: visto che è esclusiva dell'uomo, vorrebbe significare l'elemento umano e perciò è assente nella prima parte più "mostruosa" ed emerge successivamente, nella seconda metà del concerto.
AAJ: Chiaro e interessante. Quanto c'è di scritto, o comunque di predefinito, e quanto d'improvvisazione?
AD: È una domanda difficile, nel senso che quando lo suono ho talmente tanto in testa che risponderei che è molto scritto; solo che, al contempo, quello che ho in testa non è affatto scritto e, in più, quasi tutte le idee che in qualche modo si sono fissate sono frutto di un precedente momento improvvisativo. Come dicevo presentando il concerto, da quando è nato il progetto, nel 2021, a oggi, la musica si è evoluta; ma, sia chiaro, ciò non è accaduto mentre ero in camera a studiare, bensì durante tutti i concerti che ho fatto in questo lasso di tempo. Mi ricordo per esempio che la frase su cui mi trattengo in tutta la prima parte mi era venuta in mente prima di un concerto che ho fatto nel 2022 in Calabria; in quell'occasione era una semplice frase che quella sera ho suonato due o tre volte, prima di procedere con il resto; poi, man mano, nei concerti successivi ho iniziato a svilupparla ed è diventata una parte stabile del concerto. Insomma, nella performance c'è l'idea del canovaccio da sviluppare; poi ovviamente alcune idee —quelle che mi sembrano convincenti, o in cui mi ritrovo di più —si fissano e perciò, in qualche modo, diventano materiale scritto. Però restano delle cellule, o delle idee timbriche: alla fin fine, quello che è molto definito è la struttura, oltre agli elementi di effettistica, che sono fissi per ragioni logistiche, cioè perché non ho un computer con cui smanettare dal vivo e devo prepararli in anticipo, perciò su di loro non ho grandi margini di improvvisazione.
AAJ: Hai sempre lavorato molto sul solo. Quanto conta il lavoro sul violino nello sviluppo delle composizioni per formazioni allargate?
AD: Il lavoro in solo è stato per me anzitutto una presa di coscienza di quella che è la mia espressività prettamente strumentale, quindi se non avessi lavorato così tanto sul solo molto probabilmente alcune cose non mi sarebbero venute in mente neppure in un contesto di ensemble —nel quale comunque sei più focalizzato sugli altri e sull'insieme. Come ben sai, per sviluppare un linguaggio e un'estetica personali è necessaria una pratica molto lunga e, per quanto mi riguarda, questo lavoro di sviluppo l'ho fatto in solo. Infatti, dopo aver esordito nel mondo jazz con un primo lavoro in settetto, Anais Drago & The Jellyfish anche per cause di forza maggiore —ovvero la pandemia —mi sono trovata da sola; e con il solo ci sono rimasta a lungo, prima di poter avere di nuovo un altro progetto di gruppo, cioè il trio che hai sentito al PARC.
AAJ: E così siamo arrivati al trio, del quale è appena uscito il disco, Relevé. Dicevi un attimo fa che nelle formazioni allargate si è più attenti alle altre componenti, tant'è infatti che nel trio non sei neanche la voce dominante, ruolo ricoperto invece da Federico Calcagno: com'è che sei arrivata a quel trio? Oltretutto anche abbastanza particolare come formazione strumentale, composto qual è da violino, clarinetto basso e batteria.
AD: Anzitutto ho fatto tesoro dell'esperienza precedente al solo, cioè quella con il settetto. Quell'esperienza fa sì che la prima cosa di cui mi interesso ora, nel concepire una formazione allargata, sia capire in che tipo di ensemble mi trovo, non tanto in base a quali strumenti siano più adatti per dialogare col mio violino, bensì secondo quale tipologia di impasto sonoro mi possa permettere di sentirmi più a mio agio. È così che ho fatto questa riflessione, probabilmente molto banale e molto soggettiva, cioè non dovuta al fatto che suono il violino, bensì al fatto che io con il violino mi sento in un certo modo: in una situazione con una forte massa sonora, dovuta all'abbondanza di voci e alla presenza di strumenti anche armonici molto forti, molto presenti, io fatico a muovermi.
Magari è anche una questione d'abitudine, dovuta proprio al fatto di aver suonato quattro anni in solo: però ho dovuto tenerne conto. Così, ho assemblato un trio di questo genere —cioè una formazione in primo luogo ridotta e in secondo luogo priva di uno strumento armonico —nella convinzione che avrei avuto maggiori possibilità espressive —una convinzione confermata poi dai fatti. Inoltre, avevo voglia di mettere a servizio della musica tutta una serie di skills che avevo sviluppato e su cui mi piace lavorare, utilizzando il violino come uno strumento non prettamente melodico, ma più ritmico-armonico. Che magari fa un po' ridere, perché comunque alla fine resta un violino; però, nel momento in cui ci sono un basso, una chitarra e un pianoforte, se io mi metto a fare gli accordi divento completamente superflua, mentre se non c'è nessun altro che li fa, allora quello che faccio, anche se piccolo, assume un significato. In altre parole, volevo sviluppare un ruolo del violino tale da farlo diventare uno strumento di sezione e non solo solistico; è per questo che sono molto contenta di aver lasciato quel ruolo a Federico, che con i suoi clarinetti lo svolge benissimo.
AAJ: Nel trio c'è poi anche un singolare impasto timbrico che ne rende l'ascolto particolarmente interessante, perché tra clarinetto basso e violino il contrasto è decisamente virtuoso, mentre anche durante il concerto mi stupì il ruolo della batteria, che ha una posizione decisamente atipica. Tu come l'hai pensata?
AD: Per il discorso che ti facevo, anche legato alla masse sonore, ho dato a Max Trabucco degli input ben precisi: avere dei suoni secchi, poco risonanti. Lui ha poi meravigliosamente tradotto nella pratica queste indicazioni facendo un lavoro, secondo me veramente bello, sui piatti, sui cimbali, insomma sulla componente metallica. Mi piaceva anche l'idea di avere un sound, pur acustico, che andasse verso un concetto più elettronico, che poi è venuto fuori solo in alcuni brani, non in tutti. Secondo me il ruolo che Max alla fine ha assunto —proprio per quest'idea di abbandonare i ruoli che di solito si conferiscono agli strumenti —è molto melodico, pur restando ovviamente la colonna portante ritmica del tutto. E lo ringrazio vivamente perché fatico non poco a scrivere le parti per batteria, perciò preferisco dare indicazioni il più precise possibile!
AAJ: Ricordo in realtà che dopo il concerto era molto contento, mi disse che avevi idee molto chiare...
AD: Sì, sì, certo, le idee le avevo... ma non erano "parti"!
AAJ: Quel trio come lo collocheresti? Che musica è? Lo so che è una domanda banale, né m'interessa una risposta precisa, ma ritengo la questione sempre interessante da discutere.
AD: Infatti non so darti una risposta precisa, però posso dirti che quando sono nati il trio e il suo repertorio, io avevo voglia di tornare a un progetto decisamente diverso dal solo a cui mi stavo dedicando da tempo, che era un po' statico, meditativo, lineare: volevo qualcosa un po' più ad alta tensione, che avesse una maggiore varietà di ritmi. Diciamo che avevo voglia di ballare! O comunque di tornare a provare quelle sensazioni che avevo quando, da ragazzina, facevo parte di un gruppo folk, in cui c'era "spinta," ritmo. Certo volevo farlo in un modo diverso, senza un repertorio canonico a cui attingere, ma ho pensato a dei pezzi che andassero in quella direzione.
AAJ: Tu vieni dall'ambito classico; quando poi ti sei diretta in direzioni diverse, come hai portato con te la tradizione violinistica?
AD: Ho incontrato il jazz più o meno nel momento in cui mi sono diplomata in conservatorio, quando cioè già avevo una padronanza "accademica" dello strumento; che però in quel momento ho deciso di lasciar completamente perdere per iniziare a studiare il linguaggio jazz. Da allora, per anni, la mia attenzione si è diretta interamente a imparare quel linguaggio e quel fraseggio. Il lavoro sul suono è venuto dopo, più esattamente quando dal jazz mi è apparsa l'improvvisazione libera: è stato allora che ho smesso di pensare solo a cosa suonavo e ho iniziato a pensare anche a come lo suonavo. Lì, potremmo dire, è iniziata la seconda parte del cerchio, che mi ha portato poi a chiuderlo: sono tornata alla ricerca del controllo del suono, quindi dell'arco, e poi anche a tutta un'altra serie di aspetti tecnici, che sono molto contenta di aver riscoperto, non più però partendo da un repertorio accademico, ma attraverso l'improvvisazione e le mie stesse composizioni.
AAJ: C'è stato qualche modello, o quantomeno ispiratore, in questo processo?
AD: In senso stretto no. Ci sono stati una serie di ascolti che mi hanno aperto mondi o comunque strade da percorrere. Non ho invece mai fatto ricerche specifiche sui violinisti, né in ambito jazz, né in ambito classico. In fondo, credo di aver ascoltato più strumenti diversi che non il violino stesso. Anche questa mia necessità di connotare il violino come strumento non melodico mi viene dall'ascolto di altri strumenti, non del violino. E gli ascolti che mi hanno influenzato sono molto vari: uno per esempio è Different Trains di Steve Reich, che non ha nulla a che fare con il jazz, anche se ci sono gli archi; un altro sono i 24 preludi per pianoforte microtonale del compositore russo Ivan Wyschnegradsky, che hanno contribuito a spingermi in una direzione che già mi interessava, cioè uscire dal sistema di interazione temperata europea che ho studiato per tanti anni.
AAJ: Questo lo notavo già nel concerto, forse anche perché ho visto da poco Mat Maneri che, memore delle ricerche del padre Joe, lavora molto sulla microtonalità: soprattutto nella prima parte mi sono reso conto che ti muovevi in quella direzione.
AD: Sì, infatti, sono stilemi e forme espressive che cerco di sviluppare e poi tiro fuori nel corso delle performance. Mi piace l'effetto destabilizzante che provoca, in primis su di me.
AAJ: Hai nuovi progetti in cantiere? Tenendo presente che hai il disco del trio fresco di uscita e poi c'è il solo, che mi pare una costante.
AD: Il solo sì, resta una cosa il cui sviluppo mi impegna costantemente, mentre il trio quest'estate non ha ancora molti appuntamenti, proprio perché è appena uscito: lo presenteremo a Sile Jazz, poi altri concerti seguiranno in autunno. Comunque non mi dispiacerebbe fare una seconda registrazione, stavolta in studio, visto che questo disco è un live. Oltre ad essi, in realtà in questo ultimo anno e mezzo sono stata coinvolta in moltissime cose, assai diverse tra loro, ma che proprio per questo mi piacciono molto, perché in ognuna riesco a esprimere qualcosa di quel che sviluppo nel mio studio in solo: ho un duo con Peppe Frana, suonatore di oud, con cui stiamo scrivendo pezzi originali; poi un trio con il fisarmonicista Fausto Beccalossi e il chitarrista Luca Falomi, anche qui musica originale, più immediata e godibile; poi c'è il mitico trio omaggio a Zappa e all'irriverenza Shake your Duty, con Valentina Scheldhofen Ciardelli al contrabbasso ed il controtenore Riccardo Strano: saremo allo Zappanale il prossimo luglio! Infine c'è il trio con Barbara Casini e Barbara Piperno, basato sulla musica brasiliana nordestina e di tradizione sudamericana.
AAJ: Singolare accostamento il violino a questo genere di musica.
AD: Ancor più se consideri che Barbara, oltre a cantare, suona la chitarra e le percussioni, anch'io canto e suono le percussioni oltre al violino, e la stessa cosa fa l'altra Barbara, che è flautista. Questa composizione strumentale ha richiesto un gran lavoro di arrangiamento e aperto spazi per mettere dentro delle cose che ho sviluppato per mio conto sullo strumento. Mantenendo però anche qui una grande godibilità e mettendomi al servizio di un universo musicale e di un repertorio per me nuovi. Una cosa, quest'ultima, che peraltro vale anche nel duo con Peppe Frana, grande conoscitore della musica modale e del repertorio tradizionale del mondo arabo. Quando mi sono ritrovata davanti alla possibilità di suonare assieme a lui, l'ho avvertito che io quella musica non la conoscevo, ma mi ha risposto che non gli interessava e che, anzi, era pure meglio se non la conoscevo, perché l'obiettivo non era imitare un linguaggio ma sviluppare qualcosa di originale. In questo senso anche i miei studi sulla microtonalità li faccio indipendentemente dal linguaggio e dal patrimonio culturale mediorientale, perché mi sembrerebbe un'operazione di appropriazione culturale priva di senso. Anche se poi magari un giorno mi sveglierò col desiderio di diventare un'esperta anche di quello...
Tags
Interview
Anais Drago
Neri Pollastri
Italy
Torino
Relevé Live
Federico Calcagno
Max Trabucco
concerto a Firenze
Connetto Jazz 2025
zbigniew seifert
Steve Reich
Ivan Wyschnegradsky
Mat Maneri
Peppe Frana
Fausto Beccalossi
Luca Falomi
Valentina S. Ciardelli
Riccardo Strano
Barbara Casini
Barbara Piperno
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.