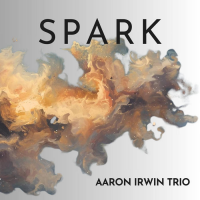Home » Articoli » Cover Stories » Una gemma Soft Machine per il quarantennale Cuneiform
Una gemma Soft Machine per il quarantennale Cuneiform

Per celebrare degnamente la ricorrenza del quarantennale non poteva quindi esserci miglior scelta che un inedito del gruppo simbolo per eccellenza dell'etichetta, quei Soft Machine di cui la Cuneiform ha documentato la storia attraverso la pubblicazione di numerosi inediti. Per l'occasione la Cuneiform offre addirittura un album quadruplo, che riporta integralmente i concerti eseguiti dalla band nelle due serate del 27 e 28 Febbraio 1971 a Høvikodden, piccolo centro norvegese vicino a Oslo, in uno spazio museale come parte di una mostra d'arte della famiglia Boyle. Le esibizioni contenute su Høvikodden 1971 furono accompagnate dalla proiezione di film di Mark Boyle, che già in altre occasioni —fino dal 1967-68—aveva accompagnato la musica dei Soft Machine con i suoi light show. I concerti furono registrati professionalmente, il che ha permesso di salvaguardare questo prezioso documento storico. La seconda delle due serate era già stata pubblicata nel 2009 da Michael King (ingegnere del suono canadese appassionato della scena di Canterbury e del British Jazz) per la sua Reel Records. La Cuneiform, invece, propone quella stessa serata usando i nastri originali rimasterizzati per un suono ottimizzato al massimo in quella che è molto probabilmente la miglior registrazione dal vivo di quella particolare incarnazione dei Soft Machine conosciuta come il quartetto classico, costituito dal tastierista Mike Ratledge, il batterista e vocalist Robert Wyatt, il bassista Hugh Hopper e il sassofonista Elton Dean.
In quel Febbraio 1971 i Soft Machine avevano già alle spalle una storia piuttosto travagliata. Nati nel 1966 per iniziativa di un gruppo di amici che avevano frequentato la stessa scuola (sia pure in anni differenti) in quel di Canterbury, erano una evoluzione di altri progetti come il Daevid Allen Trio e i Wilde Flowers, che saranno documentati su disco solo molti anni dopo. La prima formazione era un quartetto che comprendeva, oltre a Wyatt e Ratledge, Kevin Ayers al basso e Daevid Allen alla chitarra, con Hugh Hopper che faceva da road manager e contribuiva con alcune composizioni. L'anno successivo realizzano un 45 giri e alcuni demo prodotti da Giorgio Gomelsky (pubblicati solo nel 1972), e si fanno notare suonando all'UFO club di Londra insieme ai primi Pink Floyd, e facendo da gruppo spalla alla The Jimi Hendrix Experience.
Al rientro da un tour estivo di successo in Francia, all'australiano Daevid Allen viene negato l'ingresso in quanto non in possesso di un visto valido; Allen è pertanto costretto a rimanere in Francia, dove poco dopo fonderà i Gong. Il gruppo prosegue come trio, e a inizio 1968 accompagna la Jimi Hendrix Experience in un tour negli U.S.A. dove registrano il primo disco per la Probe, all'insegna di un rock psichedelico e dadaista non privo di spunti strumentali originali, ma i nastri rimangono nel cassetto per diversi mesi. Al termine di un secondo tour nordamericano massacrante in autunno il trio si scioglie, stanco e sfiduciato per la mancata pubblicazione del loro album nonostante il buon successo di pubblico. Ayers, nauseato dal business, decide di abbandonare la musica (ma in seguito ci ripenserà), Ratledge torna in Inghilterra e Wyatt rimane negli Stati Uniti dove dopo alcuni ingaggi sulla West Coast si trasferisce a New York per lavorare ad alcuni demo ai Record Plant Studios. Qui riceve una chiamata dalla casa discografica che, entusiasta dell'album, lo intende pubblicare immediatamente sul mercato americano, e vuole il gruppo per un nuovo tour promozionale e l'incisione di un secondo album previsto dal contratto. Il trio perciò si ricostituisce a inizio 1969 con Hopper al basso al posto di Ayers che non ne vuole più sapere, e incide il secondo album Volume Two negli Olympic Sound Studios londinesi con la partecipazione di Brian Hopper, fratello di Hugh, al sax. Il lavoro prosegue ancora sulla scia della psichedelia, ma aprendosi maggiormente anche al jazz.
Le ambizioni del gruppo crescono, soprattutto per il desiderio di Ratledge di avere un organico maggiore per dare sfogo alla sua vena compositiva. Dal sestetto di Keith Tippett arriva allora l'intera sezione fiati composta dal sassofonista Elton Dean, il trombettista Mark Charig e il trombonista Nick Evans, con in aggiunta il sassofonista e flautista Lyn Dobson. Il settetto ha vita breve, lasciando pochissime testimonianze registrate in studio e live, ma i due sassofonisti restano e il gruppo diventa per pochi mesi un quintetto, che a inizio 1970 fa in tempo a registrare dal vivo materiale da utilizzare nel terzo album, intitolato semplicemente Third.
Anche Dobson lascia, e prende forma il quartetto classico, che rappresenterà l'apice della creatività del gruppo nei suoi 18 mesi di vita, diventando anche la formazione più longeva nella storia dei Soft Machine. Ma all'interno del gruppo ci sono forti tensioni tra i musicisti, tutti dotati di forte personalità. L'arrivo del sassofonista ha decisamente spostato gli equilibri verso un jazz moderno, elettrico (si sta cominciando a parlare di jazz-rock anche in virtù del coevo Bitches Brew di Miles Davis, ma la musica dei Soft Machine prende le distanze da entrambi, focalizzandosi su qualcosa di completamente nuovo e diverso), tendente al free, e Wyatt comincia a sentirsi sempre maggiormente emarginato. Se nei primi due album le sue canzoni surreali si dividevano la scena equamente con le composizioni più rigorose di Ratledge, già da Third il suo spazio si riduce enormemente, con la sua composizione più famosa ("Moon in June") che occupa una delle quattro facciate che compongono il lavoro, e che progressivamente scompare anche dalla scaletta dei concerti, lasciandogli solo uno spazio ridotto per le sue improvvisazioni vocali. Il batterista partecipa all'incisione del quarto album Fourth, poi lascia il gruppo nell'estate del 1971, per dedicarsi a una carriera solistica che dovrà rivedere in seguito al tragico incidente che lo ridurrà paraplegico.
Fortunatamente, negli anni sono emerse numerose registrazioni che a integrazione della scarna discografia ufficiale dell'epoca documentano la grandezza del gruppo anche nella dimensione dal vivo, oltre all'evoluzione dei vari lineup nel tempo. Nel catalogo Cuneiform figurano una dozzina di titoli a nome dei Soft Machine, con registrazioni di qualità audio variabile che vanno dal 1967 al 1975. I concerti norvegesi arrivano dopo un anno che il gruppo si è assestato nella formazione in quartetto, ed è quindi ampiamente rodato. I concerti si svolgono generalmente in due set continui, con i temi che si succedono l'un l'altro senza interruzioni. La scaletta è uguale per le due serate, tranne che per la presenza di un bis nella seconda, ed è la stessa che sarà riproposta a Brema meno di un mese dopo in un concerto pubblicato sull'album Virtually nel 1998, e che rimarrà l'ultima testimonianza live del quartetto (a meno di una breve sessione per la BBC registrata il 1 giugno 1971).
Il materiale proviene in prevalenza da Third ("Facelift," "Slightly All the Time," "Out-Bloody-Rageous") e da Fourth, che veniva pubblicato negli stessi giorni, e del quale sono presenti tutti i temi ("Virtually," "Fletcher's Blemish," "Teeth" e "Kings and Queens"). In più troviamo due temi che saranno incisi (senza Wyatt) sul successivo Fifth ("All White" e "Pigling Bland"), e un brano firmato da Elton Dean ("Neo-Caliban Grides") che comparirà nel suo primo album solo. Infine, è presente una breve "Vocal Improvisation" che fotografa il poco spazio dedicato alla voce di Wyatt.
Ogni CD (o LP, nel caso della versione su 4 vinili) contiene un set completo in un flusso continuo di musica che sfugge a ogni tentativo di categorizzazione, risultando ancora fresca e originale a oltre mezzo secolo di distanza. Anche se i due concerti presentano lo stesso materiale, questo non è cristallizzato, ma ogni sera si sviluppa ex novo, assumendo nuove forme e declinazioni a seconda delle improvvisazioni e degli umori del quartetto. Al sassofonista sono lasciati i momenti più free nelle sue due composizioni che rispettivamente chiudono il primo set e aprono il secondo, mentre a Ratledge spettano gli assoli più infuocati col suo organo Lowrey, generalmente accompagnati da Dean al piano elettrico, in un impasto di tastiere abbastanza nuovo per l'epoca. Il basso di Hopper funge da pietra angolare di tutta la struttura musicale, adeguatamente sostenuto dalla batteria anarchica di Wyatt.
L'ottima qualità audio della registrazione (anche se il sax di Dean appare talvolta distante) permette di apprezzare gli intrecci strumentali e i timbri che caratterizzano ciascun musicista (l'organo distorto di Ratledge, il basso fuzz di Hopper, il drumming morbido ma deciso di Wyatt, il saxello di Dean) creando un impasto sonoro unico e inconfondibile. L'apporto individuale di ciascuno di loro è indispensabile alla creazione di quel sound immediatamente riconoscibile che ha segnato un'epoca di grandi transizioni come è stato in musica il biennio 1970-1971, stagione irripetibile della quale i Soft Machine sono stati tra i maggiori protagonisti.
In un momento in cui si comincia a parlare di jazz-rock (o rock-jazz, a seconda dei punti di vista e di chi lo propone) gettando le basi anche per quello che nel decennio successivo diventerà il fenomeno fusion, i Soft Machine spiazzano tutti proponendo una musica assolutamente nuova e originale, che sembra prendere sia dal rock che dal jazz, ma che non è minimamente riconducibile a nessuno dei due generi, così come il drumming di Wyatt, che esula completamente dalle tipicità del rock e del jazz. Anche Dean, che dovrebbe essere il più inquadrato dei quattro, proveniendo da un contesto decisamente jazzistico, se ne distacca già con la scelta dello strumento principale, il saxello (un soprano dalla forma e dal timbro particolari, non molto usato nel jazz).
Il marchio Soft Machine resisterà fino ai giorni nostri, anche se non continuativamente, con diversi interpreti che si alterneranno nelle diverse incarnazioni della band, ma l'apice toccato dal quartetto nel '70-'71 non sarà più eguagliato, pur registrando tra alti e bassi anche alcuni altri risultati di notevole livello. Questa particolare formazione è degna di entrare nella storia della musica moderna al pari di altre ben più famose e celebrate come i Cream, la Jimi Hendrix, il quintetto di Miles Davis anni '60, il quartetto di John Coltrane del periodo Impulse, il trio di Bill Evans con Paul Motian e Scott LaFaro, e tante altre. Il materiale inedito storico comparso negli anni, di cui questo recentissimo cofanetto rappresenta uno dei migliori esempi, è un supporto netto e indiscutibile a questa affermazione, e siamo grati a Steve Feigenbaum e alla sua Cuneiform per averci svelato questo ennesimo capolavoro di questi quattro eccezionali musicisti.
Tags
Cover Stories
Soft Machine
Ludovico Granvassu
Cuneiform Records
Mike Ratledge
Robert Wyatt
Hugh Hopper
Elton Dean
Kevin Ayers
Daevid Allen
Pink Floyd
The Jimi Hendrix Experience
Brian Hopper
Mark Charig
Nick Evans
Lyn Dobson
Miles Davis
Cream
Jimi Hendrix Experience
John Coltrane
Bill Evans
Paul Motian
Scott La Faro
About Soft Machine
Instrument: Band / ensemble / orchestra
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.