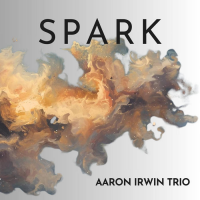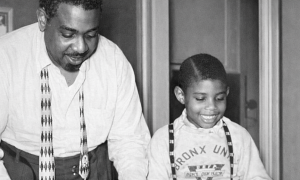Home » Articoli » Interview » Musica come sintesi e autogenesi - Intervista a Hugues Dufourt
Musica come sintesi e autogenesi - Intervista a Hugues Dufourt
Com'è noto, infatti, il nome di Dufourt viene associato al cosiddetto «spettralismo», ossia a quella corrente musicale di cui non solo il compositore divenne esponente di primo piano con l'adesione, tra il 1976 e il 1982, all'Ensemble Itinéraire - fondato nel 1973 da Roger Tessier, Michael Lévinas e Tristan Murail - ma fu anche teorico di grande lucidità, con una serie di illuminanti saggi - tra gli altri «Musique spectrale», del 1979 - in parte confluiti nel volume «Musique, pouvoir, écriture», Cristian Bourgois, Parigi, 1991 (ed. italiana: Ricordi-Lim, Milano, 1997). L'interesse per la speculazione, e più specificamente per la filosofia della musica, è peraltro tuttora in pieno sviluppo, con i quattro volumi dell'amplissimo «Essai sur les principes de la musiques», in corso di pubblicazione presso l'editore parigino Musica Falsa. Il primo titolo, «Mathesis et subjectivité», uscito nel 2006, è un affascinante percorso interdisciplinare nella cultura occidentale, da cui emerge come, nonostante le formalizzazioni sviluppatesi nei secoli (dalla teoria musicale dell'antica Grecia alle attuali tecniche di sintesi digitale e di microanalisi sonora),il pensiero musicale resista tuttora alla razionalizzazione integrale.
Già queste considerazioni ci inducono a sospettare che la classificazione di Dufourt come «spettralista» sia una schematizzazione troppo riduttiva, se non scorretta.
E' un dato storico certamente innegabile la condivisione, da parte dello stesso Dufourt, degli assunti principali della «musica spettrale» - peraltro applicati, parallelamente e in maniera affatto autonoma, da un outsider come il franco-rumeno Horaţiu Rădulescu - che sintetizzavano e conducevano a ulteriore sviluppo l'emancipazione del timbro intuita da Debussy e dinamizzata da Varèse con il concetto di «suono organizzato», le idee di Stockhausen sul continuum tra le diverse dimensioni sonore, le fluttuanti stratificazioni delle opere di Ligeti.
Il "principio cardine" dello spettralismo consiste nel fondare la composizione direttamente sulle dimensioni interne, «microscopiche», del suono.
Le caratteristiche di queste ultime, scandagliate grazie agli sviluppi dell'acustica e dell'informatica musicale, venngono cioè trasferite al livello «macroscopico» del suono strumentale.
Le innovazioni dello «spettralismo», pertanto, si riverberavano principalmente sul piano dell'armonia e dell'orchestrazione, che trovano ora base e arricchimento nell'analisi spettrografica del suono, studiato nel divenire temporale delle parziali, dei transitori, dei formanti o dell'inviluppo.
C'è però, come anticipato, una serie di motivi a rendere troppo schematica, e affrettata, l'inclusione di Dufourt in questa «corrente».
Innanzitutto, il compositore stesso rileva a più riprese la staticità degli spettri armonici («Musique, pouvoir, écriture», p. 335 ss.), e soprattutto percepisce il rischio che la "composizione del suono" possa irrigidirsi nell'applicazione meccanica delle risorse timbriche e armoniche offerte dagli sviluppi tecnologici e scientifici.
Integrando invece nel discorso musicale il timbro inarmonico e mantenendo l'autonomia dell'organizzazione delle altezze (dialetticamente recuperata al serialismo, contro il quale la musica spettrale si poneva in radicale contrasto), Dufourt non si abbandona alla seduzione delle nuove possibilità di costruzione e trasformazione timbrica (del resto, non è stato allievo, al pari di Murail e Grisey, di Messiaen, supremo fautore della sensualità sonora), ma si preoccupa di conferire dinamismo e direzionalità all'articolazione dei suoni, esploradone l'instabilità, varcando l'ambigua soglia che li separa dal rumore, imprimendo alla materia convulse torsioni. Con l'apporto fornito dalla conoscenza approfondita della psicoacustica, della fisica dei campi e a soprattutto della teoria delle catastrofi di René Thom, il compositore apre la continuità del flusso sonoro alle saturazioni e alle interferenze, mentre, nell'orchestrazione, disgrega l'evoluzione delle masse in brusche rotture o la dissolve in pulviscoli iridescenti.
L'esplorazione del timbro si rivolge pertanto, in prima battuta, ai "suoni complessi" delle percussioni (la cui instabilità frequenziale viene organizzata, con intento varèsiano, in opere come «Erewhon», del 1972-76; «Sombre Journée», del 1976-77; «Plus-Oultre», del 1990) e della liuteria elettronica (in particolare della chitarra, da ultimo esplorata nella «Cité de saules», del 1997, in cui l'uso del live electronics genera complesse stratificazioni), spesso associati tra loro («L'ile sonnante», del 1990) o integrati in un tessuto strumentale più ampio (in primis nell'emblematico «Saturne», composto nel 1979). Caposaldo del questo periodo è «Erewhon» (ispirata all'omonimo romanzo di Samuel Butler), sinfonia per sei esecutori e centocinquanta strumenti, tenuta a battesimo nel 1977 dalle Percussions de Strasbourg, sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli: qui, grazie alla sollecitazione dell'informatica musicale, e in particolare di Jean-Claude Risset e John Chowining, la percussione, spogliata di qualunque riferimento etnico o storico, diventa paradigma astratto per scandagliare le molteplici dimensioni interne del suono.
Analogamente, nella coeva «Tempesta d'après Giorgione», le ondes Martenot, l'organo e la chitarra elettrica si fondono con tre legni, vibrafono e trombone, per dare vita a un gioco chiaroscurale, statico ma carico di tensione, impregnando la composizione del senso di incombente minaccia evocato dal dipinto.
Questa composizione è di grande rilevanza, in quanto mostra il secondo ordine di ragioni che dimostrano la limitatezza la definizione di Dufourt come spettralista.
Il centro del suo lavoro creativo, negli ultimi decenni, non è occupato solo dallo studio minuzioso della fisiologia del suono e della percezione, ma si apre con sempre maggior frequenza ad altre dimensioni del sapere, anche extra-musicali, che hanno parimenti importanza strutturante, in primis l'estetica e le arti visive. Questo interesse, manifestatosi con evidenza nella «Tempesta» ritorna in «Saturne», che si richiama all'iconologia e alla riflessione estetica di Erwin Panofsky sulla malinconia, associata dall'antichità a quel pianeta «freddo, arido e lento». In questo fondamentale lavoro - come in «Surgir» (1984), mastodontica partitura per quasi 100 elementi - la massa orchestrale è trattata come un sintetizzatore che fonde e diffrange il plumbeo impasto delle percussioni e dei fiati - dalla tessitura prevalentemente grave - attraverso procedimenti di distorsione e phasing che coinvolgono nuovamente la stumentazione elettrica (ritroviamo infatti l'organo, le chitarre e le onde Martenot).
Quest'ultima infatti, anche e soprattutto nelle sue applicazioni «popolari», offriva inedite potenzialità timbriche, la cui complessità e instabilità, refrattaria alle descrizioni tradizionali in termini di altezza, durata, intensità, non poteva non esercitare una certa fascinazione sugli «spettralisti», spingendo Tristan Murail a sostenere che «lo sviluppo spettacolare dei sintetizzatori e del suono elettrico dovesse molto più ai Pink Floyd che a Stockhausen» e Dufourt stesso ad interessarsi alle apparecchiature di produzione del suono usate dalla celebre band.
Tornando alle corrispondenze multidisciplinari disseminate nell'opera di Dufourt, gli studi di Panofsky - specie quelli su Albrecht Dürer - echeggiano nuovamente sullo statico sfondo di «The watery star», brano per otto strumenti scritto nel 1993, che già nel titolo, tratto dallo shakespeariano «Winter's Tale», allude al suo intimo - ma sotteso d'inquietudine - temperamento «lunare».
A partire dall'«Heure des Traces», brano per ensemble intitolato a una celebre scultura di Giacometti, e presentato alla Scala da Pierre Boulez nel 1986, diventano sempre più frequenti e sistematiche le interconnessioni, le allusioni e le metafore ispirate alle arti plastiche e alla pittura, frequentate sin dall'infanzia presso l'atelier degli zii.
Lungi dall'idea di trasporre o di "descrivere" in musica l'immagine, e men che meno l' "atmosfera" del quadro, Dufourt di volta in volta trae modelli in grado di dinamizzare le forme musicali e fondere i timbri nell'amalgama complessiva.
Nel grande ciclo orchestrale degli "Hivers" (1992-2001), la suggestione dell'impasto proviene dai chiaroscuri e dallo sfondo cupo del "Déluge" di Poussain, ma soprattutto dai veneziani ("La gondole" d'après Guardi) e dai fiamminghi (con i chiastici movimenti dei "Chasseurs dans la neige" di Bruegel e l'enigmatico - forse autobiografica mise en abîme? - "Philosophe" d'après Rembrandt).
Con un salto di qualche secolo, sono le fluttuazioni repentine della linea, le accese tensioni cromatiche, il rifiuto del formalismo, propri dei più importanti astrattisti americani (da Pollock a Barnett Newman, senza tralasciare, sul versante "minimalista," Donald Judd e Frank Stella), o riscontrabili in un grande (ma misconosciuto) maestro dell'incisione come Stanley W. Hayter, a costituire la linfa vitale di opere per organico ampio («Lucifer» d'après Pollock, 2001) o ridotto (il coevo «Euclidean Abyss»), nonché del quartetto d'archi «Dawn Flight»,del 2008.
Un nuovo ciclo si è aperto in anni recenti intorno all'affresco dei «Quattro continenti», realizzato da Tiepolo negli anni 1751-53 nella Residenza di Würzburg. Due i brani sinora completati: sull'«Afrique» (2005), per pianoforte e ensemble si irradia la luce livida del dipinto, che, con le sue dense nubi sulfuree, permea lo spazio sonoro come un flusso continuo, mentre l' «Asie» (2009), per ensemble, associa gli spenti colori grigio-bruni della pittura a una perturbante accelerazione espressiva, non distante dalla temporalità paradossale e ambivalente che troviamo in l'«Origine du monde», per pianoforte e 14 strumenti, ispirata alla celebre tela di Courbet. L'integrazione fra strumento solista e organici di diverse dimensioni è al centro di numerose opere di Dufourt, e merita quindi un discorso a parte. In quei lavori il virtuosismo non è mai fine a se stesso, ma sempre funzionale a uno scambio di energie fra il concertista, che non ostenta certo una voce stentorea, e le sonorità orchestrali, tra le quali, al contrario, si apre faticosamente, spesso molto tempo dopo l'inizio, un percorso erratico e accidentato, che l'ensemble amplifica con tensione crescente. Le traiettorie sono sempre oblique e sofferte, quale che sia la fonte di ispirazione, si tratti delle antiche lamelle orfiche che evocano l'aldilà nel «Cyprès blanc», concerto per viola e orchestra del 2004, o del lirismo di Saint-John Perse in «...au haut faîte de l'instant»,ampio brano per oboe e orchestra presentato dall'Orchestra della RAI nel 2006. Qui il ruolo del solista aggiunge alla metafora poetica o pittorica l'allusione all'ardua sopravvivenza dell'individuo nella società attuale.
Non diversamente accade nei tre lavori in cui è protagonista il flauto, "torrido e acre" in «Antiphysis» (1978), o iridescente, ma diffratto dalle minacciose masse orchestrali in «La maison du sourd», brano del 19999 (di cui sono disponibili estratti qui, qui e qui), o ancora combattuto intimamente tra i contrasti di «Duel à coups de gourdin (Dos Forasteros)», brano solista scritto per un'occasione concorsuale nel 2008, e ispirato, come il precedente, alla cupezza lacerante delle pitture nere realizzate da Goya negli ultimi anni di vita.
Se è vero quindi che il colore e il senso della profondità hanno un ruolo fondante nella poietica di Dufourt, sarebbe comunque erroneo parlare di «impressionismo».
La composizione non si riduce al colorito, a un gioco di apparenze prive di soggetto: per Dufourt il senso è non meno rilevante del sensibile da cui emerge, senza che ciò implichi un'involuzione in senso formalista.
Alla luce di queste considerazioni è facile cogliere come un aspetto che distingue di Dufourt dallo spettralismo "puro" sia l'intento di trattare il timbro come un elemento dinamizzante e drammatizzante del gesto sonoro. Il colore può quindi rivitalizzare il teatro musicale (con «Dédale», del 1995), oppure interiorizzare senza anacronismi il lied - che, non diversamente dallo spettralismo, in fondo, dissolve le forme classiche nel continuum - nel ciclo pianistico sui lieder di Schubert, ispirati alle poesie di Goethe («An Schwager Kronos», «Meerestille», «Rastlose Liebe», e «Erlkönig» scritti fra il 1994 e il 2006) - o ancora generare dai suoi stessi elementi costitutivi quella peculiare plasticità che non nega ma rende fluido il contorno, lasciandosi apprezzare in molte pagine strumentali. Prive tuttavia di accensioni eclatanti, sospese tra toni malinconici e spesso tetri (evocati sin nei titoli,spesso tratti, singolarmente, da grandi poeti "visionari" : «Down to a sunless sea», da Coleridge; «Espace aux ombres», da Michaux; «Dusk light», da Ginsberg; «Noche oscura», da San Giovanni della Croce), le tinte di Dufourt si dibattono sotto l'influsso raggelante di Saturno/Kronos, sinistro Dio/Pianeta che offusca e fagocita la nostra temporalità «attivista e depressiva», per dirla con Dufourt.
Ma la luce oscura che si propaga dalle sue composizioni, anziché riflettere vane nostalgie sul passato o proiettare non meno vacue profezie sul futuro, riesce a offrire, tra tensioni e impulsi repentini, un barlume - opaco e instabile, ma, proprio per questo, vivo - sulla consapevolezza del nostro presente. Da questo «temperamento saturnino», peraltro, sono nate insospettate gemmazioni tra pratiche compositive eterogenee, come le metamorfosi contrappuntistiche di Philippe Hurel, le allucinate distorsioni di Fausto Romitelli, l'esplorazione della soglia tra armonico e inarmonico condotta da Riccardo Nova e Giovanni Verrando, le torbide tessiture elettroacustiche di Mauro Lanza, o ancora le trame "rumorose" di Raphaël Cendo.
Tornando alla strettissima attualità, la prossima tappa del percorso dufourtiano nella "nigredo" (con la quale "albedo" e "rubedo" non mancheranno di confliggere, certo, ma anche di unirsi), è una recentissima partitura per viola e quindici strumenti, «Les chardons d'après Van Gogh», che sarà presentata in prima assoluta dall'Ensemble Orchestral Contemporain, diretto da Daniel Kawka, a Torino, nell'ambito del Festival MiTo.
A "illuminarci" - non senza ambiguità, ça va sans dire - sulla sua opera è lo stesso Hugues Dufourt, nell'arco di più incontri, che si sono svolti tra Ginevra, Strasburgo, Milano e Radio 3 RAI.
__________________________________________________________________
All About Jazz: I quattro brani del ciclo pianistico da Lei scritto tra il 1994 e il 2006 si richiama al romanticismo letterario di Goethe e a quello musicale di Schubert. Qual è l'attualità di questo linguaggio?
Hugues Duforut: Ho iniziato a lavorare su questo ciclo più di dieci anni fa, con l'intento di realizzare una rottura sia simbolica sia effettiva con l'idioma pianistico invalso nel corso del ventesimo secolo, che inizialmente era percussivo (pensiamo a Bartok o a Stravinskij ed si è sviluppato via via in un gioco combinatorio e frammentario nelle opere di Stockhausen e Boulez.
Tuttavia questa tendenza si allenta con Ligeti, che ritorna, con i suoi Studi, a preoccupazioni "pianistiche": con questo termine mi riferisco a una tradizione e a una tecnica ben precise - con cui Beethoven, Chopin e Liszt miravano a conferire continuità all'articolazione del suono - alle quali ero stato educato, ma che intorno alla metà del novecento sembravano quasi completamente scomparse.
A Ginevra, infatti, ho seguito per una decina d'anni i corsi di Louis Hiltbrand, che preparava gli allievi ai concorsi pianistici internazionali: questi studi mi hanno trasmesso visione dello strumento più vicina a Richter che a quella corrente oggi.
Nondimeno, la mia intenzione non ha un senso regressivo né vuole essere un gesto di ripiegamento neoclassico; piuttosto, lo studio delle tecniche e dei linguaggi vernacolari della fine del diciannovesimo secolo è stato funzionale alla ricerca di altre tecniche e forme espressive.
Il riferimento a Goethe s'innesta su un percorso autobiografico di ritorno alle mie origini musicali: l'aspetto che caratterizza fortemente questa serie di brani è sì il ritorno alla tradizione austro-tedesca (non tanto a quella francese) nella quale mi sono formato, ma senza una volontà nostalgica o passatista... direi, piuttosto, di trasformazione: avevo bisogno di riannodarmi a una tradizione antecedente al pianismo della seconda metà del novecento, che ha toccato, secondo me, i suoi limiti; dunque dovevo cercare altrove.
I miei propositi erano, in origine, modesti, non c'era nessuna intenzione dimostrativa, né quella di fare qualcosa di didattico o di gigantesco; si è trattato invece di un esercizio pressoché privato, che si è sviluppato a poco poco sulla scia del tempo e dei concerti.
AAJ: Mi sembra che traspaia una visione del romanticismo del tutto anti-eroica, dove non c'è traccia di "titanismo".
Ho come l'impressione che un simile atteggiamento ritorni nei suoi recenti concerti. In «Le Cyprès Blanc» e in «...au plus haut faîte de l'instant» il ruolo del solista (la viola nel primo brano, l'oboe nel secondo) non mi pare tanto quello di sfidare e superare le prove tecniche più ardue. C'è sì l'idea dello slancio e della lotta, ma si tratta di una lotta che si gioca sul crinale di uno scacco inesorabile per l'individuo...
H.D.: Sì, trovo molto giusta questa osservazione. Non credo alla situazione del concertista eroico, alla funzione del solista "lisztiano" che esibisce il suo virtuosismo con gesti eclatanti, neanche se si tratta del pianista "lisztiano" moderno, che affronta la musica di oggi, per esempio Xenakis, facendo mostra della sua tecnica sfavillante; non posso collocarmi in una simile prospettiva, che, al di là di ogni giudizio di valore, ha per me perso significato e interesse dal punto di vista musicale.
Ciò che invece ognuno di noi sperimenta è piuttosto la condizione della sopravvivenza: tutti viviamo un'esistenza molto precaria, minacciata; i grandi disegni collettivi sono sempre meno evidenti e non credo nondimeno che l'individualismo sia, diciamo, una specie di "virtù capitalista interiorizzata": è piuttosto l'effetto di un esistenza compromessa, minacciata, sballottata dai casi della vita.
Di conseguenza non posso situarmi nell'ottica dell'individualismo "possessivo" di Hobbes, né in quello "carismatico" alla Liszt, né in quello "imperialista" di Boulez: tutto questo non mi sembra appropriato a simbolizzare il nostro destino effettivo. Cosa può fare, allora, un solista, se non può più neppure far sentire la propria voce? Certo, negli anni '50 e '60 personaggi come Berio abbiano saputo trovare un modo di espressione adeguato al grande anonimato collettivo, in maniera molto pregnante e significativa. Ma ora la situazione è cambiata parecchio, perché oggi la realtà sociale è molto più individualista, più critica e aspra, più distaccata da qualsiasi adesione alla collettività. Una situazione sulla quale si affacciano molti rischi, ma che nondimeno vive nella mediocrità: non ci sono grandi obiettivi da raggiungere, ed è nel dominio della micropolitica che i diversi individualismi cercano di connettersi; tornando al solista la sua condizione esemplifica quella di un individuo che cerca di connettersi a questa microsocietà, in cui tutti cercano di farsi sentire, con la conseguenza paradossale che ogni singola voce rischia di scomparire. Questa la situazione dell'umanità oggi, non molto brillante certo, ma è così... La scelta di riferirmi alla Germania e all'Austria di Schubert s'inscrive in un disegno simbolico evidente, perchè Schubert viveva all'epoca della Santa Alleanza, di Metternich, del Biedermeier. In un certo senso penso che la globalizzazione di oggi sia la nostra epoca Biedermeier. Oggi viviamo in contesto Biedermeier mondializzato, con un carattere kitsch piccolo borghese, esteso su scala mondiale, un sincretismo universale, un'assenza di punti di riferimento totale. A questo bisogna aggiungere Il problema più delicato e nuovo (perché non ha precedenti) dell'attualità, ossia la sparizione di tutte le forme di cultura alta, non solo della nostra tradizione musicale colta occidentale; la questione coinvolge tutto il mondo e tutte le culture, si tratti dell'Europa, dell'Asia o dell'Africa.
Dunque è questo il quadro di fondo, in cui al solista non resta che chiedere: "che cosa volete farmi dire d'altro?"
AAJ: Nel 2006, Lei ha presentato a Torino un'esecuzione del quartetto per archi n. 16 op.135 in Fa maggiore di Beethoven, sottolineando, a proposito dell'ultima produzione del compositore, la particolare relazione dialettica con la tradizione musicale che lo ha preceduto. Qual è l'attualità del suo insegnamento?
H.D.: Credo che ad alcuni - è un po' una caratteristica della nostra epoca - il passato, anche quello recente, sembri terribilmente lontano, e dunque obsoleto, quasi scomparso. Ma al tempo stesso, nessuna epoca ha mai ricapitolato o esplorato il passato quanto la nostra,si tratti del passato delle stelle o dell'universo, della storia archeologica o geologica. Anche il nostro passato politico appare già ora come una piccola unità nella storia dell'umanità : il periodo le cui origini risalgono a Gesù Cristo e giunge al XX secolo sembrerà una specie di autonoma entità storica, ormai conclusa.
Beethoven, dunque, non è poi così lontano da noi, dal momento che ha inventato la dialettica in musica. Era esattamente contemporaneo di Hegel, essendo i due nati nello stesso anno e, second me, la verità di Beethoven si trova espressa filosoficamente in Hegel, che non amava particolare la sua musica, sulla quale è rimasto praticamente muto, anche se conosceva le sue opere.
La ragione profonda risiede nel fatto che Hegel, nella sua Estetica, difendeva il mondo della musica vocale, un mondo che era già superato all'epoca sua e del Romanticismo, mentre a quell'epoca la musica strumentale sviluppava sempre più il suo coefficiente di astrazione, di artificio, di sviluppo tecnologico; ma nel contempo il correlato, per così dire «positivo» di questo sviluppo apparentemente esteriore e tecnico era, viceversa, la conquista dell'interiorità più profonda.
Hegel era molto combattuto dinnanzi a questa musica, che non ha mai attaccato frontalmente, dal momento che, in fondo, lo metteva in difficoltà. A moi avviso Beethoven era la verità di Hegel, ma Hegel non l'ha riconosciuta come tale. E d'altra parte ciò che Hegel ha potuto dire di Beethoven, non l'ha detto coscientemente, bensì a sua stessa insaputa, non nell'estetica, ma nella sua Logica: nello sviluppo dalla dialettica dell'essenza alla dialettica dell'idea troviamo Beethoven, nel senso che quest'ultimo riprende, specie verso la fine della sua vita (e in particolare con l'opus 135), tutte le tecniche musicali con grande consapevolezza, come dimostrano le testimonianze dei suoi amici e del suo entourage.
Beethoven rielaborava Mozart - che già aveva già cominciato a formalizzare il passato - in quanto aveva preso coscienza delle virtù della formalizzazione, non considerata come fine a se stessa, ma come strumento necessario ad acquisire nuovi modi espressivi e direi, allo stesso tempo, per procedere oltre qualsiasi «espressione».
La lezione di Beethoven è che il lavoro formale è pressoché autonomo dal materiale: è unp strumento per superare i problemi espressivi, per ottenere una forma di lirismo decantato, che non si era mai conosciuto prima e non si conoscerà praticamente più dopo di lui.
Dunque non soltanto la sua lezione è unica, ma soprattutto è molto avanzata, perché si tratta di un programma per l'avvenire dell'umanità e non di una semplice ricapitolazione del passato; allo stesso modo possiamo dire che il ritorno agli arcaismi in Beethoven non ha nulla di regressivo.
AAJ: E' noto il Suo interesse per mondi artistici diversi da quello musicale, spesso fonte d'ispirazione per lavori che, già nei titoli, si richiamano a Giorgione o a Guardi, piuttosto che Tiepolo e Rembrandt o, da ultimo, Van Gogh, i cui « bouquets de chardons » sono alla base del Suo concerto per viola e orchestra, che sarà presentato al Festival MiTo. Immagino che, nel Suo percorso compositivo, al di là dei Suoi legami parentali con alcuni pittori, vi siano ulteriori relazioni, più strutturali e profonde, con l'arte visiva.
H.D.: Due cose, innanzitutto. La prima rivelazione: a Venezia, grazie alla mia famiglia, all'età di dieci anni, ho scoperto la pittura dei Giorgione e dei Tintoretto. La pittura veneziana è fondamentalmente la storia del colore, ponendosi in opposizione a quella dominante in Italia, che a Firenze e a Roma era fondata innanzitutto sul disegno e sul concetto. E' una pittura legata al mondo del commercio, che libera, in un modo o nell'altro, la sensorialità dall' elaborazione concettuale, pur caricandola spesso di sottesi significati politici, in un gioco di rimandi piuttosto complesso. Sono stato colpito dal fatto che non si tratta di una pittura luminosa, caratterizzata prevalentemente da masse scure e da rari filamenti di luce livida che emergono dallo sfondo del quadro, mentre la luce opulenta e trasparente che troviamo a volte in Veronese o Tiziano costituisce piuttosto un'eccezione. Ciò che mi ha insegnato la pittura veneziana è una forma di potenza elementare, il senso della torsione e della voluta, senza interruzioni, non imbrigliata da troppe linee o dalla geometria ; penso anche alla capacità di sintesi di Tintoretto, con le sue anamorfosi che colgono il reale anticipando l'odierna inquadratura cinematografica.
Ho appreso questo e molto altro dalla pittura veneziana; dopodiché i miei gusti personali si sono poi indirizzati autonomamente verso la pittura « moderna » del XX secolo, quella astratta e americana in particolare, dal color field painting all'astrazione lirica. Ho fatto ricorso alla pittura per esprimere una certa filosofia della musica, che non avrei potuto comunicare negli anni '70 al pubblico in altro modo: di conseguenza la metafora visiva era una forma di mediazione culturale per esprimere idee che non erano certo in accordo con la sensibilità dell'epoca. Non si trattava, tuttavia, solo di stratagemma per far passare un messaggio: in effetti esiste nella pittura una reale vicenda storica, vale a dire la storia del colorismo, che risale a Brueguel e alla fine del Rinascimento e prosegue sino alla pittura astratta di oggi.
C'è dunque una continuità delle problematiche nella pittura, che, per analogia, è affatto chiarificatrice anche riguardo alla musica, nella quale si può riscontrare un'evoluzione simile attraverso la storia dell'orchestrazione.
Ma bisogna ancora relazionarsi agli anni '70, in cui lo spirito del tempo non era affatto preparato a questo genere di linguaggio, che allora sembrava semplicemente folle: « La tempesta d'après Giorgione», per esempio, ha riscosso parecchio successo quando l'ho scritta, è stata ripresa anche dall'Ensemble Intercontemporain, ma è comunque un'opera che lascia ancora l'impressione di provenire da un altro pianeta. Il clima culturale, quindi, non era pronto ad ascoltare questo tipo di discorso , che i lavori musicologici non erano in grado di mettere a fuoco; si parlava vagamente di « colore » in musica, ma nessuno sapeva farlo davvero. Ci si trovava infatti in un'epoca ancora post-strutturalista, in cui il colore era più o meno assimilato a un moto browniano, a una specie di colorismo, a una strumentazione un po' più ampia e brillante; soprattutto, il colore era concepito come un mélange assolutamente informe, perché si provava a comporre per trame, per strati piuttosto spessi: di conseguenza, il colorismo era a mio avviso non solo molto timido, ma anche molto «rumoroso.
I compositori dell'epoca non erano, in verità, dei « coloristi », semplicemente perché le loro conoscenze in materia di orchestrazione, a parte Messiaen, erano piuttosto debole, e in ogni caso operavano in un contesto in cui non ci si poneva questo genere di preocupazioni. Tutto ciò che ho sviluppato in seguito, con la teorizzazione di quella che è stata chiamata « musica spettrale », proveniva, in fondo, da una convinzione colorista, perché ho sempre sostenuto che la musica approdi a un livello superiore quando si spoglia di tutto il suo apparato retorico. L'ossessione dei musicisti, smaniosi di fare carriera è, invece, quella di diventare degli accademici riconosciuti : anche gli innovatori hanno spesso questa aspirazione, e a tale scopo finiscono per preoccuparsi della bella forma, dimenticando il colore, l'informe, e tutti i veri rischi dell'arte. Per me la cosa più interessante era e rimane questo colorismo imponderabile, che sfugge a qualsiasi accademismo.
AAJ: Quali sono gli astrattisti da Lei prediletti?
H.D.: Un punto di svolta per me sono stati gli americani: penso a Kline e De Kooning, al Pollock di «Lucifer», al quale mi sono ispirato per un brano per grande orchestra, mentre in «Euclidean Abyss» sono partito da un dipinto di Barnett Newman, il grande maestro del colorfield painting.
Più recentemente, anche se non è un'opera astratta, mi sono basato sull' «Origine du monde» di Courbet, per comporre un brano per pianoforte e orchestra. In generale, direi di sentire un'affinità verso il modo con cui Proust si accosta all'arte - e alla pittura in particolare - realizzando, nella «Recherche», dei veri e propri prodigi nel «rifare» i famosi quadri di Elstir, il personaggio nel quale sono sintetizzati diversi pittori impressionisti. Quando descrive un quadro, infatti, Proust, in realtà, «rifà» il quadro, alla sua maniera, senza mai cercare una descrizione letterale, o un equivalente poetico, della composizione plastica. Con la sua particolare tecnica letteraria, nell'arco di tutta la «Recherche», Proust crea metafore di una tale sottigliezza che ci fa entrare in una materia che è la medesima del quadro, attraverso una nuova, e vera, forma di comunicazione tra le arti, che non mira a «delucidare» la verità di un'opera, ma piuttosto a crearne un'altra, per aiutarci a comprendere.
Nel mio rapporto con la pittura non ho cercato di chiarire l'essenza di questo o quel dipinto, ma piuttosto di ottenere un tipo d'intensità e di relazione che ci introducesse a poco a poco nel quadro. Per fare un esempio concreto, intorno al 1986, il Museo d'Orsay aveva sollecitato un certo numero di opere ad alcuni compositori della mia generazione, finalizzate a permettere a un pubblico molto più giovane di accedere a una pittura che oggi sembra affatto lontana e assai poco immediata, come quella del XIX secolo. La richiesta, molto originale, era quella di creare opere contemporanee che parlassero, con un linguaggio attuale, di opere del passato: si trattava, più precisamente, di fare un film di circa dieci su ogni opera, di lavorare con un coreografo e, quindi, di realizzare la musica. In quell'occasione, che vedeva coinvolti Pascal Dusapin, Marc Monnet e altri, presi a modello non un dipinto, ma una fotografia, «Les ramoneurs du quai Bourbon» di Charles Nègre, uno dei primi e più importanti fotografi del diciannovesimo secolo. Il soggetto è costituito da tre spazzacamini stremati dalla fatica di una giornata di lavoro, addormentati sul quai Bourbon, sotto un sole già al tramonto e col freddo incombente. Qui è rappresentata una realtà - non un simbolo, certamente - ma una realtà straordinaria, trasfigurata dalla qualità della fotografia, con la sua grana e il suo color seppia, molto polverizzato. Partendo da questi presupposti, ho scritto la musica per un ensemble di una decina strumenti: l'idea mi era piaciuta molto, perché affine al mio modo di intendere la pittura. A un livello profondo, infatti, la pittura - come ci dimostrano la sua storia e l'estetica (penso specialmente a Panofsky, Aby Warburg, Fritz Saxl e agli altri studiosi tedeschi) - è la facoltà che condensa in se stessa, attraverso il colore, tutta la tonalità di un epoca. Ciò che mi ha colpito, nei dipinti che ho scelto di volta in volta, è l'unità di tono, la potenza di sintesi e di condensazione che la pittura realizza non attraverso un simbolo, perché il colore non è un simbolo, ma è semplicemente se stesso, e non sarà mai un altro colore: nella pittura romana, ci sono per esempio colori assolutamente stupendi, e unici nella storia, che non ritroveremo mai. Siamo qui in presenza di un'evidenza che attraversa tutte le epoche storiche, che non sempre si manifesta esplicitamente e può dar luogo a cortocircuiti, ma non è puramente illusoria.
La pittura quindi non ci rimanda a un passato ormai concluso, ma direi piuttosto a una storia, che continua a produrre se stessa e le sue forme, anche a nostra insaputa, pur essendo noi «postmoderni".
AAJ: Quali sono le conseguenze della polemica condotta negli anni '70 dal cosidetto movimento spettralista contro lo strutturalismo? Puo' ritenersi stemperata la portata di questa critica, anche sul piano «socio-politico», se consideriamo la circostanza che Tristan Murail si è avvalso, già molto tempo fa, delle tecnologie messe a disposizione dell'IRCAM, «creatura" dello strutturalista Boulez?
H.G.: C'è davvero molto da dire a questo proposito. Certo, abbiamo polemizzato coscientemente contro un ordine formale strutturalista, in un'epoca in cui la struttura, in realtà, veniva dissolta frequentemente nel caso e nell'alea, anche se è vero che gran parte delle musiche di quel periodo derivavano più o meno tutte dal formalismo. Ciò che è stato frainteso della nostra posizione - o almeno, della posizione che mi accomunava a Grisey - consisteva in fondo, nel fatto che non condividessimo quella dispersione analitica, si trattasse delle grandi masse di Xenakis, della musica neo-seriale o ancora delle micropolifonie di Ligeti.
Tutto questo non ci sembrava più adeguato: Grisey, del resto, ha sempre rivendicato a chiare lettere la distanza tra il proprio linguaggio, basato sulla conoscenza degli studi più avanzati nel campo dell'acustica, e quello precedente di Ligeti, che di questi aspetti non poteva essere al corrente. Su una Grisey e io concordavamo, ossia sul fatto che la musica proceda da un gesto sintetico: è la sintesi a trovarsi al principio, e di conseguenza tutti i dettagli analitici che procedevano dal serialismo, dai calcoli stocastici o dalla trasposizione di modelli elettroacustici ci parevano inappropriati al discorso musicale. Quindi abbiamo dato priorità alla capacità di sintesi, che certamente, all'epoca, riguardava, tra l'altro, tutte le dimensioni acustiche, ma sarebbe sbagliato ridurre la musica mia o di Grisey a una mera sintesi acustica: si trattava di un problema innanzitutto estetico e compositivo, direi anche filosofico, in quanto toccava quello che ci pareva essere il giusto atteggiamento mentale nei confronti della composizione stessa: chi non adottava un approccio sintetico, ma continuava a procedere per costruzioni, induzioni, deduzioni, o amplificazioni, perdeva secondo noi il senso della musica. Pertanto abbiamo voluto comporre una musica «sintetica», che da un lato creasse essa stessa il proprio processo sonoro come un'unità, e che dall'altro, interiorizzasse man mano nella struttura formale dell'opera le condizioni di questo processo. Quella che è stata chiamata «musica processuale», quindi, non significa collegare registratori con un anello di nastro magnetico, in maniera più o meno complessa; il concetto vuol dire piuttosto costituire una durata che incorpori in sé i singoli istanti, ossia integrare costantemente tutte le condizioni dell'opera nel suo stesso processo: si tratta quindi un'autogenesi.
Dunque abbiamo formulato due concetti fondamentali: la musica come primato della sintesi, e come autogenesi. Come poteva essere, valutata allora, da un punto di vista formalista, un'opera che si identificava nella genesi di se stessa? Molti formalismi degli anni '50, specularmente, apparivano, alla nostra prospettiva, decorativi e accademici, sostanzialmente privi d'interesse.
La nostra, quindi, non era tanto la lotta dell'apparenza sensibile contro uno strutturalismo nascosto; si trattava, invece, di una polemica contro un'apparenza strutturale che finiva col perdere la vera potenza di strutturazione della musica. Quanto a Murail, bisogna considerare che, negli anni '80, non c'erano grosse difficoltà a passare all'informatica musicale negli anni '80, grazie agli sviluppi della scienza e della tecnologia del computer, dovuti soprattutto a Jean-Claude Risset e John Chowning, i quali, già alla fine degli anni '60 avevano posto tutte le basi teoriche della musica spettrale, che certo non è uscita dal nulla, ma non si può ridurre alla trasposizione delle tecnologie elettroacustiche o dell'analisi degli spettri acustici.
Purtroppo simili banalità escono ancora oggi dalla penna dei musicologi, ma si tratta di bestialità, con cui queste persone tradiscono l'incomprensione totale non solo di ciò che abbiamo fatto, ma anche del loro stesso mestiere. Il problema non era dunque questa traslazione dall'elettroacustico allo strumentale (che d'altronde era già stata realizzata negli anni cinquanta da Ligeti e Stockhausen), bensì quello di comprendere come la musica informatica ottenesse una nuova unità del mondo sonoro, che non aveva precedenti, dal momento che per produrre la musica entravano ora in gioco frequenze, ampiezze e fasi; si verificava quindi un cambiamento di scala, raggiungendo un livello microscopico, pari al trentamillesimo di secondo. Di fronte a questa nuova realtà, il cambiamento di scala significava per noi un cambiamento di linguaggio, come avevano compreso Risset, con "Inharmonique," e Chowning, con «Stria»: questa era la linea nella quale intendevamo inserirci, senza ripiegare in una sorta di edonismo tecnologico, come invece ci viene spesso contestato.
In realtà, la preoccupazione estetica di cui parlavo non poteva che condurci alla conoscenza approfondita delle microstrutture del fenomeno sonoro, della psicoacustica e dell'informatica, costringendoci, di conseguenza, a un rinnovamento dell'orchestrazione.
AAJ: Spesso si evidenzia quanto Giacinto Scelsi sia stato influente sullo spettralismo.
H.G.: Non sono del tutto convinto di questa influeza; quel che posso dire è che gli altri componenti dell'Itinéraire erano ospiti affascinati, e sempre riconoscenti, di Scelsi a Roma, durante le loro residenze a Villa Medici, alle quali non ho potuto aggregarmi, dato che all'epoca ero già impegnato al CNRS. Non quindi ho conosciuto Scelsi personalmente, ma penso che emanasse una sorta di magnetismo sugli altri: non tanto su Grisey, che era piuttosto un adepto incondizionato di Stockhausen e Ligeti, mentre Murail ne era un ammiratore sincero, uno dei pochi ad averlo conosciuto bene, contribuendo alla diffusione della sua musica, specialmente a Parigi, anche con una serie di pubblicazioni («Scelsi, décompositeur», e «Scelsi, l'Itinéraire», oggi raccolte nel volume «Modèles et artifices», pubblicato nel 2004 dalle Presses Universitaires de Strasbourg, ndr).
AAJ: Quali sono stati gli sviluppi della musica spettrale dopo l'Itinéraire? E quali quelli attuali?
H.D.: A livello di linguaggio musicale, bisogna superare qualche fraintendimento, perché Grisey, Murail, Lévinas e io siamo stati accomunati come in una specie di «scuola». All'epoca in cui ho scritto il testo sulla musica spettrale (1976), Grisey e io avevamo delle idee abbastanza precise, mentre Murail avrebbe formulato più tardi il suo pensiero con le conferenze («La révolution des sons complexes» e «Spectres et lutins», ndr) tenute a Darmstadt nei primi anni ottanta, fondandolo sulle conoscenze del computer acquisite tra il 1975 e il 1981.
In effetti in quegli anni Murail era tra noi il più avanzato in quel campo, essendo l'unico assolutamente persuaso che dall'informatica potesse ottenersi un linguaggio musicale, o meglio l'unico linguaggio musicale possibile. Grisey ha invece enunciato un'idea opposta, sostenendo come la musica sfuggisse a ogni forma di razionalità evidente, inclusa quella della programmazione. C'erano quindi posizioni decisamente antinomiche in seno all'Itinéraire: io stesso avevo idee piuttosto diverse da quelle difese da Grisey e Murail. Sono infatti dell'opinione che la musica cambi scala, e dunque linguaggio: ci troviamo infatti nell'era dell'informatica musicale, di un microscopio sonoro che è trasferibile su grande scala. La mia idea di musica, del resto, non era incentrata solo sullo spettro sonoro, quanto piuttosto sull'identità tra morfogenesi e dinamica. Le origini di questa concezione possiamo rintracciarle nei testi di René Thom, il fondatore della teoria delle catastrofi, che avevo letto all'epoca della loro pubblicazione, nei primi anni '70, come «Modelli matematici della morfogenesi», e soprattutto «Stabilità strutturale e morfogenesi», della cui conoscenza sono debitore a Robert Bonnet, un amico matematico che insegna tuttora a Lione. Quest'ultimo libro, in particolare, mi ha accompagnato per tutta la vita, dal momento che parla, per esempio, di dinamiche polarizzate, di avvicinamento a uno stato di equilibrio, di spettro, che Thom definiva come relazione tra l'energia e la complessità spaziale, offrendo l'esempio della corda vibrante. Lo spettro viene espressamente collegato a un problema variazionale. Tra i concetti fondamentali, troviamo l'idea di forme quasi-statiche e di vibrazioni infinitesimali, una definizione della risonanza, della turbolenza e della fusione. Tra le idee che ho applicato in ambito strettamente musicale, in particolare in «Erewhon», c'è la considerazione che vi è un numero ristretto di «catastrofi», o forme di rottura possibili: in una visione continuista della materia, come quella di Thom, la discontinuità viene limitata a sette tipologie ben specificate. Nella sua opera si troveranno tutti i concetti fondamentali, così come il vocabolario, che hanno impegnato la musica spettrale: spiace che la sua vera fonte non sia stata indicata più spesso, in quanto termini come «processo» e «morfologia del processo», «cambiamento di fase», «regime transizionale», «stabilizzazione delle soglie», «spazio di parametri interni», «strato di transizione e di turbolenza», non avrebbero potuto svilupparsi con tale coerenza e sistematicità nella semplice testa di un musicista.
Pertanto, ho sempre protestato, e con una certa veemenza, contro l'accaparramento e l'occultamento delle fonti.
__________________________________________________________________
Discografia essenziale su Hugues Dufourt: «Erewhon» - Les Percussions de Strasbourg, (Lorraine Vaillancourt, direzione) - CD ACCORD, 2000
«La Maison du Sourd - Lucifer d'après Pollock» - Orchestre Philharmonique de Radio France, Pierre Yves Artaud (flauto), Emilio Pomarico (direzione) - CD ACCORD, 2001 «Les Hivers» - Ensemble Modern di Francoforte - Dominique My - 3 CD's aeon, 2002 «Le Cyprès blanc - Surgir» - Gérard Caussé (viola), Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Pierre-André Valade (direzione) - CD Timpani 2007 «Les Météores: L'Origine du monde - Hommage à Charles Nègre - The Watery Star -Antiphysis» - Ancuza Aprodu (piano), Fabrice Jünger (flauto), Ensemble Orchestral Contemporain, Daniel Kawka (direzione) - CD Sismal Records 2009
__________________________________________________________________
Bibliografia essenziale: Hugues Dufourt, «Musique, Pouvoir, Ecriture», Paris, Christian Bourgois, 1991, 362 pp. (ed. italiana «Musica, Potere, Scrittura», traduzione dal francese di Ettore Napoli, Milano, Casa Ricordi, Coll. Le Sfere, 1997, 387 pp.) Hugues Dufourt, «Mathesis et subjectivité. Des conditions historiques de possibilité de la musique occidentale», Paris, 2007, 391 pp. Pierre-Albert Castanet, «Hugues Dufourt, 25 ans de musique contemporaine», Paris, Ed. Michel de Maule, 1995, 414 pp.
__________________________________________________________________
Intervista rilasciata a Radio 3 RAI
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.