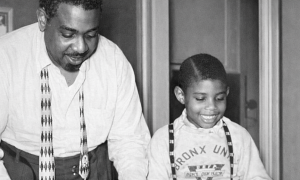Home » Articoli » Interview » Intervista a Stefano Battaglia
Intervista a Stefano Battaglia
Stefano Battaglia: Le cose vanno sempre come devono andare. Avevo da poco registrato delle improvvisazioni nello studio Artesuono con il violinista Dominique Pifarely e il percussionista Michele Rabbia. Qualche giorno più tardi Eicher era nello stesso studio a mixare un album di Rava e durante una pausa il tecnico Stefano Amerio riversò su CD la mia registrazione della settimana precedente e Manfred ne rimase colpito. Io ero a casa, quando arrivò la telefonata in cui mi si chiedeva di innescare la collaborazione. Mi ci volle un po' di tempo per credere che non si trattasse di uno scherzo. Fissammo un appuntamento a Monaco durante il quale Manfred volle ascoltare anche altri nastri di quel periodo e alla fine mi propose di esordire con un doppio album - Raccolto - di due diversi trio, uno più legato a linguaggi di emanazione jazzistica, l'altro vicino a quelli contemporanei e delle nuove musiche. Da lì a poco entrai in studio a registrare più di trenta composizioni dedicate alla figura di PierPaolo Pasolini, da cui scegliemmo materiale per un altro doppio album - Re: Pasolini -, ancora con due formazioni differenti.
Da quel momento ci siamo concentrati sul documentare i gruppi più stabili: il duo con Rabbia - Pastorale - , il Trio di The River of Anyder e prossimamente il solo. Inoltre abbiamo già registrato nuovo materiale in Trio con il chitarrista norvegese Eivind Aarset e Rabbia. Lavorare nella musica in un clima di reciproca profonda comprensione rende la collaborazione molto semplice. Libertà, passione, generosità e lealtà sono i valori più importanti nel rapporto tra artista e produttore. Credo che proprio grazie a questo ECM abbia costruito i sodalizi più importanti, riuscendo a documentare gli ultimi quarant'anni di storia della musica nel modo più esaustivo, ampio e trasversale. Dopo otto anni fatico a considerare Eicher solo un bravo produttore, tanto è consapevole e appassionata la sua condivisione nel processo creativo. Da un punto di vista personale mi ritengo privilegiato sia per la generosità con la quale Manfred ed io abbiamo sviluppato il rapporto, sia perché questo sodalizio regala significato al mio lavoro e avvera uno dei sogni della mia giovinezza.
AAJ: Cos'è per Stefano Battaglia l'ECM sound? Una perfetta sublimazione estetica, un'arma a doppio taglio che rischia di appiattire le personalità artistiche, o...
S.B.: La premessa è che tutte le parole e i pensieri che sento a proposito di ECM sono solo parole e pensieri, dunque non-reali, mentre il lavoro svolto da ECM è lì, concreto, a documentare da quarant'anni, producendo (realmente!), molte delle cose migliori in campo musicale da ogni parte del mondo sia nella musica antica, tradizionale-etnica (la cosiddetta world-music), classica, romantica, moderna, contemporanea, jazz (senza ideologie, dal mainstream alle avanguardie), sino alle nuove musiche, compreso avanguardie ed elettronica. Per questo ogni volta che mi chiedono di parlare di ECM faccio questa premessa: ogni riflessione e parola è superflua rispetto alla realtà. Ci sono due questioni riguardo al sound, una tecnica l'altra artistica.
Da un punto di vista tecnico credo che negli anni nei quali ECM è germogliata sino a diventare la più importante delle etichette indipendenti (fine anni sessanta, anni sessanta) vi fosse davvero un'energia speciale nel mondo occidentale e molta sperimentazione anche attorno alla ripresa del suono, soprattutto alla sua manipolazione in fase di post-produzione in studio, e in questo senso quasi tutti sono andati nella direzione opposta, rispetto a Eicher. Erano gli anni del boom del disco e il pop, inutile nasconderlo, creava una tendenza perversa per la quale anche le musiche acustiche, fatte di dinamiche reali, inseguivano l'estetica della musica leggera nella speranza di emularne le vendite. Inoltre, in concomitanza con l'espansione del set di batteria, degli strumenti elettrici ed elettronici, quasi tutti gli studi di registrazione erano progettati per assorbire il suono anziché espanderlo, e per garantire delle dinamiche "gradevoli" e radiofonicamente presentabili, il suono stesso veniva sofisticato e compresso, i musicisti separati da stanze chiuse, quasi ci fosse la volontà di avere un suono "da disco" da opporre a quello "reale," del "live". Più adatto al sound dei Weather Report, o di Miles, che a quello di Konitz, e molti ensemble dal suono cameristico ne soffrirono, a mio parere, fatta eccezione per coloro i quali collaborarono con ECM.
Persino i teatri sono stati riempiti di velluti e moquette, che sono la morte del suono! I produttori di jazz acustico si trovarono tutti a fare barricata proteggendo la purezza della ripresa in registrazione, ma erano paradossalmente costretti a lavorare in studi evidentemente progettati per altro genere di musica: il risultato era un suono puro, sì, ma quasi sempre brutto (o perdente per impatto nei confronti della musica elettrica) per via dell'ambiente nel quale era collocato, che non permetteva mai e in nessun modo al suono di viaggiare. La mia opinione è che le scelte estetiche di Manfred si basassero prima di tutto sulle caratteristiche peculiari del suono del musicista, che presuppone da parte sua delle orecchie molto buone e una percezione attiva, viva e vibrante dello spazio in cui il musicista stesso collocava, viveva, la sua performance. La "sofisticazione" che ha determinato il cosiddetto suono-ECM invece penso abbia proprio a che fare con la scelta di usare in post-produzione uno spazio ambiente più simile a quello della chiesa o del teatro di antica concezione, molto risonante, senza materiali fono-assorbenti, in contrasto con le gabbie ovattate degli studi-standard.
Questa scelta, quando condivisa col musicista, ha determinato dei capolavori nei quali l'ambiente ricreato ha influenzato l'azione, il gesto tecnico e la narrazione del performer. Penso ad esempio ad una gemma come Open to Love di Paul Bley, dove Bley sfrutta la lunghezza e gli overtones del suono riverberato per un dialogo appassionante col silenzio: dialogo la cui rarefazione certamente deve molto alla tecnica-estetica di ripresa dello strumento nell'ambiente. Parlerei del suono-ECM dunque in termini di influenza, sfida, o stimolo, per un performer. In qualche caso una necessità: se si pensa al celebre Koln Concert, pochi direbbero che si trattava di un piano mediocre. La grandezza del pianista e la sofisticazione operata da Manfred ha determinato quel suono da iper-strumento che è un poco irreale, probabilmente migliore-della-realtà... certamente caratteristico e funzionale!
Negli ultimi quindici anni il suono ECM è ancora cambiato a favore di una maggior naturalezza, addirittura tornando ad una dimensione simile a quella con la quale si registrava la musica acustica, classica specialmente, nel dopoguerra sino agli anni sessanta. Musicisti molto vicini, stretti nella stessa stanza (teatro o auditorium o chiesa), esattamente come per la musica da camera: buoni microfoni, buone orecchie, buoni musicisti. Niente sofisticazioni. Il nostro disco in Trio è stato registrato esattamente come un live, o come un disco anni sessanta: teatro e palco in legno (l'Auditorium della Radio Svizzera), strumenti attaccati uno all'altro, niente cuffie, niente separazioni. Pronti e via. Dinamiche reali, in relazione col suono dei partners e l'acustica dell'ambiente. Avevo già registrato in Trio con questo sistema di ripresa, stretti in cerchio in un teatro di Siena, i Book of Jazz e 2), nel 2000 per Symphonia, con Dalla Porta e Sferra: lo trovo esaltante, è una esperienza molto reale, si possono curare i dettagli e le sfumature del tocco e delle dinamiche, non c'è possibilità di tagliare e montare in fase di post-produzione, è una bella sfida dal punto di vista tecnico, soprattutto per i batteristi.
L'aspetto artistico: la qualità più rara di Eicher ha a che fare con la percezione, l'esperienza reale, della manifestazione musicale, cioè con la capacità di sentire, oltre che ascoltare. Poi, volendo trovare un comune denominatore a tutto il mare magnum di artisti, linguaggi, idiomi e tradizioni diversi documentati in questi quarant'anni, credo che l'identità e la qualità del suono dell'artista sia una condizione rintracciabile in ogni strumentista che abbia collaborato con ECM. Non parlo naturalmente di "bel suono" nel senso più comune e superficiale, ma di identità-nel-suono. Magari musicisti completamente diversi nello stile e nell'estetica musicale, ma tutti estremamente identificati con la propria voce, il suono. Questa presenza "nel suono" comporta automaticamente, per complementarietà, un virtuosismo opposto a quello comunemente inteso, una ricerca a sottrarre per lasciare risuonare il già suonato, un amore per le note taciute pari a quello per le note suonate.
Potremmo individuare due grandi categorie tra tutti gli improvvisatori, a prescindere da stili e generi: i "saturatori dello spazio" e i "creatori dello spazio". Per motivi misteriosi i primi sono spesso riconosciuti come "virtuosi" e gli altri come "interessanti". Io invece considero virtuoso, oltre che interessante, chi riesce a creare uno spazio, piuttosto che a riempirlo, e sono certo che Eicher la pensa come me! Una volta Manfred mi parlò del progetto di un disco di Miles in chiesa con Jarrett all'organo, mai andato in porto: il suono e le pause di Miles in chiesa: perfetto!... l'avrei comprato subito! Ma queste, come ho detto all'inizio, sono solo chiacchiere. Piacevoli, ma chiacchiere.
AAJ: Uno degli aspetti che colpiscono maggiormente in The River of Anyder, il tuo ultimo lavoro proprio per ECM, è la cantabilità a tratti gioiosa delle esecuzioni. Come sei arrivato a combinare questa caratteristica con un altrettanto marcato senso di ricerca?
S.B.: Ho sempre dato molta importanza alla melodia, e non vedo ostacoli nell'incontrare gioia e cantabilità all'interno di un percorso di ricerca. Da sempre ho avuto bisogno di sentire elementi di canto nella mia musica, e sempre così sarà. Quello di cui avevo urgenza era di creare un contesto il meno possibile idiomatico, senza tempo, primitivo, in un certo senso: mi sono imposto di scrivere semplici canti e danze che non fossero influenzate da linguaggi moderni e sofisticati, ma che anzi, sarebbero potute esistere già mille anni fa, composte e suonate da musicisti remoti con strumenti arcaici.
Quando scrivo musica ho bisogno di inventarmi una disciplina attraverso la quale condizionare il processo creativo. Questo è un lavoro che vuole celebrare i luoghi dell'utopia attraverso la danza e il canto, nel loro significato più semplice e primitivo. Era importante per me ricordare a me stesso che, sebbene io sia un musicista-evoluto-del duemila che suona uno strumento sofisticato, la musica è sempre esistita ed è sufficiente un tamburo ed una voce per fare musica. Mi sono chiesto: " Posso farlo?".
La scelta di usare come evocazioni dei non-luoghi, per lo più creazioni irreali, città che-non-esistono, mi consente l'uso dell'immaginario, del misterioso, dell'illusorio, le influenze sono più sottili e immateriali, ciò che le abita sono figure paradigmatiche del sogno e dell'angoscia, del desiderio e delle inquietudini. Sono luoghi dell'immaginazione, non di rado luoghi impossibili, proprio come talvolta è la musica, quando è contaminata da tradizioni distanti per epifania geografica e temporale. Una sorta di enorme simulacro di idee, illusioni e miraggi, perfetto per combinare suggestioni musicali diverse. Nel corso degli ultimi anni ho scritto più di quaranta brani, semplici canti e danze ispirati ad altrettanti luoghi.
AAJ: Si avverte altresì un interplay tanto ferreo, quasi feroce, quanto leggero, impalpabile. Frutto di anni di comune frequentazione e condivisione, di una precisa strategia, o di... una formula magica ?
S.B.: Il Trio è in sé una formula magica, e a me, trovati i musicisti giusti, piace creare dei sodalizi, costruire una storia; so bene che per determinare identità serve tempo e pazienza, con Salvatore e Roberto esiste frequentazione e condivisione sin dagli anni che precedettero Re:Pasolini, e spero riusciremo a cambiare insieme nel tempo per andare sempre più in profondità.
Ricordo che ci incontravamo ovunque vi fosse un buon piano e suonavamo senza dirci nulla per tutto il giorno, improvvisando completamente. Ancora adesso, vita professionale a parte, è rimasta questa purezza nella ritualità del fare musica insieme. A volte penso addirittura che le composizioni che scrivo siano un ostacolo anziché un veicolo... La nostra volontà, evitando di paragonarla ad un'estetica, è quella di creare spazio senza saturarne la tridimensionalità, evitare il piano-centrismo del Trio classico e determinare degli equilibri più collettivi che si spostino continuamente, come in un prisma, sfruttando al massimo la polifunzionalità degli strumenti senza pre-visione e "arrangiamento".
AAJ: Anche The River of Anyder, come molti dei tuoi lavori, è ricco di riferimenti letterali e filosofici. Come intendi il rapporto tra musica, letteratura e, in generale, le altre forme d'arte?
S.B.: Credo che chiunque cerchi un senso riguardo al fatto di starsene per cento anni su di un pianeta a fare qualcosa, debba incontrare la filosofia. Una filosofia o tante filosofie. Di qualunque genere e tipo. Ha a che fare con il significato e la verità. Riguardo alle arti per me è tutto la stessa cosa, un'unica grande fonte. Amo la poesia e la bellezza in ogni sua forma, non ho alcuna ideologia di genere e di stile. Mi esalta l'espressione del sé, che sia attraverso la musica, la danza, la pittura o la gastronomia non fa differenza. Ho scelto la musica perché ho avuto l'opportunità di studiarla sin da bambino, ho sempre suonato e credo di avere dei talenti in tal senso, ma proprio per questo ci sono dei lunghi periodi nei quali non sento alcun bisogno di musica "dall'esterno," in aggiunta a quella che produco io quotidianamente. E temo che la bulimia musicale di chi tra i musicisti ascolta musica continuamente sia distruttiva da un punto di vista espressivo, che sia l'illusione di riempire un vuoto con un pieno che arriva dal di fuori.
Credo che sia molto importante, per chi si esprime attraverso una forma d'arte, proteggere e coltivare la propria unicità, diversità. Siccome non c'è dubbio che chi ha talento musicale rimanga molto influenzato da tutto ciò che ascolta e dunque lo abita, col tempo la mia scelta è stata quella di rinunciare alla cieca passione della curiosità e scegliere con grande attenzione la musica da "fare entrare in casa". Percepisco che questo a volte rischia di essere scambiato addirittura per snobismo e invece è il suo contrario, è la consapevolezza di una fragilità, di un equilibrio che necessita protezione, della coscienza che ascoltare musica senza reale desiderio è davvero superfluo e nocivo, è come mangiare senza appetito. Nonostante questo riconosco molto chiaramente le mie passioni musicali e ne vado orgoglioso, ma so che a quarant'anni è meglio non esagerare con il nutrimento esterno: la mia essenza, la mia unicità deve rimanere ben visibile per mantenere intatte le possibilità di essere autentica nella sua espressione, pregi e difetti. Questa è la stessa verità della quale ho bisogno io per primo come ascoltatore quando ascolto qualcun'altro esprimersi. Tendo allora a cercare continuamente altre forme di bellezza e poesia, per questo si trovano così tante evocazioni extra-musicali nei miei lavori. Tutto ciò che di poetico e lirico faccio entrare dentro di me finisce nella mia musica quanto la musica stessa farebbe, ma senza il rischio di snaturare la mia identità o contaminarmi stilisticamente: almeno non più di quanto io non lo sia già.
AAJ: Altro tipo di rapporto che da sempre costituisce un punto nodale della tua arte è quello tra scrittura e improvvisazione...
S.B.: Scrivo continuamente, ho sempre scritto tantissima musica, e ho accumulato una grande quantità di materiale, spesso in modo disordinato. Per questo negli ultimi anni ho disciplinato i periodi di scrittura attraverso dei "contenitori" precisi, quasi sempre extra-musicali. Ma nel tempo mi sono ritrovato piano piano a considerarmi sempre più un improvvisatore, un performer, più attratto dalla verità del momento presente che dall'interpretazione, dalla manifestazione che dalla rappresentazione. Ora, e da quasi vent'anni ormai, sono impegnato a eliminare ogni differenza tra queste due prassi. Ci stiamo lavorando, come si dice. L'obiettivo più esaltante e ideale per me è il processo di improvvisazione che impropriamente chiamo tabula rasa per definire l'assenza assoluta di musica pre-esistente, per descrivere lo "schermo bianco". Questa prassi, che negli anni è divenuta per me un vero e proprio metodo di lavoro, studio ed insegnamento, è una esperienza di reale composizione istantanea, e consente di utilizzare e combinare gli stessi principi narrativi e formali della composizione con l'urgenza espressiva e la verità della libera improvvisazione.
AAJ: Misticismo e spiritualità sono termini piuttosto ricorrenti nelle tue ultime produzioni. In che modo agiscono sul tuo processo creativo ?
S.B.: Sono due ambiti che non voglio mai confondere tra loro, sebbene siano naturalmente collegati ed io provi grande attrazione ed interesse per entrambi. La mistica mi attrae molto perché ha a che fare con il mistero (che dal greco si traduce mystikos, appunto). Ciò a cui non posso rinunciare della mistica è la contemplazione del sacro attraverso una esperienza diretta, non "teorica" e "astratta". Sebbene sia un ambito che si occupa dell'oltre, fuori dal pensiero logico, questa sensazione dell'esperienza diretta e tangibile della vita soprasensibile è uno degli aspetti più importanti della mia vita di musicista. Non è la musica stessa un grande mistero, in fondo? Dalla musica noi possiamo rivelare o scoprire la "verità ultima" dell'individuo, attraverso un progressivo distacco delle conoscenze sensibili e razionali: un processo spontaneo di spossessamento del sé.
Diverso invece il discorso della spiritualità, che è così ampio e impervio che mi consiglia di limitarmi a dire che tutto ciò che non è materia, o evidenzia una distanza da essa, mi attrae, e dunque ogni cosa che ha a che fare con lo spirito e l'espansione interiore dell'individuo suscita il mio interesse. In fondo si può definire spirituale addirittura tutto ciò che collega in modo immateriale l'essere umano; la musica è per me da molti anni il mezzo privilegiato per ottenere questo processo, che come in un cerchio che si chiude è la ragione ultima per la quale sono un musicista.
AAJ: Il piano-trio è una delle formazioni più classiche nell'ambito della musica jazz e forse per questo tra le meno soggette a trasformazioni epocali o clamorose evoluzioni. In che direzione sta andando il piano trio di Battaglia?
S.B.: La parole chiave per qualsiasi forma d'arte, specialmente oggi, è: verità, somma ed equilibrio di autenticità e unicità. Inutile dire quanto il Trio rappresenti per me Salvatore e Roberto, essendo una formazione classica all'interno della quale ognuno di noi ha ascoltato per anni i "suoi eroi": in questo senso potrei sbilanciarmi e dire di aver raggiunto, in modo sufficientemente rapido e naturale, un'identità inconfondibile, realmente autonoma rispetto ai grandi Trio del passato e del presente. Sebbene sia anche doloroso per certi aspetti, credo sia decisivo conquistare un senso di leggerezza e distacco verso le varie tradizioni del Trio. Da cui la mia scelta di rinunciare quasi del tutto all'idioma jazzistico e ai suoi "stili imperanti," senza rinunciare al "jazz" e alla "jazzisticità" come modus operandi di improvvisatori e come ricerca costante di una certa urgenza, "temperatura" espressiva.
Tecnicamente parlando credo che il parametro musicale sul quale abbiamo più lavorato nel senso del distacco sia quello armonico, per questo ora sono più vicino a delle tessiture armoniche più semplici e vuote, aperte ed ambigue, più influenzate dalla tonalità pura europea o dalle modalità delle tradizioni del mediterraneo. Oppure, per contro, a soluzioni più complesse provenienti dalle musica europea dei due dopoguerra, con l'estensione della politonalità da un lato e le dissoluzioni cromatiche e timbriche dall'altro. L'Italia come sappiamo è un luogo magnifico per geografia, e le possibilità reali di ricevere contemporaneamente influenze dalla mitteleuropa, dal mediterraneo (dal ceppo arabo-andaluso, da quello greco-bizantino) e dall'est balcanico, sono una straordinaria sorgente culturale che ci rende potenzialmente unici, specialmente se come improvvisatori trasformiamo queste contaminazioni in senso attivo e propulsivo, non imitativo. Che è per me il modo più responsabile e gioioso per armonizzarsi con il passato inserendosi nel processo di continuità e movimento delle tradizioni, cercando umilmente di creare un contributo di autentica unicità.
AAJ: Una sostanziosa discografia ti ha portato a utilizzare diversi tipi di ensemble in differenti ambiti musicali. Ce n'è uno in particolare con il quale riesci ad esprimerti in maniera completa e assoluta e che rispecchia maggiormente la tua personalità ?
S.B.:Il piano solo, naturalmente. Ma chissà quanto ego e narcisismo c'è in questa risposta, perché il fatto di esprimersi in maniera completa ed assoluta non significa automaticamente produrre musica migliore. Perciò, sebbene sembri sempre così difficile trovare i partner perfetti, è importante anche dialogare, rinunciare a delle parti di sé, considerare altre estetiche, cercare di armonizzare le proprie esigenze individuali con quelle di altri, constatare che a volte dal compromesso nasce una musica che rappresenta meno il sé ma proprio per questo possibilmente ha più valore, perché condivisa e da solo non potresti crearla. E' la vita, si dovrebbe dire.
AAJ: Per concludere un pensiero alle nuove generazioni. Sei un apprezzato docente, qual è il suggerimento più importante che si può dare ad un giovane che vuol fare della musica la sua professione?
S.B.: Oggi chiunque può fare il musicista, intendo dire professionalmente parlando: è una scelta che vuole una determinazione quasi feroce, qualche talento e un po' di fortuna. Ma chi è musicista e capisce di volersi esprimere attraverso la musica paradossalmente non può scegliere, sarebbe come privarsi di una funzione vitale, e semmai ha il compito difficile di proteggere la sua verità e coltivarla nel desiderio, col desiderio di esprimerla. Questo desiderio di essere attraverso la musica è la cosa più importante, senza di esso la musica è solo un bel mestiere. C'è una zucca vuota in una stanza: "Cosa posso fare? Posso fare musica, esprimermi attraverso di essa? ". Chi è musicista non ha bisogno di tanti consigli, nemmeno di tante informazioni: sente ciò di cui ha bisogno, anche di quali maestri. Ciò che dico sempre ai giovani è: " Non inseguite tutto. Tutto è niente ". Non è più il momento della curiosità, come poteva essere sino a prima della globalizzazione.
Come si fa a proteggere identità e fiducia in sé in una civiltà nella quale tutto è collegato superficialmente con tutto? Addirittura il gusto e le idee faticano ad avere un'identità, è sempre più difficile sentire dei giudizi chiari, dei pensieri autonomi, delle direzioni precise. Proteggete i vostri piccoli spazi, i vostri cento dischi preferiti, sceglieteli, ascoltateli un milione di volte (ben diverso dall'avere un milione di dischi ascoltati una volta!). Non fatevi sopraffare dalla curiosità, non subite passivamente il mercato, o secoli di didattica approssimativa e accademie generaliste. Sceglietevi i maestri, ascoltate la vostra voce, suonate tutto il giorno, imparate ad ascoltare i suoni degli altri, accettate i vostri limiti e coltivate i talenti, costruendo discipline e metodi nel modo più duro, gioioso e autonomo possibile.
Foto di Davide Susa (la prima), Claudio Casanova (la seconda, la quarta e l'ottava), Aldo Venga (la seconda e la sesta), Danilo Codazzi (la quinta) e Roberto Cifarelli (la settima).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.