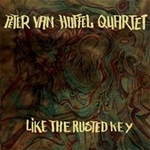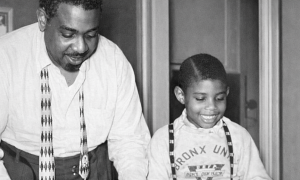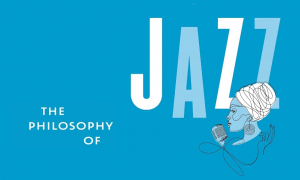Home » Articoli » Interview » David Sylvian: Spalancare il cuore
David Sylvian: Spalancare il cuore
Ci sono artisti che non vogliono assolutamente rischiare e lasciare la via vecchia per la nuova, ma David Sylvian non è uno di questi. Nel corso della sua folgorante carriera, Sylvian ha sempre cercato di trascinare i suoi ascoltatori fuori dai percorsi battuti. L'autoconsapevolezza e l'introspezione permeano ogni aspetto del suo lavoro. I suoi pezzi più avvincenti hanno toccato argomenti come la ricerca della spiritualità e del senso della vita nel mondo d'oggi. I suoi lavori sono fragili ed evocativi, e mettono l'ascoltatore di fronte alle sfide di ogni essere umano.
Negli anni Ottanta David Sylvian ha raggiunto la notorietà con la sua band glam-rock, i Japan, che ha sciolto all'apice del successo nel 1984. La fine della band ha coinciso con la rinascita di un artista che si lanciava in una nuova avventura partendo da una visione molto personale. Sin dall'album dell'esordio solistico, Brilliant Trees, Sylvian si è costruito una carriera notevole, basata sulla sua voce profonda e vibrante arricchita di magie compiute in studio.
Gli album seguenti, come Gone to Earth, Secrets of the Beehive, Plight and Premonition, Flux + Mutability, Rain Tree Crow (che ha visto il temporaneo ricongiungimento della sua band precedente, i Japan), The First Day, e Dead Bees on a Cake, sono stati semplicemente brillanti.
Sylvian prospera proprio cambiando frequentemente direzione. La sua produzione, sia come leader sia come collaboratore, attraversa svariati universi musicali, inclusi il Jazz, il Pop, il Soul, la musica etnica, il Progressive, la musica elettronica e quella d'avanguardia. I valori espressi nei suoi album, così come i collaboratori di cui si è avvalso, sono di altissimo livello: Holger Czukay, Ryuichi Sakamoto, Jon Hassell, Evan Parker, Bill Frisell, Marc Ribot, Bill Nelson, Robert Fripp, Mark Isham, Michael Brook, Arve Henriksen e Derek Bailey.
Gli album di Sylvian declinano in modo unico il rapporto tra le arti visive e quelle acustiche. Essendo anche un pittore, conosce molto bene l'impatto che una copertina può avere sulla percezione della musica. Le copertine dei suoi dischi sono molto più che mera decorazione del disco, e alla loro realizzazione hanno contribuito artisti del calibro di Russell Mills, Ian Walton, Anton Corbijn, Yuki Fuji, Charles Lindsay, Shinya Fujiwara, Atsushi Fukui e Ruud van Empel.
Per la maggior parte della sua carriera, Sylvian ha registrato per la Virgin, e questo sodalizio è terminato nel 2000 lasciandoci due meravigliose raccolte: Everything and Nothing, una raccolta di brani vocali, e Camphor, una raccolta di brani strumentali. Entrambe rappresentano sintesi uniche della sua carriera, e ci restituiscono un vivido ritratto di un artista.
Nel 2003 Sylvian ha creato un'etichetta, la Samadhisound, nella quale la musica e l'arte coesistono in armonia. Oltre ai suoi lavori da solista, questa etichetta ha avuto il merito di supportare artisti come Harold Budd, David Toop, Akira Rabelais, Steve Jansen (il fratello di Sylvian), Sweet Billy Pilgrim, Thomas Feiner & Anywhen. Il primo disco prodotto dalla sua etichetta è stato Blemish, un album costituito solamente da improvvisazioni. A breve ha fatto seguito un album di remix, Good Son vs. Only Daughter, quindi Snow Borne Sorrow dei Nine Horses (una collaborazione tra Sylvian, Steve Jansen e Burnt Friedman), Money for All e Manafon.
Incredibilmente, dopo aver dato vita a diciotto album in studio nell'arco di quasi trent'anni, David Sylvian non accenna in alcun modo a rallentare. Il suo disco in studio più recente, Manafon, è senza dubbio uno dei più audaci. Manafon è un disco di pura improvvisazione, realizzato da gruppo di improvvisatori stellare. Il risultato è un disco che offre trame particolari ed inusuali, nelle quali la musica e la voce si scontrano e si intrecciano magnificamente, sebbene provengano da due mondi totalmente diversi.
Dopo trent'anni di carriera, David Sylvian riesce ancora a fare la musica che vuole lui. E, come tutti i grandi artisti, fa della musica che solo lui può fare.
All About Jazz: Molti anni fa hai voltato le spalle alla fama e al successo, e sei sopravvissuto. Anche se non conduci una vita da pop star e custodisci la tua vita privata come tale, vendi ancora moltissimi dischi. Ai concerti fai il tutto esaurito. Hai ancora uno zoccolo duro di fedelissimi fan, là fuori. Qual è il tuo rapporto con il pubblico? .
David Sylvian: Posso provare ad interpretare solo in parte i desideri del mio pubblico, così come potrebbe riuscirci chiunque altro osservi la situazione da vicino. Alcuni di essi hanno intrapreso insieme a me il lungo viaggio dalla notorietà del periodo pop ad oggi. In un certo senso siamo maturati insieme. Potresti voler ammettere che, quantomeno per quanto riguarda la sfera musicale, è stata una bella sfida. Altri ti seguono in modo selettivo, secondo le loro preferenze, magari prediligono l'aspetto vocale e non quello strumentale (o, ma è un caso raro, vice versa). Altri vengono stuzzicati e incuriositi da un brano in particolare. Incontro il pubblico faccia a faccia (e senza presunzione dirò che è il 'mio' pubblico) nell'arena dove tengo il concerto. E da questo punto di vista l'ho sempre trovato il pubblico più generoso, rispettoso e piacevole che un artista possa sperare di incontrare. Più di questo, non so che altro dire.
AAJ: La musica che crei ha una bellezza che dura nel tempo, e dice molto di te. Cosa vorresti che le persone prendessero, dalla tua musica? Che tipo di risposta, di sentimento, speri che scaturisca da chi ti ascolta?
D.S.: Più volte ho detto che vorrei riuscire a spalancare il cuore dei miei ascoltatori. Con ciò voglio dire che vorrei che si abbandonassero complrtamente. Sarebbe bellissimo, una cosa ideale, ma forse mi aspetto troppo. Almeno vorrei che il mio lavoro risuonasse nella vita degli altri, ecco, questo forse è un desiderio più facile da realizzare.
AAJ: Le copertine dei tuoi album sono come una mostra d'arte, con lavori di Russell Mills, Anton Corbijn and Yuka Fuji. Essendo tu stesso un pittore ed un fotografo, cosa pensi che le copertine diano in più al disco?
D.S.: la copertina può entrare in risonanza, stabilire un dialogo con la musica, forse spiegarla? Se non altro, allude al contenuto dell'album.
AAJ: Puoi descrivere quell'incrocio filosofico dove, secondo te, arte e musica si incontrano?
D.S.: Non credo ci sia un solo punto di incontro, ma molti. In parole povere, nel regno del cuore, o forse dovunque si imbatte in una qualunque verità.
AAJ: Riesci a confrontare la catarsi creativa che provi quando finisci un tuo lavoro musicale con quella che si verifica quando completi un'opera d'arte visiva?
D.S.: È solo nel comporre musica che riesco ad essere abbastanza espressivo da raggiungere ciò che si potrebbe definire uno stato di catarsi. Con l'espressione visiva riesco a raggiungere un livello comparabile.
AAJ: Pensi che l'affermarsi del download della musica digitale abbia un impatto significativo sull'importanza delle copertine?
D.S.: Sì, certamente. Ma questo cambierà ed evolverà in modi che si riveleranno interessanti ed appaganti. Mi aspetto che la componente visiva diventi più elaborata, parte integrante di un'esperienza complessiva. Quando il prodotto fisico sarà quasi obsoleto, ci saranno sviluppi inaspettati in quest'area. Il download digitale elimina anche il concetto di formato. Come compositori, siamo liberi di offrire lavori che non vengono definiti dal mezzo, e quindi possiamo offrire pezzi che durano letteralmente pochi secondi o pezzi che possono durare ore, o addirittura durare per sempre.
AAJ: Quale è stata la genesi e il processo creativo del nuovo disco, Manafon?
D.S.: È la continuazione dell'approccio intrapreso con l'album Blemish, che prevedeva momenti di improvvisazione accompagnati da un processo di composizione automatica. L'ho rielaborato aggiungendovi il contributo di ensemble più ampi, registrati dal vivo in studio sia in Europa che in Giappone. All'inizio non sapevo né se né come avrebbe funzionato in pratica. Ma dopo le prime sessioni, che furono registrate a Vienna nel 2004, e che hanno dato vita ai brani che si possono trovare in Manafon, capii che avevo scoperto una simbiosi che poteva portare a risultati affascinanti. Quella prima sessione andò avanti per sette giorni e mezzo. Fu un notevole lavoro di esplorazione, allora.
Potemmo cogliere molte splendide improvvisazioni ma dato che stavo cercando qualcosa di specifico, qualcosa che non riuscivo a far capire a parole ai musicisti coinvolti, dovevo incoraggiarli o cercare di persuaderli, dare suggerimenti e spunti, aggiungere e togliere elementi per cambiare la chimica dell'ensemble, finché potei udire ciò che stavo cercando. Accadde nel settimo giorno di sessioni, nell'ultimo giorno di lavoro. A quel punto l'ensemble era un quartetto, composto da Werner Dafeldecker al contrabbasso, Michael Moser al violoncello, Christian Fennesz alla chitarra e al computer e Keith Rowe alla chitarra. Per me si tratta di una forma di moderna musica da camera.
Quando ho capito che la cosa aveva funzionato, nelle sessioni successive mi sono concesso meno tempo per arrivare al risultato finale. Nel 2006 a Tokyo è stata questione di un giorno, così come a Londra nel 2007. Lavoravo alla stesura e alla registrazione delle parole e della melodia vocale in un secondo tempo, talvolta persino un anno dopo aver eseguito le registrazioni iniziali. Ciò ha restituito alle sessioni di scrittura la loro spontaneità e freschezza, dato che era come sentire il lavoro per la prima volta (compivo una prima selezione dei brani che secondo me andavano bene poco dopo aver fatto le registrazioni originali).
Riproducevo una delle improvvisazioni e cominciavo a scrivere. Dopo poche ore, il testo era completo, composto insieme alla melodia, e si collegava a precisi accordi che identificavo nell'improvvisazione. Registravo la parte vocale al momento, e quindi c'era poco tempo per ripassarla. Questo è quel che intendo per processo di scrittura automatica. Si trattava di seguire il processo, la disciplina, e assecondarla finché mi sembrava completa. Il processo è pervaso da una rapidità che lo fa sentire urgente, decisivo ed emotivamente in sintonia con lo spirito dell'improvvisazione originale.
AAJ: Che cosa significa la parola "Manafon"?
D.S.: Mi ci sono imbattuto studiando la vita e le opere di R.S. Thomas. È il nome di un villaggio in Galles, il luogo dove si trovava la prima parrocchia di Thomas e dove scrisse i suoi primi tre volumi di poesie. Col tempo, la parola è diventata per me sinonimo di immaginazione poetica, di mente creativa, di fonte perenne; da qui la copertina del CD; che rappresenta un improbabile idillio. Un posto dove la conoscenza intuitiva scivola nel flusso dell'inconscio.
AAJ: Cosa ti ha spinto a tornare di nuovo alla libera improvvisazione, dopo aver lavorato con i Nine Horses alla coppia di album Snow Borne Sorrow e Money for All?
D.S.: Ho cominciato a lavorare a quello che sarebbe diventato Snow Borne Sorrow prima di cominciare a lavorare a Blemish. Una volta completati sia Blemish sia il relativo tour, io e Steve continuammo a lavorare sulle canzoni che avevamo scritto, ed io cominciai a scriverne delle altre con Burnt Friedman, che incontrai durante il tour di Blemish. Così col tempo, come è stato scritto altrove, da questi progetti gemelli sono nati i Nine Horses. Più o meno a metà di quell'avventura avevo già registrato la prima delle sessioni per Manafon. Così per un bel po' di tempo ho portato avanti due progetti simultaneamente, anche se separati tra loro. Non è una questione di abbandonarne uno a favore dell'altro. Non vedo alcun conflitto nel volerli conseguire allo stesso tempo. Gli obiettivi che ci eravamo posti come Nine Horses non erano gli stessi che volevo perseguire con il mio lavoro da solista. E voglio continuare ad applicare questo tipo di diversificazione alle mie attività.
AAJ: L'edizione deluxe di Manafon contiene un documentario intitolato Amplified Gesture, che riporta interviste rilasciate da chi ha preso parte alla realizzazione del nuovo album sul tema dell'improvvisazione. Ci racconti qualcosa a riguardo?
D.S.: Avendo completato Manafon e avendo passato del tempo con persone notevoli, che avevano deciso di seguire una via musicale per così dire meno battuta, pensai che sarebbe stato interessante, forse importante, documentare le opinioni di questi musicisti riguardo la loro formazione, la relazione che avevano con i loro strumenti, cosa li avesse portati da un tipo di musica ad un altro fino a trovarsi a lavorare nell'area nota come libera improvvisazione. Un'introduzione alle filosofie che stanno alla base del loro lavoro, alle persone dietro alla musica. Da quel che sapevo, era una cosa mai tentata prima, il che mi parve una grave omissione. Una colpevole mancanza, in termini di scarsità di materiale disponibile su questi temi. L'ho pensata come una guida introduttiva, un invito a frugare a fondo nella quantità di materiale che questi professionisti avevano prodotto in decenni di impegno.
AAJ: Prova a descrivere l'approccio complessivo che hai utilizzato per realizzare Blemish. Se gli elementi fondanti del disco precedente, Dead Bees on a Cake, erano l'amore, la devozione e l'intossicazione spirituale, pare di capire da precedenti interviste che i temi di Blemish siano per te elementi negativi.
D.S.: Disillusione, conflitto, isolamento, tradimento, fino ad arrivare all'odio... tutto il peggio, insomma!
AAJ: Quali sono i contrasti concettuali tra Blemish e i tuoi altri album da solista?
D.S.: Il contrasto più evidente e significativo è forse l'approccio seguito nello scrivere e nel registrare. In effetti è stata una cosa simultanea, una serie di improvvisazioni eseguite in pochissimo tempo, che includono la scrittura del testo e la sua esecuzione prima che si asciugasse l'inchiostro. Tutto fatto al momento. Aggiungi il fatto che ero letteralmente, completamente, solo per tutte e sei le settimane di sessione, e penso che tu possa cominciare a capire la differenza di creare questo disco rispetto ai precedenti. Un altro aspetto è la forma aperta che di recente hanno assunto molte delle composizioni. Strutturalmente sono molto lasche, non ci sono mai più di due cambi di accordo in ognuna di esse. Essenzialmente sono pezzi basati su un suono ripetuto, il che mi permette di lavorare come paroliere e come vocalist in modo abbastanza libero.
AAJ: Come descriveresti il genere di storie raccontate dai tuoi dischi? Ti senti a tuo agio quando, partendo dalle tue esperienze personali, ti trovi a doverle esporre?
D.S.: Rispondo intanto alla seconda domanda: questo è fondamentale per me. È una cosa necessaria, che non si discute. Però talvolta mi sento a disagio nel dover parlare durante un'intervista del contenuto di un album, perché è una cosa così intrinsecamente personale. Per uno che si espone così tanto nel suo lavoro, penso di avere il diritto di proteggere la mia vita privata per quanto possibile.
Non so come rispondere alla prima parte della domanda. O rischio di non essere del tutto oggettivo nella descrizione, o non riesco a dare una risposta semplice. Dovrei sfogliare i libretti dei CD pagina a pagina, per poter descrivere la differenza di approccio tra un insieme di canzoni e un altro.
AAJ: The Good Son è composto da brani di Blemish, remixati e modificati da altri. In passato non lasciavi che altri modificassero le tue canzoni (come accade oggi). Nel genere, c'è anche il rifacimento di Darshan (brano di Sylvian e Robert Fripp) eseguito dalla FSOL qualche anno fa, che è stato grande ed insolito. Cosa pensi della cultura di oggi, dove tutto è reinterpretato, rifatto e riciclato? Cosa pensi dei remix?
D.S.: In generale, non mi interessa. Come hai detto, la Virgin ha commissionato alcuni remix del mio materiale, e non mi è mai importato nulla del risultato, a parte il Wagon Christ remix di Godman fatto da Luke Vibert, perché è stata una mia libera scelta.
Non voglio entrare nell'argomento remix, che è stato solo uno strumento di marketing nelle mani delle case discografiche per tentare di dare ad un brano una parvenza di appartenenza a diversi generi; ma come molti professionisti ti diranno, un remix non è altro che un lavoro che ti viene commissionato per un compenso vergognosamente alto. Forse qualcuno li apprezza. Io non ho mai comprato un album remix perché ho sempre pensato che le intenzioni dell'artista sono espresse chiaramente nel lavoro originale, e quel che viene dopo è comunque secondario, nella migliore delle ipotesi, e guidato da necessità commerciali, quindi un volgare sfruttamento, nel peggiore dei casi. Da quel punto di vista, penso che Blemish rappresenti un'anomalia per me.
AAJ: Quale era lo scopo di fare un album remix?
D.S.: Secondo me la maggior parte del materiale di Blemish era infinitamente malleabile, e volevo vedere cosa altri artisti, che rispetto, ne avrebbero fatto. È stato un banco di prova per potenziali collaboratori futuri, come Burnt Friedman, che fece un paio di remix per me prima che cominciassimo a scrivere insieme il materiale che sarebbe diventato Snow Borne Sorrow. Ci sono alcuni artisti straordinari che riescono a rielaborare in modo davvero ispirato quello che gli viene presentato da remixare. Quando il remix non vuol dire 'prova a renderlo più interessante per un pubblico più vasto,' la probabilità di ottenere un risultato creativo cresce notevolmente. Ryoji Ikeda ha fatto un paio di remix per me, e la sua versione di The Only Daughter è davvero notevole.
AAJ: Come hai scelto il gruppo di artisti che ti hanno aiutato a rielaborare il materiale?
D.S.: Ero già in contatto con tutti loro, per un motivo o per l'altro. Tutti candidati potenziali per un lavoro d'equipe.
AAJ: Il singolo World Citizen esprime il tuo punto di vista ed il tuo atteggiamento nei confronti della politica mondiale. C'è una componente politica nella tua musica?
D.S.: Per come la vedo, tutta la musica ha una componente politica, perché agire con successo da catalizzatore per cambiare il cuore o la mente di una persona è un atto politico. Talvolta affronto i temi politici direttamente, altre volte meno. Si può usare una canzone famosa come un podio da cui parlare, ma non mi piace abusane, perché penso che così si compromette quel potere di scavare a fondo nel subconscio che è insito nella musica.
AAJ: Sei stato protagonista di molte installazioni audio-visive, di cosiddetta arte sonora, come Ember Glance e When Loud Weather Buffeted Naoshima. Cosa ti ha portato a lavorare in questo ambito? Ci parli del lavoro a Naoshima?
D.S.: Le installazioni erano un altra esperienza con la quale esplorare interessi consolidati seguendo delle specifiche linee guida che potrebbero o dovrebbero risultare impegnative, portando potenzialmente a certe soluzioni che aiutino a sviluppare questi tipi di lavori in direzioni nuove ed interessanti.
La Benesse Foundation mi ha commissionato la realizzazione di un lavoro per il festival Standards 2 appena sono atterrato sull'isola. Ciò mi ha consentito di esplorare il paesaggio avendo in mente il potenziale ingaggio. Il piano prevedeva che il pubblico, raggiunti gli uffici della Fondazione, ricevesse un iPod con il quale esplorare i villaggi circostanti, i musei e le 'case d'arte' mentre godeva dell'accompagnamento audio. In effetti, voleva essere un lavoro che legasse questi elementi contrastanti in qualche modo. Tentai di creare qualcosa che aumentasse la consapevolezza di altre dimensioni della realtà e allo stesso tempo adulasse, contrastasse ed estendesse la dimensione che era disponibile al momento. Un'esposizione multipla, una stratificazione ed un tracciamento di punti di riferimento sia reali, sia immaginari. Il loud weather del titolo si riferiva alla vita emotiva dell'isola, che veniva lodata grazie al suo passato spirituale ed alla sua influenza sulla vita di ogni giorno. C'è un riferimento ripetuto al lavoro, alla sfida creativa, una affermazione della vita o della sua possibile futilità. E ci sono i paesaggi associativi (ad esempio, il paesaggio Francese del primo Novecento di Monet allestito sotto il suolo di Naoshima) che creano una rete di connessioni più ampia da ogni parte del mondo, alludendo ad una più grande abbondanza di risorse e di scambi culturale. Su tutto soffiano i venti che impollinano, purificano e sradicano, vivi insieme alle voci delle generazioni... L'intenzione era che il volume fosse tenuto molto basso, così che i rumori dell'ambiente si fondessero con gli elementi registrati.
AAJ: Dead Bees on a Cake è un disco totalmente diverso. È stato difficile far andare d'accordo la miriade di differenti influenze che lo pervadono?
D.S.: Sentivo che queste composizioni si appartenevano a vicenda. Trattavano problemi simili, erano state create con lo stesso spirito nel medesimo periodo. Il materiale non mancava e alla fine la decisione di cosa includere nell'album mi apparve ovvia. E neanche dare un ordine ai brani è stato un problema.
AAJ: Il tuo interesse nella cultura orientale è ben radicato ed evidente. Ed elementi di spiritualità Orientale sono presenti nel tuo lavoro. Quanto ti identifichi con queste tradizioni? Anche la musica Orientale — specialmente quella indiana — sembra essere uno dei fattori che più ti influenzano. Quale aspetto di questa musica è per te il più affascinante?
D.S.: Seguo alcune pratiche e discipline dell'Induismo e del Buddismo, quindi la risposta ovvia è che mi identifico in modo fondamentale con queste tradizioni. Anche se è stato un processo graduale; all'inizio non mi trovavo completamente a mio agio, ma le ho fatte mie con il passare del tempo. Non posso dire che la musica Orientale faccia presa su di me in modo particolare. Sono stato esposto a molta musica devozionale Indiana negli ultimi nove anni, e l'ho assorbita e digerita pian piano. Ho apprezzato lo spirito vivido della musica devozionale (ascoltandola dal vivo piuttosto che registrata) e mi ha toccato nel profondo. Comunque, sarebbe sbagliato dire che ne sono attratto, così come da qualunque altra musica orientale, rispetto ad altre.
AAJ: Quanto è importante la spiritualità per te e per la tua musica?
D.S.: Non può essere altro se non fondamentale per la mia vita, e quindi per il mio lavoro.
AAJ: Sei applaudito sia per il tuo lavoro in gruppo sia come solista. Hai lavorato con musicisti di avant/jazz di prim'ordine: (Czukay, Fripp, Hassell, Ribot, Sakamoto, eccetera). Il fatto di lavorare con questi straordinari artisti ti ha dato la sensazione di poter sfidare e superare le tue stesse doti di compositore ed arrangiatore?
D.S.: Mi piacciono le sfide, ed è qualcosa che spesso cerco nei miei collaboratori. Ma in fin dei conti, come compositore cerchi semplicemente di fare il tuo lavoro, tutto qua. Sono stato fortunato, come dici, a lavorare con musicisti di talento, ma tendo a considerare la composizione dal punto di vista del creatore. Tento di darle vita e di darle sostanza.
AAJ: la tua collaborazione con Holger Czukay ha dato vita ad alcuni dei più interessanti album ambient. Qual è l'idea di fondo di questi due album?
D.S.: Il primo dei due album, Plight and Premonition, non era stato pianificato, quindi se c'era un'idea dietro, questa si sviluppò solo durante la registrazione del materiale. Holger mi aveva invitato a Colonia per registrare un pezzo vocale per un brano su cui stava lavorando. Ma quando arrivai allo studio la prima sera, accadde qualcosa di totalmente differente da quello che mi ero aspettato. Al Can studio c'erano strumenti piazzati per tutta la sala (un cinema in disuso). Mi misi all'armonium e Holger cominciò a registrare a mia insaputa. E così ebbero inizio le sessioni per Plight and Premonition. Nel corso di quella serata registrai una serie di improvvisazioni su diversi strumenti. Con il progredire del lavoro, apparve chiaro che non si era trattato di una performance, ma piuttosto di una registrazione pirata, fatta mentre gli strumenti stessi riverberavano in quell'ampia sala. Holger ebbe il merito di registrarmi mentre cercavo me stesso in tutti quegli strumenti. Non appena sentivo di aver sviluppato qualcosa degno di essere registrato, il momento era già trascorso, e andavamo avanti. Abbiamo provato a ritrovare lo spirito di quelle sessioni in seguito, quando registrammo Flux and Mutability, ma non riuscimmo a produrre ciò che era stato creato così intuitivamente creato la prima volta.
AAJ: Negli anni ti sei proposto sia come autore che come cantante in diverse situazioni e generi, oltre le tendenze del momento. In generale, la musica elettronica viene presa molto meno sul serio dal grande pubblico rispetto a quella fatta per gli strumenti acustici. Quando componi, qual è l'equilibrio tra sentimento e tecnologia?
D.S.: Sono sicuro che non è più come dici. L'uso dell'elettronica in musica è accolto sempre più, e penso che siano in pochi, qualunque sia il genere musicale, a rifiutare l'elettronica a priori. D'altronde anche le registrazioni più 'naturali' usano tecnologie molto avanzate oggigiorno. Per me la tecnologia è uno strumento come un altro. Si lavora al servizio della composizione, e si usa qualunque cosa le sia di beneficio. Certo solo un purista o un Luddita rifiuterebbero l'elettronica per principio. Tutte le opzioni vanno considerate quando si lavora. E queste si assottigliano appena riesci a definire il carattere del lavoro in tutto e per tutto, compresa la sua identità sonora.
AAJ: Come ricordi l'esperienza di The First Day? Che sfide hai dovuto affrontare, dal punto di vista del suono, lavorando in questo formato?
D.S.: Per me si è trattato di far convivere la voce in un contesto di musica dominata dalla chitarra. Come puoi sentire, abbiamo dovuto lavorarci su un bel po' per farla emergere dalla mischia. Ho abbandonato la sessione per una settimana durante le registrazioni perché le cose non stavano andando come avrei voluto. Pensai che fosse il caso di lasciare Robert (Fripp) da solo al timone per un po.' Tornai dopo due settimane, e alcune tracce di base erano state registrate, ma il suono era troppo denso, non lasciava respirare. E a peggiorare le cose c'erano troppi overdub di chitarra e di batteria. Ci volle un bel po' di lavoro per sistemare il materiale al mixaggio. E al momento di fare il master stavo ancora lavorandoci per migliorarlo. Assolutamente non un buon segno, questo! Riguardo l'esperienza in generale, mi è piaciuto molto andare in tour con Robert. Con lui il materiale sembrava prendere vita. Avevamo passato entrambi momenti difficili. La sua presenza nella mia vita è stata davvero positiva.
AAJ: Guardando i vecchi progetti, vorrei chiederti qualcosa su Rain Tree Crow. Come vedi la sua musica da questo punto di vista?
D.S.: Non ho ascoltato l'album nel suo insieme da quando è stato completato, ma ero soddisfatto di parecchi elementi di quella particolare collaborazione. La maggior parte del lavoro era nato sull'improvvisazione, ma molto era stato raffinato e rielaborato a lungo, anche se le registrazioni finali contengono ancora elementi e semi delle improvvisazioni originare dalle quali sono cresciute. Se le relazioni personali lo avessero consentito, penso che tutte le persone coinvolte avrebbero previsto che il progetto si sarebbe sviluppato in due o tre album, forse con l'aggiunta di materiale dal vivo.
AAJ: La vita è piena di discussioni e politica, tuttavia i contrasti possono produrre dei brani immortali. Per te la tensione agisce da catalizzatore creativo?
D.S.: Una volta avrei risposto di no, ma ho accettato i conflitti come parte integrante della vita al punto da cercarne le radici nella mia scrittura, senza sentire il bisogno di risolverli precisamente.
AAJ: Oltre alle due raccolte, Everything and Nothing e Camphor, sia i tuoi lavori da solista che del materiale prodotto con la vecchia band sono stati ripubblicati più volte. Il materiale aggiuntivo delle riedizioni è contenuto nel tuo cofanetto Weatherbox. Dato che ci sono state molte voci sulla riedizione di questo cofanetto, questo è stato il solo modo di ripubblicarne il materiale?
D.S.: Non è vero che tutto il materiale aggiuntivo di queste riedizioni era presente anche nel cofanetto Weatherbox. Parte del materiale disponibile nelle riedizioni è inedito. Riguardo la riedizione di Weatherbox, qualcosa che la Virgin/EMI era interessata a fare. Personalmente pensavo che non fosse una buona idea. Per fortuna non riuscirono a trovare la copertina originale, così accantonarono il progetto. Le riedizioni erano pensate per essere indipendenti dal cofanetto. Infatti, Virgin/EMI sta ancora discutendo la possibilità di creare un nuovo cofanetto.
AAJ: A proposito della pubblicazione di lavori non più in commercio, si trova in giro parecchio materiale pirata, sia audio che video. Diverse band hanno pubblicato molto materiale dai loro archivi (principalmente cose dal vivo) per arginare il fenomeno. Hai in mente di pubblicare nuovamente vecchio materiale, video, audio o libri, (cose come Preparations, Steel Cathedrals, Trophies Vol.1, Polaroids, eccetera) in un prossimo futuro?
D.S.: Non mi piace l'idea di essere costretto a riciclare materiale che, secondo me, ha fatto il suo tempo solo per far contenta l'industria della pirateria. Se però ci fosse una effettiva richiesta, e se sentissi ancora un legame con quel materiale, non sarei contrario a ripubblicare certe edizioni. Ma per ora non ci sono piani in proposito.
AAJ: Nel 2003 hai fondato la tua casa discografica, la Samadhisound. Come si è sviluppata questa etichetta dall'idea iniziale a ciò che è oggi?
D.S.: La Samadhisound è nata quasi di sua spontanea volontà. Non avevo previsto di fondare e gestire un'etichetta, ma mi è piaciuto molto essere coinvolto nella Samadhisound. Ci sono stati momenti in cui ho lottato per la sua sopravvivenza perché eravamo giunti al punto di porne le basi fondanti, e sembrava prematuro lasciar andare l'impresa. Detto ciò, vediamo che sia gli affari sia i media cambiano rapidamente, e le vendite sono in calo. Se non fosse stato per il duro lavoro di poche persone in gamba, l'etichetta non avrebbe potuto esistere come piattaforma per tutto questo tempo. Tenendo presente tutto ciò, mi limito a guardare l'anno in corso. Penso che nel 2010 avremo il più alto numero di titoli dalla sua nascita. E piuttosto che essere indice della salute dell'industria o dell'etichetta, ciò riflette semplicemente il numero di progetti dei quali sono venuto a conoscenza e dei quali voglio che la Samadhisound faccia parte. Come ho detto spesso parlando dei miei desideri per l'etichetta, è possibile piantare un albero di mele senza sognare un frutteto.
AAJ: Quanto sei coinvolto nella gestione della Samadhisound?
D.S.: Al momento me ne sto occupando parecchio, in pratica sono il motore che la fa funzionare.
AAJ: Qual è la direzione, il fine della Samadhisound dal punto di vista artistico?
D.S.: La Samadhisound è un luogo sia reale che virtuale dove gli animi si possono incontrare e condividere la creatività. È locale e globale al tempo stesso, un terreno fertile per le idee e le nuove tendenze della musica e delle arti. Questo è uno dei futuri possibili per la compagnia. Penso che la Samadhisound viva una sua vita, e che me ne riveli alcuni aspetti se e quando ritiene sia il caso. Riesco ad intuire quali sono i passi successivi del suo sviluppo. Ho delle preferenze riguardo alle direzioni che potrebbe prendere, ma in fondo cerco di ascoltare e assecondarla.
AAJ: Tra gli artisti che hanno pubblicato un disco per la Samadhisound c'è David Toop. Sono curioso: cosa pensi dei suoi libri come Ocean of Sound, Haunted Weather e gli altri suoi scritti?
D.S.: David è uno dei migliori scrittori sulla musica che abbiamo in questo Paese. Dal suo lavoro traspare una consapevolezza evoluta dell'arte dell'ascolto che, insieme alla sua vasta conoscenza della storia dei diversi generi musicali, delle arti sonore, eccetera, caratterizza la maggior parte delle sue pubblicazioni. I suoi lavori sono affascinanti, e spesso impreziositi da precisi approfondimenti dei mondi musicali che ci avvolgono e ci assorbono.
AAJ: Quali sono le sfide più grandi che un'etichetta indipendente, completamente focalizzata sulla musica sperimentale, si trova ad affrontare?
D.S.: Non è corretto dire che la Samadhisound è totalmente focalizzata sulla musica sperimentale. La mia intenzione è quella di pubblicare album di artisti provenineti da diversi generi. Comunque le difficoltà sono le stesse a prescindere dalla natura del lavoro: come far conoscere un lavoro al grande pubblico, e come interessare le persone al punto da fargli dedicare un'ora del loro tempo? Se riuscissi a rispondere anche solo in parte a queste domande, direi che saremmo sulla buona strada.
AAJ: Qual è stata l'esperienza più appagante legata alla gestione della Samadhisound?
D.S.: A parte i miei album da solista, l'aver realizzato le grafiche per quegli stessi album insieme a Chris Bigg. Come direttore artistico, scelgo le immagini e preparo una prima bozza. A quel punto Chris completa il tutto con un design appropriato. Chris è un designer molto capace. Entusiasta, accomodante, capace di fornire più opzioni per ogni proposta.
Mi è anche piaciuto riunire la comunità globale degli artisti con cui ho lavorato. In altre parole, sono profondamente coinvolto nella parte creativa, ed è la cosa che più mi soddisfa. Per certi versi sono anche coinvolto nell'aspetto commerciale, ma il team che gestisce l'etichetta è composto da collaboratori di cui mi posso fidare, e sono lieto di delegare le responsabilità in qualunque ambito io sia convinto di avere persone capaci.
Discografia Selezionata
David Sylvian, Manafon (Samadhisound, 2009)
David Sylvian, When Loud Weather Buffed Naoshima (Samadhisound, 2007)
Nine Horses, Money For All (Samadhisound, 2007)
Nine Horses, Snow Borne Sorrow (Samadhisound, 2005)
David Sylvian, The Good Son vs. The Only Daughter (Blemish remixes) (Samadhisound, 2005)
David Sylvian, Blemish (Samadhisound, 2003)
David Sylvian, Camphor (Virgin, 2002)
David Sylvian, Everything and Nothing (Virgin, 2000)
David Sylvian, Dead Bees on a Cake (Virgin, 1999)
David Sylvian, Approaching Silence (Virgin, 1999)
David Sylvian/Robert Fripp, Damage:Live (Virgin, 1994)
David Sylvian/Robert Fripp, The First Day (Virgin, 1993)
Rain Tree Crow, Rain Tree Crow (Virgin, 1991)
David Sylvian, Weatherbox (Virgin, 1989)
David Sylvian and Holger Czukay, Flux + Mutability (Virgin, 1989)
David Sylvian and Holger Czukay, Plight & Premonition (Virgin, 1988)
David Sylvian, Secrets from the Beehive (Virgin, 1987)
David Sylvian, Gone To Earth (Virgin, 1986)
David Sylvian, Brilliant Trees (Virgin, 1984)
Foto pubblicate per gentile concessione di David Sylvian
Traduzione di Stefano Commodaro
Articolo riprodotto per gentile concessione di All About Jazz USA
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.