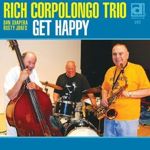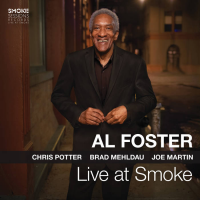Home » Articoli » Interview » Butch Morris, conduction d'argento
Butch Morris, conduction d'argento
Lo swing è tante cose: è forza, calore, fuoco, istantaneità, spontaneità. In una parola sola è combustione: quell'immediatezza che solo una musica libera è in grado di cogliere, di catturare.
E' tuttavia a un'intuizione posteriore di qualche anno (che in ogni caso, come tutte le cose di peso, parte da ben più lontano) che il Nostro deve la consacrazione, e l'estetica jazz un angolo visuale desueto, ulteriore, in cui porsi. Ci riferiamo ovviamente alle famigerate conductions, che oggi marciano decise verso quota duecento (le prime cinquanta sono mirabilmente sintetizzate in Testament: a Conduction Collection, box di dieci CD edito nel 1995 su New World/CounterCurrents): ognuna, il buon Butch, l'ha infatti numerata in divenire, come Anthony Braxton con le sue compositions.
"Vocabolario di segni ideografici e gesti usati per modificare o costruire in tempo reale arrangiamenti o composizioni musicali. Ogni segno e gesto trasmette informazioni generative per l'interpretazione del singolo e dell'ensemble, e dà la possibilità di alterare o dettare istantaneamente armonia, melodia, ritmo, articolazione, fraseggio o forma": così, in buona sintesi, Butch Morris ha definito la conduction, questa sorta di rito laico a cui, dal vivo e su disco, ha preso parte una moltitudine di musicisti, fra cui Arthur Blythe, Myra Melford, William Parker, Mark Helias, Fred Hopkins, il Rova Saxophone Quartet, il trombonista/manipolatore elettronico J.A. Deane (tra i fedelissimi, con Le Quan Ninh e Martin Schutz, fra gli altri), e poi Thurman Barker, Vincent Chancey, Brandon Ross, l'arpista Zeena Parkins, Tristan Honsinger, Hugh Ragin, Peter Kowald, Wolter Wierbos, Steve Beresford, Hans Reichel, Tom Cora, Han Bennink, Ikue Mori, Elliott Sharp, Reggie Nicholson, Hans Koch, Fredy Studer, e tanti altri.
A Bolzano - caso non unico - a supportare Morris era un ensemble di una ventina fra strumentisti e cantanti (due) provenienti dal Conservatorio Monteverdi (dove la conduction ha avuto luogo lo scorso 26 giugno) e dall'Istituto Musicale Vivaldi. Ne è venuta fuori una partitura composita, in quattro movimenti di durata e temperatura diverse, con le varie componenti strumentali (fra cui erano anche due percussionisti con "attrezzi" alquanto desueti) a fronteggiarsi su differenti piani, di natura timbrica ma ancor più - vien da dire - di apertura/adattamento agli input morrisiani, nonché di padronanza tecnica e di linguaggio (più o meno) specifico.
Fra sezioni più minimali e/o rumoristico-concrete, e crescendo (entro cui serpeggiava qua e là una palpabile danzabilità) di spiccata suggestione, la "Conduction No. 191" è così corsa via per un'ora circa, lasciando alla fine appagato sia il pubblico che - è sembrato - i musicisti, coinvolti in un'esperienza per loro senz'altro desueta. Al pomeriggio, a ridosso della prova generale, abbiamo scambiato qualche battuta con Butch Morris. Ecco cosa ne è venuto fuori.
All About Jazz: Anzitutto un chiarimento: la sua prima conduction risale al 1984, come riportano alcuni testi, o all'anno seguente, come recitano altri?
Butch Morris: Era il 1985: in questo 2010 festeggio i venticinque anni.
AAJ: Con quale bagaglio è approdato a quella sua prima conduction?
B.M.: Fin dagli anni Sessanta - direi verso il 1968/69 - questa idea ha iniziato a farsi strada in me. La prima concretizzazione è avvenuta nel 1974. L'anno prima avevo incontrato Charles Moffett, lo storico batterista del trio di Ornette Coleman, che aveva già tentato qualcosa del genere. Nel 1977 sono poi andato in Olanda per un workshop in cui insegnavo improvvisazione, e nel biennio successivo ho ripetuto l'esperienza in Belgio. E' stato in queste occasioni che ho iniziato a verificare nella pratica le idee che avevo maturato nel corso degli anni. Anche perché, contemporaneamente, facevo parte della big band di David Murray, dove avevo l'opportunità di sperimentare la cosa. Comunque è stato durante quei corsi d'improvvisazione in Europa che ho iniziato ad allestire degli ensemble specifici per provare questo tipo di cosa, che definivo - e definisco - comprovisation, cioè - come s'intuisce facilmente - una fusione, una compenetrazione, fra composizione e improvvisazione.
Dicevamo prima del 1984: forse l'equivoco nasce dal fatto quello è stato in effetti l'anno in cui ho capito di aver messo a punto ormai un mio vocabolario in questo senso, e ho iniziato a muovermi per portarlo dal vivo, ciò che appunto è accaduto a partire dall'anno seguente. Ho cominciato così a numerare queste mie esperienze, appunto con la "Conduction No. 1," poi la 2, e così via.
AAJ: Quella di stasera è quindi la "Conduction No. 191," basata su Vivaldi...
B.M.: Non è proprio così: non esiste un rapporto diretto con la musica di Vivaldi, una sua eventuale rielaborazione. Il sottotitolo cita Vivaldi un po' perché una delle scuole da cui provengono gli esecutori è intitolata a lui, e un po' perché mi ha segnato, in passato, l'utilizzo che Vivaldi fa delle differenti sezioni strumentali, e di strumenti anche inusuali. Personalmente, per esempio, ho iniziato ad ascoltarlo negli anni Sessanta, innamorandomi del suo "Concerto per fagotto". Di lui mi ha sempre colpito la capacità di adattare un'identica prassi compositiva a strumenti diversi, appunto, il che genera differenze timbriche che evidentemente variano la sostanza stessa, il tono, della composizione. Quindi: un'unica idea compositiva con tante diverse esemplificazioni pratiche. Questo, appunto, mi ha suggestionato, così come la sua vitalità, la sua energia.
A questo proposito, quando sono arrivato a New York c'erano numerosi ensemble i cui nomi facevano riferimento all'energia. Al loro interno, la tensione nasceva appunto da un accumulo di forze vitali - e vitalistiche - generato dall'accostamento, anche dall'accavallamento, di diversi improvvisatori. Nelle circostanze in cui mi sono trovato inserito in formazioni di questo tipo, ho cercato di catturare più idee possibile, andando però a cercare al loro interno una sorta di quintessenza che non risiedesse unicamente nella componente energetica.
AAJ: Ma all'interno di questi ensemble suonava ancora la cornetta?
B.M.: Certo.
AAJ: E la suona ancora?
B.M.: No, non più. Ormai ogni mio pensiero ruota attorno alla conduction, un terreno mai del tutto esplorato. Voglio capirla, sviscerarla sempre meglio, magari variando il rapporto fra la notazione e ciò che non vi fa ricorso.
AAJ: Ci sono esperienze specifiche precedenti che hanno esercitato una particolare suggestione su di lei, e di cui di conseguenza ha tenuto conto mettendo a punto questo suo vocabolario compositivo-improvvisativo?
B.M.: Ciò che m'interessava era unicamente trovare un diverso modo per avvicinare la composizione, seguendo parametri nuovi, e la stessa cosa riguardo all'improvvisazione: ecco come è nata l'idea della comprovisation. Da musicista, non m'importava tanto sapere che il jazz deve avere swing, che il jazz è swing, quanto piuttosto capire quale sia l'essenza dello swing, come ci si arriva; non limitarsi a perpetuare lo swing, quindi, ma coglierne, appunto, l'essenza, il nocciolo. Sono cresciuto nelle jazz bands, nelle blues bands della tradizione, ma ben presto si è fatta strada in me l'esigenza di suonare free, di praticare la libera improvvisazione, perché - appunto - il free jazz coglie l'essenza dello swing senza magari esprimerlo in maniera esplicita, diretta, riconoscibile. E' chiaro che non ci ho messo un giorno a capirlo, ma questa convinzione si è fatta strada in me molto precocemente. Quindi la mia idea è stata fin dall'inizio quella di portare avanti la tradizione, ma attraverso vie nuove. Lo swing è tante cose: è forza, calore, fuoco, istantaneità, spontaneità. In una parola sola è combustione: quell'immediatezza che solo una musica libera è in grado di cogliere, di catturare. Io quindi mi sono proposto di penetrare anzitutto quest'essenza, spostandomi in un secondo momento sugli altri parametri: le frasi, i timbri, ecc.
AAJ: Che differenza di approccio esiste nel mettere a punto una conduction con degli studenti di conservatorio, come qui a Bolzano, rispetto a quando ha modo di lavorare con musicisti che la conoscono e che lei conosce a fondo?
B.M.: La chiave è sempre la stessa: la sorpresa. Anche questo è swing: la sorpresa mia nei loro confronti, e la loro nei miei. Non è una questione di informazioni preesistenti: questa sorpresa dev'esserci comunque, che io mi trovi a Seattle, in Corea, a Parigi, dovunque. Esiste comunque una sorpresa da parte dei musicisti nel vedere come io, attraverso un vocabolario di segni, creo ritmi, melodie, ecc. Quindi c'è un'ampia variabilità, che sta soprattutto nei musicisti, nel loro carattere, da dove provengono, il loro background, in una parola nel loro essere unici. Un'unicità che io tendo comunque a salvaguardare: questo ci tengo che sia chiaro. Ne faccio tesoro, anzi, e credo di poter dire che la mia musica, per quanto pilotata, rimane estremamente democratica. Tutto il processo che ho cercato di sintetizzare, questo percorso di progressiva conoscenza reciproca, può infatti determinare anche degli scarti sensibili nel mio modo di orientare una data conduction. Qui a Bolzano, per esempio, tre musicisti hanno abbandonato la cosa, strada facendo, ed è cambiato letteralmente tutto.
AAJ: Che musica ascolta, di preferenza?
B.M.: Ascolto ogni tipo di musica. Anzi: ogni tipo di suono. Può essere che questa notte, prima di addormentarmi, il suono che avrò più presente nelle mie orecchie sarà lo scorrere dell'acqua che ha accompagnato questa nostra conversazione.
Foto di Alberto Bazzurro (la terza e la penultima) e Claudio Casanova (tutte le altre).
Si ringraziano Nicola Ciardi e Klaus Widmann.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.