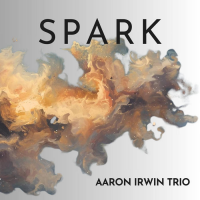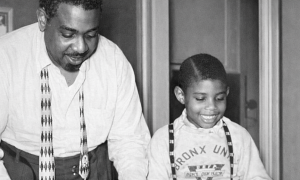Home » Articoli » Live Review » Biennale Musica 2024 a Venezia
Biennale Musica 2024 a Venezia

Courtesy La Biennale Venezia, Andrea Avezzù
Venezia
Varie sedi
26 settembre—11 ottobre 2024
La direzione artistica di Lucia Ronchetti, giunta all'ultimo anno del suo mandato, non finisce di stupire. "Absolute music" è la denominazione del 68° Festival Internazionale di Musica Contemporanea, che, come si legge sul catalogo, intende affrontare ..."il significato della musica quale linguaggio autonomo e lo statuto ontologico del suono, mostrando lo stato dell'arte di questa disciplina alchemica e coinvolgente, entrando nel laboratorio dei compositori e degli interpreti più rigorosi e inventivi che elaborano partiture, programmi, codici e performance, senza alcun riferimento extra-musicale e senza riferimenti visivi." Dopo aver puntato l'attenzione nelle passate edizioni sulla voce, su esperienze di musica elettronica e soprattutto di teatro musicale, di autori—performer e di progetti trasversali, sempre previlegiando una consistente presenza femminile, dirottare la riflessione quest'anno sul concetto di "musica assoluta" significa un ritorno all'ordine, a una ricerca disciplinare accademica, autoreferenziale, asemantica? In altri termini, con riferimento a una teoria estetica che ha imperato alla metà del secolo scorso contrapponendo due diverse modalità dell'azione artistica, significa previlegiare il polo creativo del "chiuso," dell'assenza, del freddo, rispetto a quello dell' "aperto," della presenza, del caldo? Non direi, o per lo meno non sempre, giudicando dai concerti che ho potuto ascoltare in cinque giornate del lungo festival, in cui è stato comunque confermato il rilievo della componente femminile. Si è assistito infatti anche ad esperienze di evidente gestualità e fisicità interpretativa, di coinvolgimento dello spazio con risultati suggestivi, di commistione fra i generi.
Significative a tale proposito sono le parole di Rebecca Saunders, a cui a buon ragione è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera 2024: "Superficie, peso e tatto sono parte della realtà della performance musicale... Essere consapevoli della matericità del rumore di uno strumento, o di una voce, ci ricorda la presenza di un corpo fisico fallibile dietro il suono. La presenza fisica del musicista e del suo strumento acustico, del suo suono, sono importanti fonti di ispirazione." Un testo che sembra avere dei punti in comune con la teoria della musica come esperienza audio-tattile sostenuta dal musicologo Vincenzo Caporaletti e che ha visto una traduzione immediata nell'esecuzione di "Wound," per ensemble e orchestra, nel concerto inaugurale al Teatro La Fenice in prima italiana.
In questa composizione le intenzioni della compositrice britannica sono esplicite: ..."Una lesione radicata nella pelle rovinata, un segno di differenza. La superfice imperfetta, i contorni sfilacciati, fratture nella patina. L'implicazione della vulnerabilità: la squisita fragilità e imperfezione che ci rendono umani...." Wound, nel senso di ferita, lacerazione, violenza, soprattutto nei confronti del corpo e della psicologia femminile, ha conferito una concreta espressività al percorso sonoro. Nella parte iniziale a stento gli impasti timbrici e armonici palesavano la loro origine acustica; a volte i flussi sonori risonanti, ricchi di glissando, di crescendo e smorzamenti, sembravano mimare immaginifiche nuances elettroniche. Col procedere del brano quello che è prevalso è stato un impianto strutturale, abrasivo e scabro, in cui si sono continuamente alternati improvvisi, squassanti addensamenti e raccordi più reticenti e pensosi; sono così emersi in piena evidenza di volta in volta i contributi di pianoforte, percussioni, fiati, archi con momenti di incisiva efficacia. Sotto la direzione di Tito Ceccherini, l'integrazione fra Ensemble Modern -a giusto merito vincitore fra l'altro del Leone d'argento -e orchestra del Teatro La Fenice ha donato alla partitura compattezza e vibrazioni aliene.
Al monolitico, estremo radicalismo di "Wound" ha fatto seguito la proposta più insinuante, possibilista e accattivante della compositrice coreana Unsuk Chin: il suo "Puzzles and Games from Alice in Wonderland," scritto nel 2017 ma in prima esecuzione italiana, ha visto la convincente interpretazione del soprano Siobhan Stagg, autraliana ma residente a Berlino, nel ruolo di Alice. L'impianto strumentale, generato in apertura da interventi puntillistici isolati, si è via via trasformato in un contrappunto articolato e fitto, pur rimanendo per lo più sospeso e delicato. Per certi aspetti, la qualità melodica della composizione, l'interpretazione disinibita della Stagg e anche il suo relazionarsi con l'orchestra, hanno fatto emergere alcuni collegamenti con le "Folk Songs" di Luciano Berio, ma anche con altri precedenti del Novecento. Nel corso dell'opera si sono susseguite situazioni, ora più drammatiche ora più ironiche e perfino umoristiche, che sono state sottolineate da un adeguato atteggiamento vocale e scenico, ma anche strumentale, di carattere decisamente teatrale.
Composizioni di Rebecca Saunders e Unsuk Chin sono state presentate anche in altre due delle dieci sezioni in cui la programmazione era articolata. Nell'assolo affrontato nella Sala delle Colonne di Palazzo Giustinian dal pianista francese Bertrand Chamayou, che si è misurato con composizioni di tre autori diversi, in buona parte debitrici verso forme e tecniche del passato, della Chin sono stati ripresi i "Piano etudes 1—6." Nel primo studio, In C, composto nel 1999, emerge l'influenza del Gamelan balinese, a differenza di altri tre studi, che, come afferma la compositrice, "hanno un orientamento relativamente forte verso la musica pianistica del modernismo classico, soprattutto per quanto riguarda la tecnica." Nel complesso si è percepito un andamento contrastato, un'avventura attraverso situazioni diversificate, ricche di salti di ottava, grovigli percussivi, rincorse con frasi ripetute ma sempre variate.
In "Fantasy for Piano Solo" invece, prima assoluta del trentenne compositore statunitense Miles Walter, si è potuto intravvedere una sorta di trasposizione di un elegante dinamismo novecentesco, contrapposto a una rivisitazione neo-romantica più macerata. Una trina di note cristalline che s'inseguono velocemente, a tratti evolve verso un registro più grave o si acquieta in un'atmosfera relativamente più calma. Improvvisamente emerge una cadenza di ragtime prima che la composizione s'inoltri in fasi più nervose sul registro acuto.
Un percorso forse ancor più imprevedibile e accidentato viene intrapreso in "Shadowlines," composto nel 2001 dal britannico George Benjamin, che così precisa: "Questa sequenza di pezzi, tutti canoni in forma diversa, è stata concepita come una struttura continua, cumulativa... dal breve prologo, apparentemente di carattere improvvisativo, ...all'epilogo semplice e delicato." Oltre che una filtrata rilettura di forme del passato nei brani proposti (ecco una visione musicale "purista," disciplinare e autoreferenziale), il coerente e mirato recital pianistico da parte di Chamayou ha avuto come tema di fondo il contrasto fra dinamiche e tessiture sonore, fra sussulti e meditazione, fra energia propositiva e lirica poesia.
Un'altra composizione di Rebacca Saunders è invece rientrata nella sezione Sound Structures, eseguita al Teatro Piccolo Arsenale sempre dall'Ensemble Modern sotto la direzione attenta di Bas Wigers: "Skull," scritto nel 2023 come terzo e conclusivo episodio di un trittico comprendente "Skin" (2016) e "Scar" (2019). Stratificazioni di armonie, glissando, intonazioni incerte su un andamento lento hanno prodotto una sequenza di ondate misteriose, una sensazione inquietante di pericolo persistente, l'attesa di una minaccia non identificabile ma inevitabile. I picchi sonori della parte centrale rendono sempre più esplicite e destabilizzanti queste sensazioni, spingendo verso un disperato tentativo di fuga o verso la rassegnazione a soccombere, a meno che non si abbia la determinazione di affrontare di petto l'emergenza. Il poderoso e abrasivo crescendo finale, saturo si soluzioni dense e sorprendenti, non fa altro che estremizzare il dilemma fra queste scelte esistenziali contrapposte. La visione non ottimistica, ma tutt'altro che rinunciataria, della Saunders risulta del tutto in sintonia con gli estremi fenomeni bellici, socio-politici e climatici che stiamo vivendo a livello globale.
Nella prima parte dello stesso concerto era stato eseguito un brano inedito del tutto diverso, composto dalla venticinquenne Alice Hoi-Ching Yeung, cresciuta a Hong Kong e attualmente residente a L'Aia. La giovane autrice ha concepito una partitura intitolata "Sonic Ritual" per tre percussionisti (a Venezia i bravi Brian Archinal, Federico Tramontana e Aleksandra Nawrocka). Gestualità e interazione istantanea sono rimbalzate dall'uno all'altro dei tre interpreti, dando di volta in volta la prevalenza a una mirata gamma timbrica e strumentale; i gong, le pelli colpite o strofinate con tecniche diverse, i piatti di varia foggia sfregati con gli archetti... hanno dato luogo a un paesaggio sonoro di inventiva freschezza e immediata comunicativa.
Ma l'apoteosi del percussionismo la si è ascoltata al Teatro alle Tese in una composizione scritta da Gérard Grisey intorno al 1990: "Le noir de l'étoil" per sei percussionisti, suoni registrati e trasmissione di segnali astronomici (più precisamente gli impulsi sonori emessi dalle pulsar e registrati da appositi radiotelescopi). I sei interpreti erano dislocati lungo il perimetro della sala rettangolare, ciascuno posizionato su una pedana sopraelevata, alle prese con un vasto set di strumenti, fra i quali gli immancabili gong e una enorme grancassa orizzontale. Per il pubblico, seduto a terra o in piedi al centro della sala, l'effetto multifonico creato dalla sovrapposizione delle fonti sonore acustiche è quindi risultato imponente. Se si considera che in varie fasi e con varia intensità si sono inseriti anche i suoni della base preregistrata e quelli captati dallo spazio, si comprende come la molteplicità delle soluzioni adottate dal compositore abbiano prodotto un esito di grande impatto.
Le combinazioni ritmiche, timbriche e dinamiche messe in campo, mai banali, esenti da espedienti accattivanti, hanno creato un'esperienza sensoriale che ha tenuto perennemente l'ascoltatore in uno stato di allerta, raggiungendo momenti di un tutto pieno avvolgente e parossistico, ma sempre chiaramente leggibile nelle componenti del suo svolgersi. Il vigoroso impeto che ha caratterizzato l'interpretazione va attribuito alla motivazione e all'affiatamento che hanno animato gli esecutori: i quattro membri dello svizzero Ensemble This—Ensemble That, più i giovani Federico Tramontana e la polacca Aleksandra Nawrocka, oltre al delicato ruolo riservato a Thierry Coduys, responsabile del sound projection.
Un'altra sezione, denominata Absolute Jazz, è stata forse pensata per rendere omaggio a un genere musicale riconosciuto, più che per descrivere l'approccio di quegli autori che, forti di un solido percorso di studi, tendono a praticare una ricerca compositiva personale e trasversale, avvicinandosi all'ambito della musica contemporanea. Per gli appassionati di jazz, che ben conoscono Tyshawn Sorey come uno dei più notevoli e versatili batteristi dell'attualità, è del tutto insolito ascoltarlo in veste di compositore e pianista. Al centro della sala delle Tese dei Soppalchi, quasi totalmente oscurata, Sorey si è concentrato sul suo "Alone," una suite austera e articolata in vari movimenti. Note isolate e accordi anomali, lenti e spaziati, tanto da lasciarli risuonare fino all'esaurimento, hanno lasciato il posto a un complesso intrico di note continuamente tenuto sul registro grave: una sorta di tuono, dapprima lontano e soffocato, poi in una progressione in crescendo fino a raggiungere una massa sonora impressionante. Inevitabilmente alcuni momenti concitati nella parte centrale del concerto hanno richiamato il fraseggio, la grana armonica e ritmica della pronuncia di Cecil Taylor, il più grande, imprescindibile innovatore del linguaggio pianistico della seconda metà del Novecento. Nel finale, la parabola esecutiva è tornata a selezionare accordi concatenati, con le mani posizionate alle due estremità opposte della tastiera. Con evidenza questo disegno compositivo preordinato ha trovato la sua naturale realizzazione in una buona dose d'improvvisazione.
Sempre la sezione Absolute Jazz ha compreso anche l'apparizione di Peter Evans, che ha proposto "Concert Solo for Trumpet," concepito appositamente per lo spazio delle Tese dei Soppalchi, di cui aveva preso visione in precedenza. Questa è stata per me l'occasione di ascoltare in solo il trombettista di New York per la terza volta, potendo constatare come ogni volta il suo approccio alla solo performance si configuri in risposta alle diverse condizioni contingenti. La sua tecnica si avvale nel modo più opportuno di respirazione circolare, dell'uso del volume, di microtoni, della complicità dell'amplificazione e del microfono, che sprofondato nella campana dello strumento procura suoni fortissimi e sforzati, talora dalle inflessioni elettroniche... Nel travolgente concerto veneziano è stata appunto questa tecnica prodigiosa che gli ha permesso di elaborare un discorso concatenato e incatenante, una sorta di comizio su come gestire un'estemporanea libertà creativa, su come cioè affrontare l'improvvisazione al fine di ottenere un'espressività piena e un senso narrativo coinvolgente.
Nella prima parte del concerto Evans ha usato una pocket trumpet a quattro pistoni; prima di proseguire con la tromba ha imbastito un momento di raccordo, alternando sui due strumenti brevi frasi e colpi secchi di frastornante potenza. Non sono mancate però anche aree in cui, con una tecnica più ortodossa, ha inventato frasi lineari e liriche, memori di lontani temi rinascimentali. In definitiva si può parlare di Absolute Jazz? Penso proprio di sì, rispetto alla più essenziale e severa performance di Sorey, se è vero che alcuni dei presupposti fondamentali del jazz sono la ricerca di una pronuncia personale e inimitabile, di un sound peculiare, praticando una libertà improvvisativa anche estrema e dando così forma a performance irripetibili.
Ci sarebbe altro da riferire su queste giornate della Biennale Musica 2024; non si può fare a meno però di citare il concerto sinfonico della WDR Sinfonieorchester, che sotto la direzione di Ilan Volkv ha proposto tre composizioni di autori diversi per generazione e ambito estetico, fra cui la tuttora sconvolgente "Sinfonie in einem Satz," scritta nel 1951—53 da Bernd Alois Zimmermann. Quello che è importante rilevare è il trasporto e la precisione chirurgica, maniacale con cui l'orchestra tedesca ha dato vita a tutto il materiale musicale affrontato; una mirata gamma di scelte esecutive si è stagliata con possente energia, mettendo in evidenza soprattutto il peso degli archi e dei sei percussionisti.
L'eredità lasciata dalla direzione artistica di Lucia Ronchetti, a meno che non accetti un'eventuale proroga dell'incarico, è piuttosto ingente: musica intesa come espressione multiforme e dialettica, compromessa con l'attuale realtà sociale e comunicativa nel suo complesso, oltre che con altri linguaggi artistici, tutt'altro che ricerca formale chiusa in una proclamazione della propria autonomia, auto-esaltando se stessa e la propria storia. Al momento nessuno sa chi subentrerà nell'impegnativa mansione, se non Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.