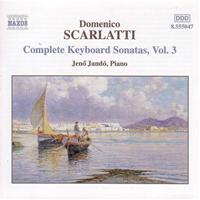Home » Articoli » Lyrics » Sulla contaminazione: parte sesta - La crisi post-free
Sulla contaminazione: parte sesta - La crisi post-free
In particolare, la relazione di Festinese esprime un punto di vista interessante e per molti versi da me condiviso. Tuttavia sono perplesso sulla possibilità di stabilire un criterio per separare in modo così deterministico la commistione "buona" da quella "cattiva".
Tra l'altro, il determinismo come definizione di un nesso rigido di causa-effetto ha un rimando in qualche modo "geografico" (e quindi una vaga attinenza etnologica), perché una delle relazioni più approfondite sul tema è quella dello storico Lucien Febvre che nel suo libro "La terra e l'evoluzione umana" (Einaudi), scritto nel 1922, dedicava ampio spazio al determinismo storico dei geografi positivisti di fine Ottocento che stabilivano delle connessioni ineluttabili tra comportamento sociale e aree o latitudini di provenienza.
Quindi, tornando al nostro argomento, dagli Ethiopian Minstrels di fine Ottocento a Tony Esposito che si presenta con la kalimba a San Remo, passando per la moda della tabla nel jazz anni Settanta, per la voga dell'exotic lounge, o per Don Cherry e i Codona, i casi sono molto differenti e, a mio giudizio, troppo spesso difficilmente esauribili con l'aggettivo "buono" o "cattivo". Per fare un esempio citato da Libero Farnè: è buona o cattiva la commistione di Ellington con i suoi "africanismi" d'epoca al Cotton Club? Probabilmente è "cattiva", cercando di interpretare il metro di giudizio di Festinese, eppure non si può negare che proprio quella commistione contenesse elementi di grande interesse. Per esempio il repertorio di Ellington degli anni Venti è tutt'altro che deprezzabile e stilisticamente fece scuola, aprendo la porta a una fase successiva non certo di secondo piano.
Tornando a bomba al convegno mi piace ricordarne anche un altro capitolo, oltre a quello del "veleno" e dell'intossicazione nel corpo jazzistico. Un argomento forse più vicino al tema di partenza, che per la verità ognuno ha un po' interpretato a modo suo e che io avevo inteso come confronto "ad ampio orizzonte" sul jazz dopo gli anni Sessanta. Mi riferisco all'accenno di discussione sul jazz interpretabile come "musica fatta di diversi generi" o come "musica fatta di relazioni tra singoli" (concetto quest'ultimo introdotto da Giuseppe Vigna). Il tutto era partito proprio da una sorta di mappa geografica del jazz, portata al convegno da Neri Pollastri, che riannodava i e sintetizzava i fili del jazz post-free sotto l'egida dell'etichetta ECM.
Io invece ero venuto al convegno con l'intento di solleticare i colleghi e i presenti sul tema della crisi che il free (se così vogliamo chiamarlo) ha lasciato sul tappeto. Personalmente penso che l'idea che il jazz nasca e prosegua come una storia di relazioni sia intrigante. Nonostante questo è innegabile che, anche se non vogliamo chiamarlo be-bop hard bop, o cool, in determinate epoche del Novecento la connotazione stilistica del jazz fu caratterizzato da un forte denominatore comune e da una comune origine.
Ecco, questa mancanza di un forte denominatore largamente condiviso, unito ad alcune delle questioni laceranti aperte dai jazzisti free (primo fra tutti il rifiuto delle definizione di "jazzista" da parte di molti musicisti) è all'origine di un cambiamento. Una sorta di polverizzazione del panorama (anche in termini geografici) per cui cronologicamente dopo il free jazz verrebbero (e ripeto verrebbero) il jazz-rock e l'Europa.
In realtà nel corso degli anni Settanta alcune delle questioni poste negli anni Sessanta (la natura nera del jazz, gli elementi caratterizzanti dell'estetica del jazz, etc.) conobbero valide e varie risposte ma che si svilupparono come lungo una canalizzazione sotterranea che arriva fino a noi: pensiamo allo sviluppo del jazz della Chicago nera, a William Parker, alla scena Downtown di New York, oppure pensiamo a quanto il cosiddetto post-rock ha ereditato dal free fino ad assumerne alcuni connotati.
La cosa impressionante è che la profonda crisi di coscienza del jazz negli anni Sessanta impose una sorta di iato in cui si inserì, a partire dal decennio successivo, una melassa equivoca sul senso più profondo del jazz. Tra i risultati più orrendi c'è la stortura della fusion, che in alcuni casi ha portato il jazz nell'alveo di una sottocultura a tutto uso e consumo del mercato.
Nel corso degli ultimi vent'anni poi la riproposizione di formule stantie e repertoriali in cui, nei casi peggiori, l'originale senso jazzistico è stato sottoposto ad abbondante lifting ha creato mostri ancora più aberranti. Senza mettere bene a fuoco l'esistenza di questo doppio binario, e forse per l'abbaglio dei lustrini di Diana Krall, qualcuno si è anche avventurato nell'affermare che il jazz che è morto ("Jazz isn't dead it just smells funny" diceva Frank Zappa), ma in fondo questa è una riflessione su cui, oltre ai critici, sarebbe opportuno coinvolgere organizzatori e i direttori artistici.
Foto di Fabio Gamba
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.