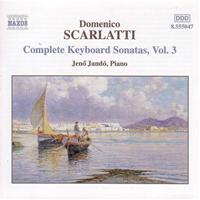Home » Articoli » Lyrics » Sulla contaminazione: parte quinta - La storia del jazz ...
Sulla contaminazione: parte quinta - La storia del jazz è storia di contaminazione
Quando Alan Lomax chiese a Jelly Roll Morton di suonare musiche che gli ricordavano l'infanzia, il pianista creolo, "l'inventore del jazz", si mise a strimpellare arie d'opera italiane, marcette francesi, ouverture di sinfonie, valzer, blues, ragtime. Nella New Orleans dei primi del Novecento, città multietnica come poche altre, il sovrapporsi di suggestioni europee, spagnole e francesi in testa, ad un vasto agglomerato di neri urbanizzati, tra i quali i creoli, diede origine a forme musicali decisamente ibride e instabili. La storia del jazz è dunque storia di contaminazione fin dalla primissima ora, anche se, e molti spesso lo dimenticano, quando l'Original Dixieland Jazz Band entrò in studio per consegnare agli annali il primo disco jazz, il processo di codificazione del genere era già in fase avanzata.
In ogni caso, al di là delle considerazioni sulla genesi della musica che amiamo, è innegabile che la contaminazione sia elemento costitutivo dell'estetica jazz. Molto più difficile, invece, introdurre in sede di giudizio critico discriminanti di velenosità o bontà. La superficialità, ad esempio, non basta a tracciare una linea di demarcazione tra la contaminazione buona e quella cattiva; così come non possono bastare i concetti di rispetto, frequentazione, conoscenza delle culture "altre", categorie sociologiche che nel mondo globale hanno assunto significati sconosciuti e impensabili fino a un ventennio addietro. In questo senso Duke Ellington rappresenta forse l'esempio problematico più calzante, visto che dell'esotismo ha fatto uno dei motivi più sublimi della sua musica: si pensi alla "Far East Suite", all'"Afro Eurasian Eclipse", agli africanismi del periodo Cotton Club. Interessante anche il concetto di ironia come elemento chiave per disinnescare i rischi dell'esotico gratuito e fastidioso. Eppure, anche in questo caso, si dovrà ammettere che non sempre l'ironia basta e non sempre nella contaminazione si rinvengono elementi ironici; così come capita di assistere a ironici miscugli di salse e spezie esotiche che scadono nel becero trastullo della world più deleteria o, peggio ancora, nell'esca gettata con malizia nel mare poco pescoso del mercato discografico attuale.
Per uscire da quello che potrebbe apparire un vicolo cieco, credo sia necessario riportare il discorso all'interno di un'ottica individualista, che tenga conto prima di ogni altra cosa dei singoli musicisti, delle relazioni e della storia. Libero Farnè ha parlato, a ragione, di "forti idee generatrici", ovvero un pensiero musicale forte, un'ispirazione pura e sincera. Credo che la storia del jazz, mi verrebbe da dire la storia della musica in generale, sia prima di ogni altra cosa una storia di musicisti. E ogni visione artistica che si rispetti non è in fondo una contaminazione di esperienze, ascolti, incontri, frequentazioni? Solo l'artista in questo senso è garante della bontà o velenosità di quel che crea, di quel che assembla a partire dai più svariati materiali a disposizione. E nell'era del postmoderno, o del presunto postmoderno, nell'epoca della polverizzazione dei generi e delle categorie estetiche, della fine della storia dell'arte com'è stata teorizzata per tutto il Novecento, della crisi dei modelli consolidati di produzione e fruizione della cultura, dell'universo a portata di clic, penso sia più che mai doveroso il ritorno all'individuo come certezza primaria.
Ritorno all'individuo e ritorno alla storia. Ed ecco il secondo punto che mi preme sottolineare. Si parla spesso, e non a caso, di "continuum" per definire la storia del jazz. Nessun'altra forma musicale può vantare un rapporto tanto storicizzato con il proprio passato, un rapporto basato sul rispetto e sul culto dei padri a prescindere dalla radicalità dei singoli pensieri. Il jazz non ha mai conosciuto il trauma delle avanguardie, non ha mai rinnegato quel che è stato, non ha mai dovuto affidarsi al parricidio per rinascere a vita nuova. Esiste un alveo comune e condiviso nel quale scorre ancora il grande fiume del jazz. Oggi, come quarant'anni fa, l'artista jazz si porta dentro la consapevolezza di appartenere alla storia di questa musica. Alex Von Schlippenbach che si prende la briga di dedicare un triplo CD a Monk; l'integralista Otomo Yoshihide che licenzia una replica esatta di Out to Lunch di Eric Dolphy; Evan Parker che in un concerto a Faenza ricorda la scomparsa di Steve Lacy, additandolo come fonte d'ispirazione; l'ICP Orchestra che omaggia Herbie Nichols; Aki Takase che dedica un lavoro a Fats Waller, assoldando per l'occasione il banjo stralunato di Eugene Chadbourne; John Zorn che dichiara il proprio amore per Hank Mobley e Sonny Clark; Elliott Sharp che si sorprende nel mettere la propria tecnica e la propria semiacustica al servizio delle composizioni di Monk (Sharp? Monk? Sharp! Monk!); i numerosi musicisti di vent'anni o poco più che parlano di Tim Berne, Nels Cline o Steve Coleman come modelli imprescindibili: fino a quando sopravviverà questo senso di appartenenza, questo profondo respiro storico, il jazz avrà un futuro e un senso.
E praticare la contaminazione coltivando le proprie radici, le radici del jazz, e al contempo la propria individualità artistica, è senza dubbio un buon antidoto contro il veleno evocato in precedenza.
Foto di Luca Canini
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.