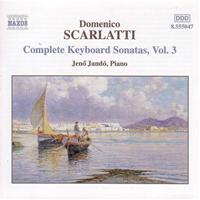Home » Articoli » Lyrics » Sulla contaminazione: parte quarta - Contaminazione ed e...
Sulla contaminazione: parte quarta - Contaminazione ed ecologia della musica
Ma, come si sa, non tutti gli usi linguistici possono essere compresi semplicemente rifacendosi al vocabolario e all'etimologia. E di fatto in questo caso (così come in quello generale delle "contaminazioni culturali", delle quali quelle musicali sono una sottospecie) il termine non viene usato con significato negativo. Perciò, chiarire la stranezza dell'uso positivo di un termine palesemente negativo può essere rilevante per capire se vi siano contaminazioni "buone" e, in caso affermativo, quali siano.
Che l'uso linguistico positivo del verbo "contaminare" si sia affermato per mancanza di alternative sembra assai improbabile, vista l'ampia disponibilità di termini analoghi privi del portato negativo, come "unione", "intreccio", "fusione", "intersecazione" o "congiunzione", solo per citarne alcuni.
Più plausibile sembra invece la possibilità che il tipico rovesciamento della negatività in positività sia intenzionale, ancorché forse non interamente esplicito. Potrebbe trattarsi in altre parole di una ironica reazione critica all'atteggiamento di chiusura protettiva e autoconservativa che caratterizza le forme culturali istituzionalizzate, ovvero la cosiddetta "alta" cultura, che fa della sua stessa "purezza" un valore: rendere positiva la "contaminazione", in questo senso, avrebbe il significato di contestare, o perfino negare, il valore di quella purezza conservativa.
Il problema di questa spiegazione sta nel fatto che l'uso positivo già presuppone quello negativo, il quale viene sì contestato per ragioni in senso lato "politiche" (l'istituzionalizzazione della cultura la sottrae all'informale creatività sociale e la trasforma in un sistema di potere), ma con ciò si lascia sfuggire le ragioni concrete per cui quell'uso era nato, ovvero l'effettiva negatività di almeno alcune forme di intreccio culturale - quelle in cui esso non è più un semplice "intreccio" ma, a cagione della sua pericolosità, diviene appunto "contaminazione".
Un'analisi anche minimamente esaustiva di tali ragioni richiederebbe un lavoro di ben altra portata che non queste brevi riflessioni, per cui qui mi limiterò ad accennare un possibile orizzonte di ricerca.
Cos'è una cultura? Semplificando per brevità un po' le cose, si può affermare che una cultura sia un complesso organismo, la cui vita dipende da quella dei suoi numerosi elementi interni: gli individui umani, ma anche i soggetti collettivi (enti, associazioni, imprese) e quelli simbolici (singoli elementi culturali, opere, stili che le classificano, concetti e significati che le interpretano) prodotti dagli individui stessi e che assumono una loro vita relativamente autonoma (nel senso dello "spirito oggettivo" di Hegel o del "terzo mondo" di Popper).
Ma un organismo è qualcosa di individuale che ha, in quanto tale, un'essenziale esigenza di scambiare cose con l'ambiente che lo circonda, cioè con altri organismi. Questo scambio è vitale (senza di esso l'organismo non potrebbe sopravvivere), ma resta funzionale alla auto-produzione di elementi propri: l'organismo metabolizza e con ciò trasforma profondamente, adattandolo a se stesso, ciò che prende dall'esterno. E per far questo ha bisogno di tempo e dell'intervento di molte delle sue componenti interne. Lo scambio con l'esterno è perciò caratterizzato da una misura - non può cioè avvenire né troppo lentamente (l'organismo perirebbe per carenza di nutrimento), né troppo rapidamente (esso collasserebbe per l'impossibilità di reggere il carico cui è sottoposto) - che non è unificata, bensì è diversa per ciascun tipo di organismo: superata la propria misura, i propri tempi, lo scambio che l'organismo intrattiene con l'esterno non è più utile e buono, ma diviene eccessivo e dannoso.
Ebbene, a causa della sua multiforme complessità, i tempi dell'organismo "cultura" (anche musicale) sono ben diversi da quelli delle sue componenti. Così, l'architettura, la pittura, la gastronomia o la musica possono ciascuna modificarsi e metabolizzare il cambiamento in tempi assai più brevi della totalità della cultura generale in cui sono inscritte - ad esempio, della "cultura europea" - perché quest'ultima richiederà una più ampia diffusione della conoscenza, la sua assimilazione da parte delle numerose branche culturali che la compongono e, soprattutto, da parte di una moltitudine di soggetti individuali. E ancora, proprio per questo una qualsiasi "cultura" avrà tempi diversi, molto più lunghi, dei singoli individui che ne fanno parte: almeno di principio, infatti, un individuo può cambiare anche istantaneamente gusti e opinioni, riferimenti culturali e reazioni a quanto lo circonda, mentre la stessa cosa non può avvenire per le formazioni culturali, che richiedono mutamenti lenti, ragionati, intersoggettivamente condivisi.
Siamo qui di fronte a un fenomeno analogo a quello della distinzione tra "tempi storici" e "tempi geologici" che è stata al centro del paradigma ecologico negli anni '80: così come modificare l'ambiente ai ritmi della storia umana produce "contaminazioni", perché non lascia alla natura il tempo di assimilare e armonizzare il cambiamento, anche modificare la cultura in tempi che non le siamo propri - quelli imposti dall'economia, dalla ricerca del successo, dal gusto di un numero ristretto di individui - rischia di essere analogamente dannoso e di produrre "cattiva contaminazione". E il fatto che il termine in questione - "contaminazione" - sia mutuato proprio dal campo ambientalista, offre a mio parere un'interessante opportunità: quella di assumere pienamente il paradigma ecologico e di ricercare, all'interno di una "ecologia delle culture", quali interazioni culturali siano, per i tempi e le forme che assumono, potenzialmente positive, e quali invece non lo siano e rischino di diventare solo "contaminazioni".
È chiaro che, in quest'ultimo caso, sarebbe forse preferibile lasciar semplicemente cadere l'uso positivo del termine "contaminazione" (così come avviene in finlandese…), sostituendolo con uno qualunque degli altri possibili termini disponibili. Ed è anche chiaro che l'assunzione di una prospettiva ecologico-culturale avrebbe per conseguenza un maggior senso critico nei confronti delle interazioni culturali: probabilmente, oggi esse sono troppe e troppo rapide, così da correre il rischio di provocare non tanto il kitsch (male in se assolutamente tollerabile), quanto la morte delle culture più deboli (con gravi danni alla biodiversità culturale) e l'impoverimento di senso di tutte le altre.
Tuttavia, questa maggiore cautela non si configura a sua volta come un possibile rischio di sterilizzazione per le culture ad alto tasso di dinamismo, come è il caso del jazz, che Libero Farnè nel suo intervento definisce "musica meticcia per eccellenza, direi quasi per definizione o per statuto costitutivo". L'interazione culturale e il meticciato, nel jazz, non nascono come "contaminazione" di qualcosa di esistente allo stato puro, perché alla sua origine esso non prende spunto da una cultura istituzionalizzata, ma - come fa ben osservare Davide Sparti in Musica in nero - si avvia dalla quasi totale assenza di identità culturale. Proprio per questo il jazz si costruisce come cultura a sé, le cui minimali radici si reggono fin dall'inizio sull'interazione con culture altre (ad esempio, gli strumenti del jazz non sono africani e vengono in alcuni casi introdotti da musicisti non afroamericani, come accade esemplarmente per la chitarra). Una cultura dinamica, fatta essenzialmente di improvvisazione, tanto musicale quanto esistenziale, perciò una cultura dall'identità non istituzionalizzata e in continuo divenire.
Questo dinamismo, essenziale alla cultura jazzistica, ha ovviamente anch'esso una sua misura, che dipende dal modo in cui le interazioni sono assimilate dalla comunità di coloro che prendono parte alla cultura stessa e che include musicisti e pubblico. E se alle origini il dinamismo era elevato (e perciò l'interazione con molteplici culture era poco "contaminante") per l'assenza di una cultura alle spalle, oggi esso rimane alto per più motivi: perché, come detto, l'identità è espressa dal dinamismo stesso (per essere riconosciuti come bravi jazzisti non basta riprodurre, è necessario innovare); perché alla base del jazz c'è, come diceva George Russell, la musica folk (un tempo quella del popolo nero, poi quella popolare americana, in seguito quella dei paesi nei quali il jazz è approdato), la quale - essendo non istituzionale - è sempre in evoluzione naturale; infine, perché la comunità che prende parte al jazz è relativamente ristretta, e perciò ha tempi di assimilazione più brevi.
Ma, si badi, questo non significa che nel jazz non esista "contaminazione negativa": anche qui, combinazioni culturali troppo brusche e, soprattutto, non ben radicate nella comunità che produce e ascolta, possono essere pericolose. Un esempio lo si è visto anche a Cormòns, con il gruppo di Nicolas Simion, nel quale l'identità era troppo frammentaria, l'accostamento tra stilemi folklorici esteuropei e tradizionalmente jazzistici troppo poco assimilato, l'urgenza dell'intreccio poco sentita (se non per esigenze di spettacolo), così che l'esito era tangibilmente privo di un significato profondo.
In questi casi, come ben segnalava Festinese nel suo intervento (ma come a suo modo diceva Stefano Bollani nell'intervista rilasciatami qualche mese fa), l'unico antidoto è l'ironia: ostentare l'inserto esotico, citare la cultura altra in modo caricaturale, può servire ad evitare la contaminazione nociva. Ma questo, sia chiaro, solo perché queste forme di ironia conservano l'identità culturale di partenza non meno della sua difesa da ogni intrusione estranea: l'ironia, infatti, colpisce il diverso e lo denuncia tale; "prende tempo" prima di assumerlo ad elemento della cultura di partenza; lo tiene a parcheggio sulla porta dell'identità.
L'ironia non è "contaminazione" perché non è neppure autentico intreccio, ma solo ludico incontro di diversi che si dichiarano tali e non si fondono, anzi, talvolta perfino si tengono intenzionalmente a distanza.
Foto di Fabio Gamba
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.