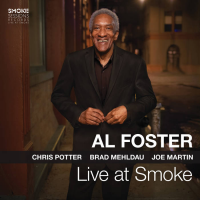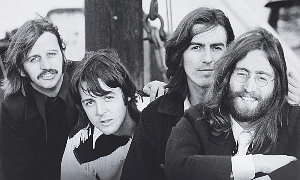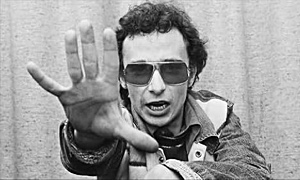Home » Articoli » Book Review » Silenzio
Silenzio
di John Cage - trad. Giancarlo Carlotti
Shake Edizioni - 2010
[Silence, ed. or. 1961, Wesleyan University Press].
"Silence" è la quintessenza del pensiero cageano. Contiene alcuni degli scritti più importanti e celebri di John Cage. Raccoglie ciò che fino al 1961 interessava Cage e la sua ricerca, a volte, come dice lo stesso compositore americano, in una forma insolita e poco convenzionale. Silenzio e rumore, paradigmi assoluti e relativi, sono concetti sviscerati nei dettagli, ma allo stesso tempo Cage li rende pratica ed esperienza del quotidiano. E gioca, con parole, pause, caso. Sperimenta e gioca anche nella forma scritta e nel modo in cui proporla al pubblico. "Però questo gioco," come dice Cage, "sarà un'affermazione della vita, non un tentativo di ricavare l'ordine dal caos e nemmeno di suggerire miglioramenti nell'attività creativa, ma semplicemente una maniera di risvegliarci alla vita stessa che stiamo vivendo, che sarebbe straordinaria se soltanto riuscissimo a escludere la mente e i desideri, lasciando che scorra come vuole" (p. 21).
Bisogna leggere "Silenzio" dimenticandosi di John Cage. E poi leggere John Cage dimenticandosi di "Silenzio". Uscire dal mito di Cage, compositore anarchico e dadaista, scordarsi della mitologia sul pezzo silenzioso, tuffandosi piuttosto nella sua sola musica e nelle sue sole parole. Non so bene che ne può uscire, forse una lettura più filologica e lineare, di un John Cage aderente al suo tempo, al suo pensiero, al suo fare e pensare musica. Privare John Cage della sua aurea. Leggere ogni singolo saggio contenuto in "Silenzio" contestualizzandolo, dandogli l'opportuna prospettiva storica, prestando attenzione alle sole indicazioni che Cage fornisce, e poi scandagliare parole, significati, forma e disposizione del testo. Limitare "Silenzio" a "Silence," al volume quale Cage l'ha scritto, concepito e dato alle stampe nel 1961, a Middletown, dalla Wesleyan University Press, senza echi successivi.
"Silenzio" raccoglie una serie di più o meno brevi saggi e conferenze scritti da John Cage tra la fine degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta. Saggi e conferenze di vario argomento e con diverse destinatari. "Scrivo articoli e tengo conferenze da più di vent'anni e spesso hanno una forma insolita (specie le conferenze) perchè ho adottatto metodi compositivi analoghi a quelli che usavo per comporre. Quasi sempre mi sforzavo di dire quanto avevo in mente in una maniera che l'esemplificasse, che permettesse, nei limiti del possibile, a coloro che mi ascoltavano di sperimentare quello che dicevo invece di limitarsi ad ascoltarlo. Questo significa che, essendo io impegnato in tutta una serie di attività diverse, cerco di inserire in ciascuna di esse alcuni aspetti che per convenzione sono invece limitati a una o più altre attività" [il corsivo è mio].
In queste poche righe che aprono la "Prefazione" (pp. 3-6) Cage ben sintetizza lo scopo del volume e pone l'accento su due aspetti, entrambi fondamentali, che devono allo stesso tempo fungere da chiavi di lettura dei vari contributi di "Silenzio" e da linee guida anche per l'ascolto dell'opera cageana: da una parte c'è l'esempio (l'exemplum, l'aneddoto), vale a dire l'esperienza e la pratica, dall'altra parte c'è un metodo (teorico-pratico) sempre uguale, che mostra una continuità di azione, perseguita, ricercata, usata in ogni ambito (dalla musica alla micologia passando per il gioco degli scacchi).
La traduzione che viene riproposta alle stampe oggi è benvenuta. Ben dieci anni dopo l'originale inglese, l'editore Feltrinelli, nel 1971, aveva edito una traduzione che per molti anni è stata di riferimento per il pubblico italiano. Oramai fuori commercio e non più riproposta, Shake ha pensato bene ad una riedizione in profumo di anniversari. Rispetto all'impaginazione dell'originale del 1961 [su cui abbiamo effettuato i confronti], la Shake ha volutamente cambiato molto poco, avvicinandosi anche per alcuni aspetti grafici e tipografici (scelta del font ad es.). Persino la traduzione di Giancarlo Carlotti è molto aderente al testo originale e si concede pochissime licenze. Un bene, sempre nell'ottica che Cage va assunto in forma più "integrale" e "pura" possibile.
I saggi contenuti in "Silenzio" sono preceduti ciascuno da alcune righe introduttive che spiegano dove, quando e per chi esso è stato scritto, e chiusi da un ulteriore testo, spesso di carattere aneddotico, in linea con quanto sopra. I primi saggi sono di particolare importanza. "Manifesto" (p. 7) sulla musica scritto per gli allora direttori del Living Theatre nel 1952, istantaneo e imprevedibile, è un condensato della filosofia cageana in forma grafica del tutto peculiare. Il 1952 è l'anno di 4'33''. Mai dimenticare la musica. Il saggio seguente "Il futuro della musica: il mio credo" (pp. 8-13) è di qualche anno precedente, del 1937, ed è stato inserito nella brochure che accompagnava la registrazione di George Avakian di un concerto a New York del 1958. Il testo si presenta distribuito in due parti: quella in maiuscolo, il cui testo suddivide le parti in minuscolo, è il manifesto vero e proprio riguardante il rumore, la musica elettronica, il rapporto tra presente e passato della musica, la parte in minuscolo è invece molto più discorsiva e si compone di paragrafi (anche due o tre per volta) che sembrano voler spiegare quanto sopra. Il saggio va senz'altro letto insieme all'ascolto degli Imaginary Landscapes. Stesso incipit: "credo che l'utilizzo del rumore proseguirà e crescerà fino a quando otterremo una musica con l'ausilio degli strumenti elettronici i quali metteranno a disposizione per fare musica ogni e qualsiasi suono che possiamo udire". Da qui gli esperimenti sui rumori, sugli strumenti elettronici, sulla riproduzione della musica, con un'attenzione costante alle percussioni.
"Musica sperimentale" (pp. 14-21) pubblicato nel 1957 è una definizione di cosa Cage intende per musica sperimentale. Sono gli anni in cui Cage sperimenta tecniche sul silenzio, sperimenta la camera anecoica ("sei pareti di materiale insonorizzante allestito in modo da ottenere una camera priva echi"). Musica nuova: ascolto nuovo. Teorica e pratica. "Musica sperimentale: dottrina" (pp. 22-28) comprende un illuminante dialogo tra un insegnante che non scende a compromessi e uno studente poco illuminato. La sperimentazione messa in pratica.
I tre saggi, "Composizione come processo" (pp. 29-70), "Composizione" (pp. 71-74), "Per descrivere il processo compositivo usato in Music for Piano 21-52" (pp. 75-77), riproducono conferenze tenute a Darmstadt nel 1958.
La prima, suddivisa in tre parti distinte, è di grande rilievo teorico. Nella prima parte "Cambiamenti," sviluppata su colonne parallele nelle quali il testo non scorre in forma continuativa, Cage discute Music of Changes e le operazioni aleatorie da lui eseguite in sede compositiva; la seconda parte, "Indeterminazione," in corpo minuscolo (che "punta a sottolineare il carattere volutamente solenne di questa lezione"), confronta il metodo usato per Music of Changes con il metodo di altri compositori del passato (Bach) e contemporanei (Feldman, Brown, Wolff); la terza, "Comunicazione," è un elenco di domande il cui ordine e la qualità delle citazioni sono state decise dal caso.
La seconda e la terza conferenza, entrambe ruotanti attorno al tema della "Composizione," sono state rispettivamente scritte "per descrivere il processo compositivo usato in Music of Changes e Imaginary Landscapes e per "per descrivere il processo compositivo usato Music for Piano 21-52. Inutile dire che chi si avvicina all'ascolto di Imaginary Landscapes e Electronic Music for Piano [il cui materiale di base è costituito per l'appunto da Music for piano] deve leggersi i saggi di cui sopra.
L'articolo "Precursori della musica moderna" (pp. 78-84) collega la parte dedicata a Cage e ai suoi metodi compositivi ad una serie di interventi di carattere più storico. Il profilo di questo articolo è ancora decisamente teorico perché Cage procede su una serie di definizioni e assunti ("lo scopo della musica," "definizioni," "strategia"... "a caso") con dettagliata spiegazione terminologica. "Storia della musica sperimentale negli Stati Uniti" (pp. 85-96) è una illuminante sintesi sulle (allora) nuovi correnti musicali, il rapporto della musica sperimentale con l'elettronica. "Erik Satie" (pp. 97-106) riproduce una discussione immaginaria tra Cage e Satia, "Edgard Varèse" (pp. 107-110) è un contributo dedicato ad uno dei "maestri" di Cage.
Segue una sezione dedicata all'arte, con due interventi, "Quattro dichiarazioni sulla danza" (pp. 111-126) e "Su Robert Rauschenberg, artista, e sulla sua opera" (pp. 127-140), sono particolarmente significativi perché illsutrano bene quali e profondi intrecci ci siano tra arte, danza, musica, disegno nell'opera cageana.
Di taglio decisamente sperimentale le tre conferenze "Conferenza su niente" (pp. 141-161), "Conferenza su qualcosa" (pp. 162-180) e "45' per un oratore" (pp. 181-230). "Conferenza su niente," scritta nel 1959, è suddivisa in "quattro misure su ogni riga e dodici righe per ogni unità della struttura ritmica". L'intero brano è suddiviso in 48 misure e in sezioni. Va letto da sinistra a destra, non lungo le colonne, e "non va fatto in maniera artificiosa," "con il rubato che utilizziamo nei discorsi di tutti i giorni". Obbligatorio l'ascolto di "Lecture on Nothing" nell'interpretazione della violoncellista francese Frances-Marie Uitti nel CD Cello, Voice and Instruments.
"Conferenza su qualcosa" è strutturata in modo analogo ed è di particolare importanza per quanto esprime sulla musica di Morton Feldman. "45' per un oratore" andrebbe letta insieme all'ascolto di 34'46.776'' for two pianists. Il testo è lunghissimo, suddiviso meticolosamente e precisamente, in parti di tempo a cui corrispondono parti di testo. Testo con evidenziati, indicazioni per la lettura, riferimenti alla musica. Silenzio, rumore, alea, caso, matematica. Tutto ma proprio tutto Cage. Sarebbe bello poterne riprodurre la partitura e vedere una performance. On line ho trovato un'anima-typographic realisation of one sentence by John Cage tratta da questo discorso.
"Dove andiamo? E che cosa stiamo facendo?" (pp. 231-299) è stato scritto usando il brano Cartidge Music per comporre i testi. I brani che compongono questo lungo testo sono disposti su quattro diverse colonne per essere letti simultaneamente. Grasetti, corsivi e diverse diposizioni (anche vuoti) segnano il particolare andamento di queso testo. "Indeterminazione" (pp. 300-321) è stato scritto nel 1958 in un albergo di Stoccolma, sapendo che al momento della lettura tra il pubblico ci sarebbe stato Karlheinz Stockhausen. Molti eventi musicali si incrociano a questo scritto, che ha come sottotitolo "Muovo aspetto della forma nella musica strumentale ed elettronica," senza dubbio importante owerchè continene numerosissimi aneddoti (disposti su due colonne), messi insieme da Cage "per suggerire che tutte le cose, le storie, i suoni casuali dell'ambiente, e per estensione gli esseri, sono collegati, e che questa complessità è più evidente quando non è ipersemplificata da un'idea che alberga nella testa di una persona (p. 300). Un manifesto! Spassoso!
Chiude "Vademecum per musicofili" (pp. 322-325) scritto nel 1954 per la "Unites States Lines Paris Review," dedicato al tema dell'umorismo. Tra funghi e sperimentazione. Da leggere nello spazio immenso del cielo. Appunto.
A chiunque possa interessare, come la dedica dello stesso John Cage.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.