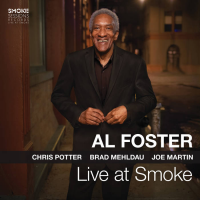Home » Articoli » Lyrics » Per Charles Mingus & la sua voce. "One, two, three, four...
Per Charles Mingus & la sua voce. "One, two, three, four. Ba coo pah che pee doup la ca singala coupa la caah!"
1. Il titolo. Ho già utilizzato un titolo dal sapore mingusiano per un saggio sul cinema afroamericano che avevo intitolato "Tre o quattro sfumature di... nero" e riesco ad applicare la stessa immagine coloristica così ai diversi gradi di integrazione culturale - ovvero di passing - della cultura afroamericana, così ai cromatismi straordinari di un pittore della Harlem Renaissance come Aaron Douglas, così ai blacks, browns & beiges ellingtoniani. Ora, so come si scrive il titolo di questo intervento - l'ho trascritto parola per parola dalla pagina 106 di un'edizione Penguin di Beneath the Underdog (1971), l'autobiografia di Charles Mingus - ma non saprei come pronunciarlo, né so come lo leggerebbe Charles Mingus, che l'ha scritto. Mi mancano ritmo, onomatopea, glossolalia, cacofonia - sempre che un jazzofilo non sia in grado, per come gira la scrittura, di identificare al volo un qualche riff, uno standard, una composizione. Il nucleo dell'intervento che segue riguarderà alcuni aspetti della ricezione di Charles Mingus, in particolare nella letteratura afroamericana, con alcuni accenni all'uso della scrittura, della parola e della voce nella sua musica.
2. La copertina. Spesso mi capita di aprire certi miei interventi con una copertina sonora, con delle epigrafi musicali; di solito le lascio senza commento, confidando che il senso delle scelte si chiarisca man mano. Qui le citazioni, quantomeno virtuali, potrebbero essere due: la prima clip sarebbe un frammento da "Jazz Thing" di Branford Marsalis con Gangstarr e Guru,[Nota 1] là dove risuonano le parole "Charlie Mingus / such nimble fingers / dropping the bass all over the place", classica epifania mingusiana - quel corpo, quelle dita... Mingus Fingers - fino a sfumare, dopo il break, alle parole che annunciano "John Coltrane".[Nota 2] La seconda sarebbe l'incipit di "Liberator of the Spirit," un'incisione del poeta losangeleno Kamau Daa'hood, accompagnato dalla batteria di Billy Higgins,[Nota 3] là dove suona la citazione "I don't play jazz: it's nigger music - Charles Mingus" prima che la voce sfumi, anche qui, su "John Coltrane".
3. Incipit: partire da un Coltrane Poem. "Liberator of the Spirit" può essere definito, a ragione, un "Coltrane poem". I Coltrane Poems sono ormai un vero e proprio genere letterario, un corpus sterminato, dato che John Coltrane è sicuramente il musicista di jazz - ancora più di Charlie Parker, di Miles Davis o di Duke Ellington - su cui si è più esercitato l'universo poetico, letterario, affettivo afroamericano (ma non solo) degli appassionati di jazz.
E' curioso che il mio spoglio alla ricerca di un analogo corpus di Mingus Poems non abbia praticamente dato frutti, ovvero poca cosa, come l'affettuosa bacchettata di Larry Neal, grande poeta, "Don't Say Goodbye to the Porkpie Hat," pure dedicata a "Mingus, Bird, Prez, Langston, and them";[Nota 4] oppure "Mingus at the Showplace" di William Matthews, tra il ricordo personale, un'aneddotica un po' troppo ripetitiva e un'evidente nostalgia per il mondo dei jazz club che non ci sono più - "And I knew Mingus was a genius [...] So I made him look at the poem. / 'There's a lot of that going around,' he said, [...]. He laughed / amiably. He didn't look as if he thought / bad poems were dangerous, the way some poets do. [...] Of course later / that night he fired his pianist in mid-number / and flurried him from the stand. / 'We've suffered a diminuendo in personnel,' / he explained, and the band played on" -, oppure ancora il Paul Beatty di "Sitting on Other People's Cars," in cui un cd di Mingus fa da cornice alla poesia ma resta labile traccia della memoria, supporto per "the reverb of the Mingus years" che danno ancora i brividi.[Nota 5]
E' davvero poco, troppo poco: Mingus è decisamente citato meno di altri par suo della storia e della cultura del jazz. Certo, il contrabbasso non è il sassofono, né il pianoforte, né la tromba, né la batteria nell'immaginario popolare del jazz, eppure stiamo parlando di un musicista, di un compositore - forse secondo soltanto a Ellington -, non solo di uno straordinario interprete di quello strumento.
La complessità lapalissiana della sua musica e l'imponenza della sua figura devono aver tenuto a distanza le emozioni del grande pubblico (afroamericano), anche quando Mingus ha trovato risorse straordinarie nel gospel della Black Church, negli shuffles, nel blues, per di più resi con le risorse della cultura popolare e con il canto. E' fortissima in lui l'influenza dello spettacolo, dell'entertainment, della "jump music", del vaudeville. La conseguenza è una "cantabilità" costantemente cercata, pervicacemente perseguita con quella grana ruvida della sua voce inconfondibile (e fa tenerezza ascoltare nei ricordi di Sue Mingus che quando Charles non suonava ormai più, "he sang with a feeble voice into a tape recorder").
Insomma, è come se Mingus - più di Monk, più di Sun Ra - sia davvero un altro pianeta, di cui si scopre qualcosa sempre "in retrospect", e sempre con il beneficio del dubbio. In Black Music (1968) Amiri Baraka quasi non lo nomina, se non in una parentesi: parlando del "doppio quartetto" dell'Ornette Coleman di Free Jazz come della cesura che apre gli anni sessanta, gli viene in mente "pensandoci meglio," in retrospect, che "it seems now to me that some of bassist Charlie Mingus' earlier efforts, e.g. Pithecanthropus Erectus, provide a still earlier version of this kind of massive orchestral Breakthrough"[Nota 6]. Insomma, Mingus era sempre arrivato lì prima...
Non è necessario ricorrere a espressioni come "potere profetico," pure utilizzate dallo stesso Mingus, per capire quanto egli fosse soggetto di un meticciato culturale e diasporico ante-litteram, capace di praticare l'attraversamento continuo, dinamico dei confini - identitari ed espressivi insieme -, forse senza nemmeno rendersene conto appieno: la durezza dello scontro razziale ai suoi tempi non ammetteva ancora la possibilità di lavorare intellettualmente in profondità sull'idea di multiculturalità, nozione che sarebbe stata compiutamente elaborata solo in seguito.
4. Debiti affettivi e Mingus come "feticcio" intellettuale. Qualcosa di interessante in giro c'è, però, ad esempio nell'introduzione che un critico come Craig Werner antepone al suo A Change Is Gonna Come (1998). Tuttavia, anche in questo caso c'è una specie di Mingus "postumo," o almeno "posteriore," dato che nel precedente Playing the Changes. From Afro-Modernism to the Jazz Impulse (1994), saggio sicuramente più importante e dalla posta intellettuale più alta, il nome di Mingus nemmeno figurava:[Nota 7]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nello scrivere questo libro, sono finito spesso ad ascoltare la musica di Charles Mingus, in particolare "Meditations on Integration" e "Haitian Fight Song," per rinnovare la mia energia spirituale e la concentrazione intellettuale. Uomo intensamente introspettivo, Mingus sapeva che anche il lavoro più solitario acquista significato attraverso il rapporto che stabilisce con il mondo esterno. Nel catturare la complessa energia del movimento per la liberazione, "Haitian Fight Song" fornisce un modo per pensare alla relazione tra lavoro intellettuale e movimenti sociali. Solo e confuso, Mingus raccoglie i propri pensieri e inizia a testare la propria voce nell'assolo di basso che apre il brano. Gradualmente entrano gli altri strumenti, riprendendone il fraseggio, aiutando Mingus a valutare quello che funziona e quello che non funziona. Prende forma un ritmo incalzante e Mingus esce allo scoperto, nel mondo, chiamando la propria comunità a unirsi alla lotta. Il ritmo cambia, indugia, ritrova il suo centro, incontra resistenza, ma procede comunque.
[...]
[La storia che Mingus racconta in "Haitian Fight Song"] è una storia su come le voci dei singoli individui trovino il loro tono più vero quando si uniscono ad altre, su come si debba fare i conti con i nostri limiti, su come si possano condividere le nostre intuizioni, su come ci si metta insieme per cercare di cambiare il mondo. In "Haitian Fight Song" Mingus crea un mondo musicale complesso in cui la voce che ha trovato nell'oscurità subisce dei cambiamenti man mano che altre voci entrano e se ne vanno, in frustrazione e trionfo. Il significato che vuole dare è chiaro: non possiamo mai separare ciò che siamo dalla gente intorno a noi. [Nota 7] Il loro destino è il nostro.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
E' un modo legittimo per inquadrare Mingus alla luce del principio dialogico che articola, secondo il discorso critico oggi comunemente accettato, il modello dinamico della cultura afroamericana, che lo chiamiamo call and response o Signifyin(g) o altro. Certo, il call and response sta alla base della politica del gospel con quel suo meccanismo semplice, diretto: una voce individuale (un leader, un predicatore, un cantante) si esprime in modo da stimolare una reazione. La risposta potrà essere verbale, musicale, fisica - qualsiasi cosa in grado di segnalare una comunicazione. Essa può affermare, contestare, reindirizzare il dialogo, sollevare nuove domande. Qualsiasi risposta che ottenga attenzione e solleciti un'ulteriore reazione diventa una nuova "chiamata". Solitamente, chi lancia la prima sollecitazione risponde alle risposte, restando il punto focale del dialogo in fieri:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Charles Mingus, affascinato dalle implicazioni politiche e spirituali del call and response, ha esplorato varie idee di comunità basate sulla ridefinizione costante della relazione tra gruppo e leader in "Wednesday Night Prayer" e "Three or Four Shades of Blue".[Nota 9]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5. Multiculturalismo. Ma non è necessariamente sempre così... e proverò a spiegarmi con un esempio. Di recente, lavorando su una nuova edizione italiana di Mumbo Jumbo,[Nota 10] ho risfogliato i blurbs delle varie edizioni del romanzo: il suo autore, Ishmael Reed, è stato spesso assimilato a un Charlie Parker o a un Mike Tyson della letteratura. Penso ora che calzerebbe piuttosto - nonostante l'affiliazione letteraria del "nostro" - una tag/gag come "il Charles Mingus della letteratura," per motivi di sostanza. Se il (pregevolissimo) multiculturalismo dichiarato - in tempi non sospetti - di Reed anticipa i tempi, l'afflato multiculturale di Mingus - stratificato, complesso, a volte naïf, forse in parte inconsapevole, condizionato com'è dalla temperie culturale e dalla realtà politica dei tempi, lotte per i diritti civili & all the rest - resta una chiara traccia di energia potenziale, ma di sensibilità acclarata.
E se Mingus non trova le parole per definire meglio un paradigma del genere - per articolare il quale sarebbero serviti quei nuovi lessici che sarebbero arrivati di lì a un paio di decenni almeno - la sua musica e la (sua) voce nella musica mi pare dicano già tutto.
Insomma, tra un Mingus stretto tra, da un lato, il dialogismo bachtiniano e la sua versione (vagamente nazionalistica, afrocentrica) del Signifyin(g)[Nota 11] - che pure è da valutarsi un'efficace griglia culturale e interpretativa, se usata non superficialmente - e dall'altro lo "stadio dello specchio" lacaniano, mi piacerebbe che si lavorasse a consolidare l'ipotesi - "retrospettiva," non dietrologica - di un Mingus multiculturale ante-litteram, pluridiscorsivo e sinergico. I sintomi dei suoi detti, e soprattutto dei suoi non-detti, ci sono tutti.
6. Willner. Provo ora a campionare qualche esempio, paradossalmente Mingus senza Mingus, a partire da un'altra operazione del recente passato: trovo infatti particolarmente interessante il lavoro, affettivo e (probabilmente) critico insieme, di Hal Willner sulla musica di Mingus che ha preso corpo in Weird Nightmare (Columbia 1992). Non entro nel merito delle interpretazioni musicali, certo mi è chiaro il tentativo di restituire Mingus a un soundscape attendibile oggi, quello di una grana sonora che trova la propria complessità non nella scrittura, ma nel metissage, nella contaminazione, nella fusione, tra generi e forme.
Insomma, Mingus era davvero così avanti nel concepire una musica stratificata dall'universo sonoro che aveva in testa, che è persino logico che non la potesse (non la volesse) chiamare jazz, non perché quella fosse nigger music, bensì perché il suo progetto, la musica che gli girava intorno e gli suonava dentro, era alla disperata ricerca di far risuonare tutte quelle cose che si incrociavano e attraversavano i confini delle nostre percezioni e delle nostre codificazioni.
Provatevi a riascoltare per esempio "Foggy Day" (in Pithecanthropus Erectus, 1956) e a condividere l'infantile, gioioso abbandono ai rumori della strada, fischietti sirene clacson, con cui Mingus stesso si intrattiene anche nelle note di copertina dell'album:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In realtà il sottotitolo sarebbe "A Foggy Day in San Francisco" perché non sono mai stato a Londra e ho raccolto questi suoni dalla Bay Area. Si potrebbe essere tentati di sorridere a un primo ascolto - e una bella risata non ha mai fatto male a nessuno - ma a un secondo ascolto provate a immaginare il tenore che suona la melodia come John Doe che discende Market Street fino al Ferry Building, fino ai traghetti, e ascolta i suoni di una grande città in un giorno di nebbia - il rombo [rumbe] dei camion, il fragore [clang] del tram, lo stropiccìo [scuffle] della folla, la baraonda [jumble] del traffico, il lamento [moan] delle sirene della nebbia, il fischietto dei poliziotti, i clacson delle automobili, l'ubriaco avanzato dalla notte prima che si ingolla l'ultimo quartino, e quel dannato fischio di mezzogiorno che mi svegliava sempre! Tutti quei suoni fanno musica, parecchia. Ho cercato di riprodurne un po,' musicalmente, e se riuscite a vedere quelle immagini mentre ascoltate il brano - anche il ferry boat, tra le sirene per la nebbia che si ferma con un cigolìo [creak] alla banchina (così riprodotto dal contrabbasso) - allora ci sono riuscito. [Nota 12]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dicevamo di Hal Willner: nel "suo" Weird Nightmare c'è la radio in "Pithecanthropus Erectus" (manipolata da un Willner straordinario collezionista di "Americana radiophonica": all'ascolto mi pare che il materiale utilizzato sia qui quello, invero un po' abusato, della War of the Worlds di Orson Welles), quella stessa radio interiorizzata da Mingus in modi di cui vorremmo sapere di più, ma dei quali ci rendiamo assolutamente conto quando ascoltiamo la sua voce (dj e comedians sono le personalità di maggiore influenza nella cultura che si propaga, inconsapevolmente, attraverso la radio, e il jazz troverà nella radio un veicolo di diffusione tanto insperato quanto serendipitous: quanti sono stati i jazzisti, Mingus compreso, folgorati sulle vie dell'etere, toccati a vita dall'ascolto di grandi del jazz!). Credo che Mingus trovi la sua comedy in buona misura nella radio di comici e vaudevillians; certo, in Beneath the Underdog, la radio diventa il suo vero maestro di jazz:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aveva fretta di corteggiare le ragazze più carine della città, così il mio ragazzo chiamò Britt Woodman e chiese il numero di Joe Comfort. Joe era il bassista dei fratelli Woodman, la migliore orchestra di jazz di Watts, composta da giovani musicisti.
"Come faccio a imparare a suonare il basso, Joe?"
"Ce l'hai?"
"Sì"
"Accendi la radio, seguila e suona. Io ho cominciato così".
Senza nemmeno sapere le note delle corde né come si accordasse lo strumento, Charles iniziò a esercitarsi per ore in piedi accanto al mobile-radio RCA Victor del soggiorno e dopo qualche settimana cominciò a raccapezzarsi. [Nota 13]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Se si ascolta bene la "Pithecanthropus Erectus" di Weird Nightmare, i particolari strumenti "americani" di Harry Partch con le loro "eerie vibes" (Willner) - un deciso taglio apocalittico, metafisico sull'anima americana - suonano appropriati, quasi la controparte dell'altrettanto quintessenziale americano, ovvero Charles Ives, cui Mingus è stato più volte accostato: ricerca della musica dell'anima, dei suoi suoni fuori-scala, di tavolozze inedite.
Insomma, con Willner c'è la voglia di far rileggere Mingus - così certi suoi brani dotati di testo, così alcune pagine inedite della sua autobiografia - a chi ne sappia interpretare in profondità gli aneliti. Occorre disseminare e tenere insieme le diverse voci di Mingus; così, schizofrenicamente, sono interpreti differenti a convocare "la voce" di Mingus: allora, buon per l'anima quasi-indiana di Robbie Robertson, per l'integrità da epigone dei Beat di Henry Rollins, per l'energia sfrontata di Chuck D, per l'irriducibilità assoluta e poetica di uno come Hubert Selby Jr., per l'appropriatezza assoluta di Leonard Cohen impegnato in "Chill of Death" (uno dei primissimi testi di Mingus, datato 1939 o forse 1940, intorno al quale si avvolge comunque la voce di Diamanda Galas), per l'eclettismo sincretico di Dr. John (uno che ha saputo tenere convincentemente insieme le litanie dei santi con il vudù, il pianismo classico di Gottschalk con lo stride piano di New Orleans) e passi per il non convincente Keith Richards e per il pur bravo Elvis Costello.
Già - e sia detto tra parentesi - perchè ci si è messo anche lui a scrivere testi per brani di Mingus ("Don't Be Afraid, the Clown's Afraid, Too," "Tonight at Noon," "This Subdues My Passion" and "Self Portrait in Three Colors"), anche se parecchi critici ritengono che, nonostante il buon fluire poetico, non aggiungano molto alla musica, soprattutto perché l'uso di titoli come quelli di Mingus aveva uno scopo epigrammatico - stabilire il focus per le composizioni strumentali. Così come i testi di Joni Mitchell nelle sue canzoni mingusiane, quelli di Costello non tradiscono il senso della "necessità," né probabilmente servono alla musica.
Basterebbe ascoltare "Freedom" (1963), magari reinterpretata da Dr. John in Weird Nightmare - "This mule ain't from Moscow / This mule ain't from the South / But this mule's had some learning / Mostly mouth to mouth" - per capire come la pazienza del mulo diventi l'ostinazione di Mingus nello spiegare come mai i neri siano ancora "cittadini di seconda classe" negli Stati Uniti. La vocalità del blues fa risuonare il risentimento, la rivendicazione - "freedom!" - e il critico e poeta Lorenzo Thomas annovera Mingus tra i jazzisti-poeti con Sun Ra e Archie Shepp. Il finale - "Freedom for your daddy / Freedom for your momma / Freedom for your brothers and sisters / But no freedom for me" -, cantato da tutta la band, a livello esistenziale e non strettamente sociale, pare echeggiare nuovamente la solitudine che attraversa la biografia di Mingus, una specie di Natty Bumppo irriducibile.
7. La voce. La voce umana è per Mingus un riferimento imprescindibile: il grido, lo hollering, il canto, il rap (la parlata ritmata), la comedy, il call and response della Chiesa Nera come il Signifyin(g) dell'oralità da strada, gli insulti rituali del ghetto. In uno degli episodi di Jazz (2000), documentario-fiume di Ken Burns, c'è una bella clip di Mingus alle prese con "Fables of Faubus," con il testo che scorre sotto i nostri occhi, testo/voce/scrittura insieme, in una significativa fusione. In più però c'è la grana della voce che porta il significato - il gioco tra feno-song e geno-song nella teorizzazione di Roland Barthes -, ovvero quello spazio, tutto da esplorare, tra il cerebrale e il fonatorio, lungo la colonna d'aria che si tramuta in suono, amplificato dal corpo, entro cui la voce articola suono e significato, scegliendo esiti volta a volta diversi. Sono quei salti di significazione da "semiotica delle passioni," quantum leaps di una voglia di esprimersi, eccessi incontenibili, incontinenti, suoni di parole che il significato non contiene più. Insomma, è un po' quel che succede quando nel musical si passa dal parlato al cantato, ma, ancora meglio, e più misteriosamente, quando si passa dal camminare alla danza: nella scena di un qualunque film, quand'è che Fred Astaire aveva cominciato a ballare? Uso nel verbo la forma dell'anteriorità perché, quando ce ne accorgiamo, lui sta già ballando, aveva cominciato da prima a danzare: l'atto di camminare non riusciva più a contenere l'eccedenza di significato, passione che sfocia nel ballo.
Nel canto - quello che voglio sottolineare in Mingus - si ha dunque, spesso, una momentanea eclisse della parola: è come se si esplorasse un ambito redentivo, privo di parola, una meta-parola che letteralmente salva, ristabilisce e rinnova non solo la parola ma anche il mondo: nuove parole, nuovi suoni, nuovi mondi.
Credo di essere in sintonia con il protagonista di un romanzo (meglio, un work in progress narrativo) del mio scrittore afroamericano preferito, Nathaniel Mackey, poeta, narratore, critico finissimo, appassionato e cultore di jazz. In Bedouin Hornbook (1986), il personaggio in questione - un musicista di jazz che firma le sue lettere e le sue riflessioni "N." - riflette sulle possibili origini africane di questa meta-voce che sarebbe il falsetto (che, come sappiamo, ha una storia molto affascinante e inquietante nella Black Music, dal soul al R&B, da Al Green a Aaron Neville) poi finisce a dissertare sulla "musica non-vocale":
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Garantito" - scrive - "l'inarrestabile avanti e indietro tra parole e wordlessness, la dimensione di assenza di parola - vale a dire, tra 'segnale' e 'rumore' - parrebbe non applicarsi laddove non vi siano parole. In passato sono stato accusato di attribuire 'poteri verbali invero improbabili' a musica strettamente strumentale [...] ma il fatto è che gli strumenti parlano per davvero. Chiunque abbia ascoltato gli scambi tra Mingus e Dolphy nel brano di Mingus 'What Love' (Charles Mingus Presents Charles Mingus, America 30 AM 6082) non ha dubbi in proposito. (Dolphy una volta ha detto 'Be,' più o meno cerco di far parlare il sassofono.' E Mingus ha sottolineato, 'Facevamo proprio quello. Suonando chiacchieravamo per davvero')".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
E Mingus ha più volte testimoniato del suo rapporto con Danny Richmond come di una conversazione - "our playing is a conversation" -, naturalmente filtrata da una "buona educazione": c'è la presentazione poi seguono educati turni di parola.
E che poi si parli per davvero letteralmente "dentro" la musica, lo si evince con grande divertimento in Beneath the Underdog - due belle sequenze alle pagine 106 e 114 della stessa edizione Penguin citata in apertura - dove i musicisti conversano del più e del meno, schiamazzando pettegolezzi, nel bel mezzo di un'esecuzione, mostrandosi magari infastiditi dalla noncuranza degli altri giusto nel bel mezzo del proprio assolo. Ma chi ha mai detto che nell'autobiografia di Mingus il jazz viene trascurato e messo da parte? Il fatto è che la musica è implicitata, tra le righe, ma risuona potente, materica, metafisica, simbolica, referenziale insieme... cortocircuitata e viva entro il testo.
8. Identità. Che poi quella voce (quella pluralità di voci) implichi un'identità (un coacervo complesso di identità) è evidente: "In other words I'm three", incipit di Beneath the Underdog, ha la medesima, straordinaria forza di "I'm an invisible man" del trombonista mancato Ralph Ellison, apertura del suo capolavoro Invisible Man (1952). Tra essere schizofrenicamente alla ricerca di un'identità ed essere invisibili non passa poi troppa differenza, quel che conta è la latitanza di un appropriato senso di appartenenza. Quasi inutile ripercorrerne gli esiti e l'aneddotica nella vita di Mingus: scampoli alla rinfusa con Sue Mingus che ricorda "he tried to be a Mexican [...] too light to be black, too black to be white", Celie, la moglie precedente, che dice "he was in a no man's land", ancora Sue che sostiene "tried to figure out he couldn't join anything", mentre lo stesso Mingus ricorda "My hair was not beautiful nappy, my skin was not dark black, beautiful like they were" [...] "they called me half-yellow sick colored motherfucker" e Dorian Mingus (figlio di Celie) che ricorda che Mingus, malato, convoca i figli e dice loro "You are no color".
Interessante che sia proprio Mingus a scrivere/eseguire la colonna sonora di Shadows (John Cassavetes, 1958), sullo stile diretto e crudo del cinema-verité che definisce la cultura bohémienne del Village ma, soprattutto, film sul razzismo e la problematica del "passing" che così tanto e così profondamente lo coinvolge (nel film il contrasto nasce in una famiglia nera con due fratelli - uno musicista/cantante, l'altro un hipster mulatto vagamente alienato - e una sorella che verrà lasciata dal fidanzato bianco quando scoprirà la sua, di lei, "vera" identità razziale).
Ora - sempre con in mente e nelle orecchie certe voice(s) over di un cinema ai confini con il documentario - potremmo ascoltare "Scenes in the City" da A Modern Jazz Symposium of Music and Poetry (1958). E' un frammento che spinge decisamente in avanti la lezione poetica e performativa di Langston Hughes, con cui Mingus pure aveva inciso. L'attore Lonnie Elders è l'autore del testo - a sentire Nat Hentoff, l'estensore delle liner notes originali, aiutato dallo stesso Mingus a mettere "in forma" le parole - mentre la voce recitante è quella di Melvin Stewart, attore del Karamu Theater di Cleveland trasferitosi a New York. Gli echi sono ancora vagamente hughesiani e probabilmente imitativi, sia pure prosciugati della pallida compiacenza eisenhoweriana, ad esempio, di una pietra miliare come Weary Blues (1958), ma l'elemento di sicuro impatto è una meta-discorsività spinta e voluta: è già jazz che parla di sé stesso mentre si fa davanti ai nostri occhi, mentre si costruisce nelle nostre orecchie e si rilancia, rimandando ai nomi dei suoi interpreti, ai titoli delle composizioni famose, ai modi di suonare, alla grana dei suoni. E' quello che Stephen Henderson nel suo pionieristico Understanding the New Black Poetry. Black Speech & Black Music As Poetic References (1973) annota come "musica nera come riferimento poetico" attraverso il decalogo delle sue strategie testuali:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Il riferimento casuale, generico; 2. L'allusione precisa ai titoli dei brani; 3. Le citazioni da testi di composizioni; 4. L'adattamento di forme di canzone/composizione; 5. L'uso della memoria tonale quale struttura poetica; 6. L'uso di accurate notazioni musicali nel testo; 7. L'uso di un'ipotetica risposta emotiva incorporata nella poesia: il "correlativo soggettivo"; 8. Il musicista quale soggetto / poesia / storia / mito; 9. L'uso dei gerghi della jazz life; 10. La poesia come "partitura" o "spartito".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Certo, a ben vedere, questo è anche il clima "sonico," aurale della Beat Generation del "dig!" di John Clellon Holmes e di Jack Kerouac... è un beatnik soundscape riconoscibile, a proposito del quale Antar the Raven, leader dei blackmadrid - formazione che ha cercato di esplorare la zona grigia tra rap e teatro -, non esita a lanciare le sue accuse: tutti i Kerouac di turno avrebbero copiato da Mingus...
Per quanto, nel caso di Mingus, appaia assurdo cercare di identificare una poetica con una singola incisione piuttosto che indagare la straordinaria disseminazione di idee e filosofie compositive - così in progetti diversi, come nel tempo - a me pare che "Passions of a Man" (Oh Yeah, 1962) sia comunque un preciso, sintomatico momento-chiave. "Garbo laughs!"... "Mingus sings!" pare dirci Nat Hentoff nelle liner notes dell'album, epperò deve ammettere che "in parecchi dei capitoli della storia morale del nostro tempo registrati in precedenza, c'erano stati frammenti di urla, ruggiti, borbottii, falsetti affilati e altre eruzioni vocali che Mingus doveva ritenere necessari per la tessitura complessiva [della sua musica]". I salti di dimensione dovuti all'eccesso passionale, ovvero l'irrefrenabile urgenza dell'autoespressione, si somatizzano qui nella voce: è un Mingus "speaking in tongues", "parlato" da lingue sconosciute, o almeno inventate, tra il vudù di evocazioni acusmatiche e una drammaturgia aurale affratellata con l'audioart che potrebbe girare in radio. E' qualcosa che, per la grana sonora, si avvicina persino alle composizioni "simil-radiofoniche" di John Cage e che dà voce e cantabilità alla parte sommersa dell'iceberg della musica di Mingus, che pure quella emersa segnala e significa. D'altra parte, il rumore - quello semioticamente inteso e quello concreto - e la passione, la matematica e la furia sono la sostanza della musica di Mingus, ne sono il soffio vitale.
9. Coda. Al termine di questo girovagare intorno alla voce di Charles Mingus, per sigillare simmetricamente con una back cover, mi piacerebbe offrire - senza commento e senza chiudere alcunché "a tesi," teatralmente - la lettura di un frammento di prosa di Al Young, autore di acute musical memoirs. E' un brano di gran ritmo su cadenze jazz - quantomeno nella versi(ficazi)one originale -, denso di suggestioni legate al ricordo della voce di Mingus, delle sue battute, delle sue esclamazioni proverbiali, animate dall'aura affettiva che le riproduce per l'orecchio dell'anima:
Tutti i momenti mingusiani confluiscono in questo, l'unico momento possibile...
Mingus a mezzogiorno, tutto in bianco, con quel suo vestito alla Charlie Chan e il panama in testa, grasso e smagliante, che entra al Ninth Circle con la bella moglie Judy e loro figlia, piccolina, l'estate che mi fermai a New York prima di imbarcarmi per l'Europa su un cargo portoghese, la testa completamente in fiamme per "Nostalgia in Times Square," quel blues di Mingus così muscolare...
Mingus che lascia il palco del Minor Key sul Dexter Boulevard di Detroit e costringe Danny Richmond a sedersi alla batteria e a suonare tutto solo come misura disciplinare per essersi presentato al concerto in ritardo e ubriaco...
Mingus avvolto dal fumo delle sigarette al microfono del Jazz Workshop di San Francisco (mentre la pianista Jane Getz, occhiali scuri e pelliccia di leopardo, sta a guardare), che annuncia alla direzione del locale che pagherà il conto di un tavolo di clienti di colore: "A loro non piace perché ho una bianca al pianoforte, e allora se ne possono andare subito, pagherò io per quello che hanno bevuto!"...
La voce di Mingus (di nuovo nella luce abbagliante del quasi-mezzogiorno) al telefono con il figlio Charles Mingus III, che è in piedi con me al centro del loft del padre, sulla Third Avenue, ed io che riesco a sentire quello che Mingus sta dicendo al figlio: "Fai uscire Al Young di lì immediatamente e non fargli vedere né carte né manoscritti miei!"...
Mingus ancora al telefono, seduto accanto a me al bar; il concerto di San Francisco è finito e lui sta dicendo a qualcuno all'altro capo: "OK, d'accordo, va bene così, tanto ho un male incurabile!"...
Mingus all'ostello [YW-YMHA nel testo - NdT] della novantaduesima strada, dove sto tenendo un reading di poesia insieme a Philip Appleman, e lui e Sue Graham, diretti a un concerto di Stevie Wonder al Madison Square Garden, si sono fermati per vedere almeno la mia parte di performance, che Mingus pare dormirsi per intero, la testa reclinata e le mani conserte in grembo, ma alla fine, quando lo avvicino, lui sorride bonario e mi dice: "Davvero buono"...
Il Mingus di "Alice's Wonderland" (identificata anche come "Diana" e la sezione conclusiva, struggente del suo "Self Portrait in Three Colors") è con ogni probabilità il Mingus che preferisco; quello che mi fa ancora disegnare colombi che volano fuori dai sassofoni, che mi sibilano accanto con battute d'ali di silenzio mentre volano e si innalzano verso altre dimensioni, forse persino quella stessa piega del tempo sulla quale Mingus sta operando in questo preciso istante...
Mingus al Village Vanguard, che fa pagare il biglietto per assistere alle sue prove con l'orchestra del Jazz Workshop, cui Eric Dolphy ha portato un sax alto suo amico che siede con la band nella sua uniforme di impiegato delle poste e che suona l'assolo di "Orange Was the Color of Her Dress, then Blue Silk," il che spinge Mingus a fargli segno di andarsene e dire: "Ne abbiamo già uno Eric, non abbiamo bisogno di altri Eric Dolphy - e poi questo pezzo parla di una ragazza che ho incontrato nove anni fa e che non era triste come la suoni tu, era una gioia vederla!"...
Mingus a Monterey, è il settembre del 1964 e Arl ed io e il mio amico avvocato Gordon Lapides di Detroit e la sua fidanzata, la pittrice JoAnne Stoutemyer, siamo andati là in macchina per ascoltare la sua all-star band e, seduto nell'aura di quell'appassionato tributo a Duke Ellington, scoppio a ridere quando Mingus afferra il microfono e dice: "Duke, ti amo da matti. Ho rubato abbastanza"...
Mingus nel video della PBS A Duke Named Ellington che suona accordi e improvvisa su un pianoforte fatto di aria mentre spiega come Ellington fosse un genio dell'improvvisazione: "Quando accompagna i solisti, non ripete mai la sua composizione. La maggior parte dei pianisti ha uno o forse due modi di suonare un accordo, il che per me è molto triste e un grosso limite, perché ho avuto la fortuna di suonare con Duke e con Art [Tatum] e con Bud Powell; loro non ripetono mai quello che hanno scritto. Duke era capace di sedersi al piano da solo e, in venti minuti o anche solo dieci, ti suonava una sinfonia"...
Mingus mentre suona, che assume quell'espressione birbona di sollievo quando segnala ai musicisti che è il momento di un cambio di tempo, cosa che faceva sempre ogni volta che il tempo si irrigidiva o diventava troppo teso, o, come ha detto lo straordinario pianista e sassofonista di Boston Jaki Byard: "E' proprio ciò che rendeva suonare con Mingus uno sballo-la sua abilità nel sollevarti da alcuni degli inesorabili obblighi verso i solisti che altrimenti trasformano l'accompagnamento in una prova di resistenza"...
Mingus alla radio, la KPFA di Berkeley, con Phil Elwood, nel 1965: "Quanto guadagna la famiglia di Fats Waller ogni volta che vengono suonati i suoi dischi? La sua famiglia; non la casa discografica. Suo figlio si è ammazzato. Viveva in povertà; era un grandissimo sassofonista, alla Sonny Rollins. Viveva a Jamaica, Long Island. E ho visto la casa, e non riuscivo a capacitarmi che una persona così famosa potesse vivere in quella povertà da ghetto. Credo che [Fats Waller] fosse rispettato in tutto il mondo. Questo è un segno della schiavitù invisibile di questa società".
Mingus, Mingus, Mingus, Mingus...
NOTE
1 Dal soundtrack di Mo' Better Blues (CBS 1990).
2 Ricordo incidentalmente che Mo' Better Blues è il film che Spike Lee ha dedicato al Coltrane di "A Love Supreme". Il locale di jazz, centrale a tutta la vicenda, si chiama proprio Beneath the Underdog, evidente omaggio dal sapore affettivo (una curiosità: Ken Russell avrebbe voluto girare un film tratto dal libro ma, dopo averci pensato su per parecchio tempo, abbandonò il progetto).
3 Da Jazzspeak (New Alliance 1991).
4 In Hoodoo Hollerin' Bebop Ghosts (1968, 1974). Curiosamente, nella prima edizione raccolta l'unica dedica era per Langston Hughes.
5 Entrambe le poesie sono tratte da Sasha Feinstein & Yusef Komunyakaa (a cura di), The Second Set. The Jazz Poetry Anthology. Volume 2, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis 1996.
6 Leroi Jones (Amiri Imamu Baraka), Black Music [1968], Da Capo Press, New York 1998, p. 195.
7 Craig Werner, Playing the Changes. From Afro-Modernism to the Jazz Impulse, University of Illinois Press, Urbana/Chicago 1994; A Change Is Gonna Come. Music, Race & the Soul of America, Plume, New York 1999.
8 Craig Werner, A Change Is Gonna Come, cit., p. XVI [dove non altrimenti indicato, le traduzioni sono mie].
9 Ibidem, p. 11.
10 Cfr. Ishmael Reed, Mumbo Jumbo, Postfazione di Franco Minganti, Shake Edizioni, Milano 2003.
11 E' Stefano Zenni a suggerire tali ambiti nel paragrafo "Le voci di Mingus" nel suo Charles Mingus. Polifonie dell'universo musicale afroamericano, Stampalternativa, Viterbo 2002, pp. 94-100.
12 Qui si può solo accennare alla straordinaria importanza dell'immagine nell'universo di Mingus: colori, "musical paintings", ritratti sonori, spazi coreografati che tengono insieme musica e immagini in movimento, in continua mutazione reciproca (viene in mente ad esempio il poco conosciuto Blues from the Ghetto, special della PBS del 1966: drammaticità e teatralità della musica di Mingus coreografata da Elio Pomare).
13 Charles Mingus, Beneath the Underdog (edited by Nel King) [1971], Penguin, New York 1980, pp. 52-53.
14 Cfr. Lorenzo Thomas, "Music and the Black Arts Movement," in Krin Gabbard (a cura di), Jazz Among the Discourses, Duke University Press, Durham/London 1995, pp. 260-1.
15 Nathaniel Mackey, Bedouin Hornbook (Callaloo Fiction Series), University of Kentucky, Lexington 1986. Sia detto tra parentesi: ma dove lo trovate un jazz novel che mette nel testo i numeri di catalogo dei dischi?
16 Stephen Henderson, Understanding the New Black Poetry. Black Speech & Black Music As Poetic References, William Morrow & Co., New York 1973, p. 47.
17 Cfr. blackmadrid, "This Subdues My Passion" (Jazzspeak, New Alliance 1991) su testo di antar the raven (iniziali minuscole di prammatica).
18 Al Young, I Can't Get Started, in Janet Coleman & Al Young, Mingus/Mingus. Two Memoirs, Limelight Editions, New York 1991, pp. 156-159.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.