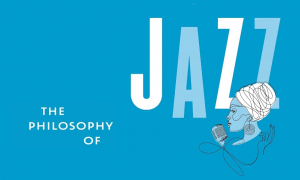Home » Articoli » Book Review » Paola Zannoner: Jazz! Racconti su scala modale
Paola Zannoner: Jazz! Racconti su scala modale
a cura di Paola Zannoner
Edizioni Effigi - 2011
"Questo volume di racconti del Laboratorio di scrittura di Massa Marittima "Scrittori di Massa" vuole essere un omaggio a Grey Cat, l'importante Festival Jazz presente da trent'anni nelle Colline Metallifere e da molti anni sotto la direzione artistica di Stefano "Cocco" Cantini, uno dei sassofonisti più apprezzati. Ogni anno il festival porta in Maremma grandi jazzisti del calibro di Ornette Coleman, Kenny Wheeler, Danilo Rea, Enrico Rava, Carla Bley, Pat Metheney, Stefano Bollani. Il jazz è il tema dominante delle narrazioni del libro. Passato e presente si alternano e si intrecciano in vite esaltate e trasformate da un linguaggio musicale che ha segnato profondamente un secolo e ancora oggi ha molto da dire. Il Laboratorio di scrittura narrativa di Massa Marittima "Scrittori di Massa" è nato nel 2003 promosso dalla scrittrice Paola Zannoner e dalla Biblioteca comunale "Gaetano Badii" di Massa Marittima. In questi anni il Laboratorio ha sviluppato numerosi progetti, ognuno concluso con la pubblicazione di un'antologia".
La sintesi della "quarta" di copertina compone in modo efficace occasione e contesti in cui collocare questi "racconti su scala modale," ossia: Vite modali (Giada Germani); Un diavolo caduto in volo (Franco Fedeli); L'uomo venuto dal jazz (Cinzia Murolo); La legge del contrabbasso (Claudia Chiti); Steinway & sons (Alessandra De Vita); Non parlatemi di jazz (Riccardo Bianchi); Il sassofono del Grassini (Roberta Pieraccioli); Nella camera oscura (Alberto Agostini).
Il volume rappresenta un ottimo strumento per valutare la modalità con cui la scrittura si confronta non tanto con la musica jazz quanto piuttosto con i suoi contorni auratici, con le situazioni e con i presupposti che la "ricezione" di questa musica ha stratificato nel corso del tempo nel bene e nel male. Si vuole suggerire, dicendo questo, che la scrittura si pone sempre in un rapporto particolare fra norma e scarto, fra invenzione e tradizione; e a seconda della adesione o della distanza, essa può offrire risultati diversi, non comparabili naturalmente fra loro quanto piuttosto con quello specifico immaginario nel quale essa trova alimento o crisi.
C'è una logica delle circostanze che lega questi racconti fra loro, e c'è una attenzione agli oggetti e ai luoghi che fanno parte del tessuto narrativo, della fisionomia del racconto. Ma il punto in cui si segnala un discrimine è, paradossalmente, fra scrittura e oralità, fra la logica della scrittura e la necessità dell'enunciazione che sottolineano il tentativo di aderire ad un fluire del discorso come necessità o meno di parafrasi della musica. Questo discrimine pare il vero portato del problema dell'ascolto delle parole, evidenziando l'elemento aurale che in ogni processo di scrittura è sempre sottinteso. Diciamo, per semplificare, che questo libro, trasformato in vinile, darebbe davvero il senso della traccia sonora che scorre nel fondo delle pagine. E come nel caso della registrazione musicale, il supporto materiale fa la differenza. Se, per ipotesi, ad ogni racconto fosse sotteso il brano musicale che sorregge la scrittura, noi potremmo avere una sorta di sinestesia, avremmo pagine da ascoltare e musiche da vedere.
Qui incontriamo un problema culturalmente rilevante, ossia il predominio della vista sull'udito. Credo che già i grandi sperimentatori di questo genere, ad esempio Kerouac o Ellison, avessero bene in mente questa necessità e questa urgenza: se questi racconti sono potenziali spartiti, quello che manca loro è la performance, cioè la loro esecuzione, che avviene nella lettura - per noi, come è consuetudine, silenziosa. Lo scrittore questo lo intuisce, ed è in questa direzione che bisogna muoversi per collocare correttamente il senso di questi racconti, cioè nel confronto fra materia sonora e scrittura, fra la sintassi e la logica della lingua e l'avvedutezza nel porre in rilievo la stratificazione dei suoni che compongono la frase.
Qui il jazz è il paesaggio sonoro, più o meno in rilievo, di un'epoca o di una psicologia. In questo non c'è qualcosa di sbagliato, è chiaro, ma il punto della questione è un altro. Il punto è capire se possiamo o meno forzare lo schema del linguaggio per avvicinarlo al discorso della musica. In questo senso, i contesti più o meno prevedibili, intendo i dati "ambientali" che reggono in maniera plausibile un certo tipo di narrazione, diventano sussidiari, non assurgono a ruolo di protagonisti. Il night-club, la biografia romanzata e "virata" sulla cronaca dell'epoca, non possono essere sufficienti a testificare l'essenza della materia narrativa. Dovrebbe essere invece il rapporto fra stile e ritmo il vettore principale di questo genere di sperimentazione. Dicendo "stile" bisognerebbe precisare il termine con un sintagma più complesso: "stile di pensiero," perché in fondo è questo di cui bisogna occuparsi, del rapporto fra pensiero e discorso, fra gli elementi multipli che costituiscono una poetica e l'esercizio di questa in termini performativi, come esperienza tanto singola quanto collettiva. La musica è la ricerca di uno "stile di pensiero" o "la comprensione delle cose" come recita una frase di Bird riportata come exergon di uno dei racconti (quello di Riccardo Bianchi). Un conto è la descrizione e uno è la comprensione delle cose. Comprendere porta in sé questo apprendere che è ad un tempo "imparare" e "possedere," ed è forse questo che rimane in definitiva come compito e scopo di questi esperimenti narrativi.
C'è una considerazione ulteriore da fare, e vale la pena riprendere alcune battute della presentazione del volume: "Passato e presente si alternano e si intrecciano in vite esaltate e trasformate da un linguaggio musicale che ha segnato profondamente un secolo e ancora oggi ha molto da dire". L'elemento biografico o autobiografico funge da "pretesto" (letteralmente) narrativo. Non c'è qui lo spazio per approfondire un tema estremamente complesso, tuttavia si possono offrire alcuni spunti circostanziati che magari possono essere dei validi presupposti per un ulteriore approfondimento.
A vari livelli in ciascuno dei racconti si assiste al tentativo di incrociare la musica con la storia privata e generale, quasi che questo fosse il mezzo necessario per ricomporre un'immagine altrimenti difficile da vedere nella sua complessità e spessore. Paola Zannoner, nella breve presentazione del volume, parla in modo appropriato del metodo di lavoro che è seguito all'ispirazione ("uno strumento, un interprete, una voce, uno stile") paragonandolo a quello di una piccola orchestra, nella quale "ciascuno ha lavorato sia per conto suo -affinando la propria tecnica espressiva- sia in sedute (prove) collettive, in cui è stato determinante il confronto e la discussione per calibrare toni, tempi, modalità di ciascun 'pezzo,' che mette in evidenza il tocco individuale nell'armonia dell'insieme" (p. 7). A questo corrisponde la semplicità e la fluidità di queste storie, sottolineando che la presenza incisiva di figure oramai assurte al ruolo di "classici" nulla toglie alla prospettiva di una novità di percorsi e di contaminazioni che sono il cuore stesso del jazz; e sottolineando come, d'altra parte, l'idea di un laboratorio narrativo, proprio come accade in uno studio di registrazione, sia il luogo nel quale convengono esperienze diverse che devono decantare individualmente e collettivamente la materia su cui dopo dovranno esprimere insieme il proprio punto di vista.
Dal canto suo, Stefano Cantini, aggiunge giustamente che il pensare in modo creativo rappresenta un rischio, ma è anche la benedizione corrispondente in termini di creatività per un artista. "Troppo spesso -aggiunge- sia nel cinema che nei libri dedicati ai grandi musicisti, il dramma personale prevale sulla vera forza artistica. Nessuno di chi ha scritto ha commesso questo errore" (p. 9).
Si può dire, complessivamente, che le cose stiano in questo modo, sebbene non sempre nella lettura dei racconti questa tensione e questa dinamica reggono costantemente e in modo convincente. Tuttavia il tentativo è davvero importante e questo tipo di lavoro non va soltanto approfondito ma "esportato," poiché possiede lo straordinario potere di avvicinare parole e musica in un intreccio profondo e non schematico. Forse si potrebbe sommessamente dare un ulteriore suggerimento: perché non incrociare questo cammino con quello delle arti visive? Penso a Basquiat, allo stesso Miles Davis pittore e all'infinita trama che le arti hanno sempre di più stretto fra di loro nel corso della storia del Novecento, storia che si può sovrapporre costantemente a quella del jazz.
Il merito che va sottolineato è di voler anche sottrarre il jazz ad un'idea troppo schematica di musica aristocratica e difficile, per restituire quello che è il suo carattere originario e profondo di musica popolare, la cui evoluzione, come del resto quella del genere narrativo, si è ramificata su diversi percorsi ma senza mai tradire la sua necessità fondamentale, quella di comunicare, quella di raccontare e di esplorare i vari aspetti della cultura entro la quale si colloca e si alimenta. Se si ha la capacità di rendere costante il confronto fra scrittura e musica, il risultato che si ottiene è quello di rendere sempre più accessibile, significativo e creativo il rapporto fra musica, lettura e ascolto.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.