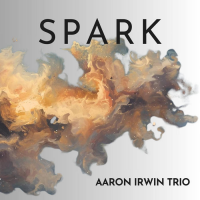Home » Articoli » Interview » Lo spazio del suono. Conversazione con Roberto Dani
Lo spazio del suono. Conversazione con Roberto Dani
AAJ: Come sei arrivato alle scelte artistiche che oggi ti caratterizzano, assai originali e personali, ma al tempo stesso di difficile rappresentabilità?
Roberto Dani: Direi che sia stato tutto piuttosto naturale. È una conseguenza della ricerca che ho fatto e che continuo a fare sullo strumento, perché il percorso prosegue. Una ricerca che mi ha portato a lavorare su realtà sonore tra le più disparate, soprattutto con formazioni ridotte: il duo, il trio, spesso anche la performance solitaria. E che al contempo mi ha spinto ad una rivalutazione dello spazio dove si suona, perché la cura delle dinamiche, ma non solo, richiede che si presti molta attenzione a quest'aspetto e più in generale al ruolo che gioca lo spazio all'interno della musica.
Lo spazio, in musica, non va inteso solo come "spazio fisico," ovvero come il luogo ove si suona, ma anche come spazio mentale. Lavorando nei modi che mi impone la mia ricerca ho potuto via via constatare l'importanza di suonare in spazi non convenzionali. Non necessariamente teatri, ma anche mostre d'arte, istituzioni culturali, fabbriche. Possibilmente spazi "vuoti," luoghi "flessibili," che possano favorire una gestione multifunzionale dello spazio e ove io possa interagire fin dalla preparazione della performance, sistemando in modo appropriato il luogo stesso - come mi pongo verso gli spettatori, la disposizione delle sedie, e così via.
Tutto ciò ha caratterizzato moltissimo la scelta dei miei progetti, anche se poi, assieme a questo, c'è il mio interesse per alcuni musicisti e compositori, che a sua volta mi ha spinto a certe considerazioni.
AAJ: Così come lo descrivi sembrerebbe un processo avviatosi principalmente dalla tua personale ricerca sullo strumento, che ti ha portato a valorizzare determinati aspetti. Come sei approdato a quel tipo di ricerca e cosa c'era prima nella tua biografia artistica?
R.D.: Direi di essermi mosso in modo abbastanza tradizionale, attraversando anche linguaggi musicali diversi e avvicinandomi al jazz a partire dalla tradizione. Tuttavia, il mio legame con una certa tradizione jazzistica non è mai stato particolarmente forte, e così sono presto transitato verso forme più moderne e contemporanee. Questo perché mi sono rapidamente reso conto che quel che mi interessava nel jazz era soprattutto quello straordinario concetto che è l'improvvisazione. È questa la mia ricerca costante sia nell'ambito della performance, sia nella didattica, che porto avanti con dei laboratori che ho chiamato Forme Sonore e che tengo in modo sia stabile che itinerante. Nel primo caso i seminari hanno una forma permanente e prevedono un incontro al mese per sette mesi consecutivi, presso il Centro Stabile di Cultura di Schio (Vicenza), e a Sinnai, vicino a Cagliari. Nel secondo caso invece li realizzo quando si presenta l'occasione. Anche questi seminari fanno parte di un lungo percorso di ricerca, che si articola nello studio delle forme aperte, veicolate esclusivamente attraverso partiture grafiche e non attraverso il sistema di notazione tradizionale.
Quindi, senza dubbio l'improvvisazione è il primo grande insegnamento che mi ha dato il jazz, anche se poi il contatto con altri ambiti artistici mi ha particolarmente sensibilizzato verso l'importanza del concetto di forma, così che, pian piano, negli ultimi dieci anni mi sono sempre più avvicinato alle molteplici espressioni della musica e dell'arte contemporanea. Ciò che più mi attrae è quella sottile zona, assai complessa, che sta in equilibrio tra l'improvvisazione e la scrittura, due aspetti che, erroneamente, sono sempre stati pensati lontani tra loro, contrapposti, fin quando un'area sempre più vasta di musicisti non ha compreso quanto invece fossero vicini, se non complementari.
AAJ: Sì, c'è senz'altro questo contrasto, che rimanda anche a quello tra scrittura e musica non scritta; però tu - usando il termine "forma" - metti in risalto che la vera alternativa/differenza è quella tra l'improvvisazione e la realizzazione di qualcosa che abbia una forma, che sia leggibile, che - come diceva recentemente Massimo De Mattia - sembri scritto anche se non lo è. Deve cioé avere una forma come se fosse scritto, pur non essendolo?
R.D.: Certamente, improvvisare deve essere questo. Ma penso alla forma come a un qualcosa di più complesso del concetto di struttura, cioè di più astratto, immaginifico. Penso che nella mia testa il concetto di forma sia infatti molto più vicino a quello di architettura, un territorio dai confini imprecisabili e che favorisce una costante innovazione.
AAJ: Come riconosci l'esistenza di una forma anche in assenza di una struttura, o almeno in assenza di una struttura chiaramente riconoscibile?
R.D.: Non può esserci forma laddove non c'è struttura, cioè dove manchino i contenuti in una loro evoluzione spazio-temporale. È decisiva la presenza di una narrazione, che non debba necessariamente seguire dei canoni predefiniti e possa apparire anche sotto sembianze inattese, ma che sia intellegibile.
AAJ: Il concetto di narrazione rimanda non solo ad aspetti della tua biografia, ma anche all'ascolto del tuo lavoro alla batteria: diversamente da quanto accade in molti batteristi, infatti, nel tuo caso è sempre percepibile un elemento narrativo. Com'è che sei arrivato a concentrare la tua attenzione proprio su un elemento che non è tipico della batteria?
R.D.: L'ho sempre vissuto come un'esigenza ed è anche stato il metro con cui mi sono giudicato (e ho giudicato gli altri musicisti, almeno per quanto riguarda l'interesse che mi suscitava il loro modo di esprimersi) nel corso dei miei anni di attività.
AAJ: Hai detto che, accanto al solo, privilegi i piccoli gruppi. Ferme restando le ragioni generali per questa preferenza, puoi dire perché privilegi questo o quel musicista? Quale tipo di musica deve rendere accessibile?
R.D.: La scelta dei musicisti parte principalmente dall'idea di lavorare su composizioni originali. Poi, come dicevo, c'è l'esigenza di suonare con chi abbia un approccio simile al mio, ossia che privilegi un certo lavoro sul suono e che perciò, operi con particolare sensibilità. Di conseguenza la selezione è stata talvolta anche piuttosto drastica: non sono infatti poi così tanti i musicisti interessati a fare un lavoro di questo genere. Ma mi è anche capitato di lavorare con l'elettronica: per anni ho avuto il progetto RAM, in duo con Michele Tadini, che creava campionamenti in tempo reale dal mio set, rielaborandoli e modificandoli all'istante e perciò di fatto duettando come me in una maniera che ho trovato veramente eccezionale. In questo caso però l'elettronica entrava in relazione con l'acustico senza sovrastarlo, con grande rispetto e sensibilità. Quando l'elettronica non è invasiva può essere straordinaria, soprattutto per le sue enormi potenzialità: apre mondi sulla complessità, sulla molteplicità. Infatti non a caso sto per cominciare a lavorare su un nuovo progetto in duo con Alberto Fiori, che in questo caso è però basato su un lavoro di pre-campionamento, non in tempo reale, su miei suoni registrati, che lui farà interagire dal vivo grazie a una tastiera e a un computer.
AAJ: Vorrei tornare al tuo lavoro in solo, intrecciandolo con i seminari dei quali parlavi. Prima indicavi alcuni elementi cardine della tua ricerca, come il suono, gli spazi, la dinamica, le sfumature timbriche. L'improvvisazione che ruolo vi gioca e come la sviluppi?
R.D.: Ha un ruolo centrale, è il terreno su cui camminiamo. Qui è necessario fare una precisazione: io non lavoro esclusivamente con musicisti. Ovviamente, i musicisti sono le persone con cui mi relaziono più frequentemente, ma sono anche molto felice di collaborare con chi si esprime attraverso modalità diverse: fotografia, video, scultura, danza, pittura e tante altre cose. Questo perché l'essenziale è lavorare sui concetti. Per me non è così fondamentale che tutto quanto ruoti attorno al suono: quando abbiamo altre persone, che non suonano, la cosa si fa ancora più interessante, proprio perché la partecipazione alla medesima ricerca di persone che usano un linguaggio diverso dal nostro aiuta tutti a capire quanto il concetto di forma sia una necessità che accomuna tutti gli approcci. Dunque l'eterogeneità dei gruppi è molto importante ed è sempre stato un valore aggiunto dei miei seminari, un aspetto che continua a essere molto apprezzato visto che più passano gli anni, più vedo arrivare anche non musicisti. L'improvvisazione per noi è fondamentalmente un modo di lavorare sui concetti. Spesso in alcuni degli esercizi che facciamo, delle vere e proprie performances, i musicisti non sono necessariamente coinvolti suonando. Per fare un esempio: se dobbiamo lavorare su alcuni parametri per visualizzare un processo strutturale, spesso non operiamo sulla materia musicale ma usiamo il corpo. Questo permette di acquisire la consapevolezza diversificata dei dettagli della ricerca, dopo di che ciascuno ritorna al proprio strumento portando con sè gli insegnamenti di questa esperienza trasversale. Ed è allora che accadono cose incredibili, perché ci si ritrova in grado di eseguire sullo strumento prassi che erano state prima visualizzate in modo del tutto diverso. Questo è possibile perché lo studio della forma non è esclusivamente legato al nostro strumento: possiamo condurlo su quel piano, ma possiamo anche scegliere di usarne un altro, come il nostro corpo, l'ambiente in cui ci troviamo, la parola (improvvisando un discorso), tutto insomma.
AAJ: Tornando al discorso iniziale, immagino che questo genere di scelte artistiche fatichi a pagare dal punto di vista della risposta del pubblico e del "mercato". Ciò da un lato si capisce, ma dall'altro sorprende, visto che chi ha il piacere e la fortuna di ascoltarti non può negare che la tua musica non sia poi cosí astrusa, ma anzi dia anche molta soddisfazione immediata all'ascolto. Tu che spiegazioni hai?
R.D.: Personalmente tutti gli spettacoli a cui ho preso parte, non solo musicali tradizionali (penso anche al progetto Stàgon con l'artista Gianandrea Gazzola, che ha costruito uno strumento/installazione basato sulla caduta di gocce d'acqua che abbiamo presentato in diversi paesi europei), hanno ricevuto una grande attenzione. Anzi, direi che c'è sempre stata una reazione straordinaria da parte del pubblico, anche quando questo non era composto di adepti o specialisti. La difficoltà è casomai quella di riconoscere proprio il crescente interesse da parte del pubblico verso questo genere di proposte. Su questo punto il problema è da un lato legato alla comunicazione mediatica, che tende ad appiattirsi su proposte ripetitive, e dall'altro di comprensione da parte di un maggior numero di persone, specie quelle che si occupano di selezionare e organizzare, che sembrano quasi temere il cambiamento - cioè proprio ciò di cui il pubblico ha bisogno. Ma - aggiungerei, tornando a un tema che avevamo toccato in precedenza - uno dei problemi che concorrono a creare questa situazione di stallo è anche quello degli spazi: il luogo ha un'importanza assolutamente strategica. Il lavoro che svolgo è indissociabile dal luogo in cui lo svolgo. Quindi, di nuovo, la scelta del luogo è fondamentale e in questo io ravviso molti grandi errori: vedo troppo spesso programmare eventi in luoghi che sono totalmente inappropriati, o che forse lo erano un tempo e oggi non lo sono più.
AAJ: Quando parli di luoghi inadeguati ti riferisci alla prassi di svolgere attività concertistiche all'interno del tradizionale club, o in teatro, piuttosto che andare volutamente a cercare spazi diversi e meno consolidati?
R. D.: Esatto, in particolare vedo una grande inadeguatezza riguardo alla prassi di suonare all'aperto, cosa che trovo molto difficile e penalizzante soprattutto quando si lavora con strumenti acustici, perché vanno perse una quantità di specificità sonore, penalizzate da acustiche insufficienti e sovrastate da rumori di ogni tipo. Sicuramente si parte dalla diade aperto/chiuso, per arrivare poi a riflettere su quale ambiente chiuso sia adeguato, su come prepararlo a questa specifica performance, e via dicendo. Nella mia esperienza i concerti che hanno avuto migliori esiti sono sempre stati quelli proposti in luoghi diversi e lontani dal teatro tradizionale. Ora, da questo punto di vista non si può negare che si sia fatto molto per uscire dalla "riserva" del tradizionale luogo di spettacolo; tuttavia questo lavoro, che pur è stato fatto, non ci ha dato un lascito, non ha realmente né scardinato il concetto del teatro come luogo d'eccellenza, né creato una rosa di alternative praticabili, e neppure fatto passare un concetto fondamentale: che il teatro, comunque, è e resta un luogo sempre di nuovo da reinventare.
AAJ: Con ciò tocchi un'altra questione, quella più generale del dove mettere in scena le rappresentazioni artistiche non solo musicali. Il teatro, in particolare, è una realtà con cui collabori spesso. Tu, da musicista di ricerca, come cooperi con il teatro?
R.D.: Anche l'interazione con il teatro è stata per me una cosa molto, molto naturale, proprio per quella necessità di differenziazione espressiva di cui parlavamo prima. In questo momento, per ragioni solo contingenti, è un esperienza in stand by, ma in passato ho fatto cose anche molto diverse tra loro e sempre molto interessanti e formative: hanno avuto tutte un'influenza fortissima su ciò che ho poi fatto anche fuori dall'ambito strettamente teatrale. In particolare hanno rafforzato la mia consapevolezza dell'importanza del corpo, dello spazio e soprattutto della drammaturgia. Ecco, questo mi sembra un termine importante, drammaturgia: prima parlavo dell'importanza della narrazione, ma adesso preciserei che ancora prima è necessaria una drammaturgia, una visione d'insieme. Questa è una cosa che ho maturato grazie alla compartecipazione alle attività teatrali, che spesso aveva la forma di una mia presenza defilata nel buio della scena, inginocchiato su un set strumentale mobile con il quale cambiavo posizione, ma che in altre occasioni prevedeva anche la direzione di un ensemble di batterie e una relazione più stretta tra testo e musica. Da tutte queste diverse esperienze, comunque, ho sempre tratto una maggior consapevolezza di spazio e drammaturgia, che poi ho riportato nelle mie performances più strettamente sonore. È stato soprattutto a partire da queste esperienze che ho iniziato a lavorare sullo strumento in modo più profondo. La mia «tecnica» strumentale ha a che fare con la mia concezione della batteria, in particolare della «batteria preparata», che per me significa essenzialmente un utilizzo dei tamburi come superficie di lavoro e - soprattutto - di risonanza per metalli (piatti, ecc.) e corde. Infatti, il cuore del mio strumento è un sistema di corde (tre sul rullante e una sul timpano) che entrano in contatto con la pelle attraverso ponticelli mobili e che poi vengono suonate con archetti. In questo contesto, i tamburi diventano grandi casse armoniche. Inoltre le corde del rullante sono intonabili in tempo reale grazie a una speciale pedaliera. Sono arrivato a questa soluzione per ovvie ragioni compositive: avevo bisogno di lavorare su durate estremamente lunghe, o addirittura infinite, senza ricorrere all'ausilio di elettronica.
AAJ: Domanda conclusiva di prammatica: progetti inediti o in corso?
R.D.: A parte il ben noto trio con Stefano Battaglia (agli inizi del 2013 è prevista l'uscita del nuovo CD per l'ECM) e i già citati duo con Alberto Fiori e progetto Stagòn con l'artista Gianandrea Gazzola, ci tengo a citare quello in trio con Roberto Bonati al contrabbasso e Alberto Tacchini al pianoforte. Lo abbiamo messo in scena al Teatro Regio di Parma lo scorso anno e presto ne uscirà un CD. Anche qui l'approccio alle composizioni, di Bonati, ha un taglio cameristico e si spinge su un territorio al tempo stesso lirico e di libertà di ricerca. Un progetto che, come quello con Battaglia, ha un proprio suono, dove ci si spinge anche volutamente in campi aperti e sperimentali. La stessa modalità di lavoro che pratico nella mia ricerca personale e che amo ampliare con musicisti che sento affini, come in questo caso, con libertà e rigore.
Foto di Claudio Casanova, tranne l'ultima di Gabriele Grotto.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.