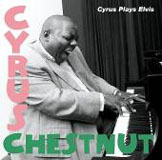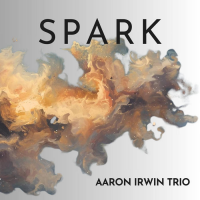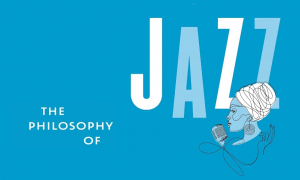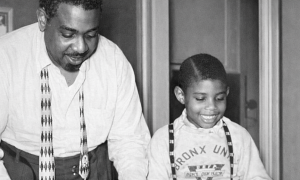Home » Articoli » Book Review » Jazz Music
Jazz Music
di Flavio Caprera
Pagine 381
Mondadori, Milano, 2006
Euro 12
Evidentemente gli esperti di marketing e i responsabili dell'editoria divulgativa delle grosse case editrici italiane ritengono che oggi sul mercato ci sia una forte richiesta di guide di carattere enciclopedico sul jazz, classicamente impostate con le singole voci in ordine alfabetico. Alla Einaudi, che nel 2005 aveva licenziato Jazz! Come comporre una discoteca di base di Carlo Boccadoro, la Mondadori ha risposto a ruota nel 2006 con questo Jazz Music di Flavio Caprera, incluso nella collana Piccola Biblioteca Oscar.
Ignoro quale sia il reale interesse per questo genere di opere da parte del pubblico specializzato (perché di tale si tratta in gran parte). È vero comunque che i tempi cambiano: nel panorama internazionale si sono imposti nuovi protagonisti e le vecchie enciclopedie, oltre che non aggiornate, non sono più reperibili. Quindi i giovani neofiti, e non solo, possono essere i potenziali destinatari delle nuove opere di questo genere.
L'enciclopedia (et similia) d'altra parte, per sua natura, è uno strano prodotto editoriale, un po' amorfo, né carne né pesce, né soggettivo né oggettivo. È un libro di consultazione e come tale in teoria dovrebbe essere il più possibile completo, estremamente oggettivo, frutto di una ricerca rigorosa, calibratissima, veritiera, essenziale... ma, lo sappiamo, l'oggettività è un concetto astratto. In realtà l'impostazione e l'elaborazione dipende dagli autori, che non possono fare a meno di avere un approccio soggettivo, anzi sarebbe sacrosanto e auspicabile che l'avessero; solo che spesso nelle enciclopedie recenti questa soggettività, che comporta un'interpretazione anche arbitraria e discutibile dei fatti, viene occultata, anzi viene fatta passare, con un'azione mistificatoria, per una presunta, incontestabile ufficialità.
Caprera sembra intuire tutto questo, ma non affronta l'argomento fino in fondo, con chiarezza. Nella sintesi aproblematica e un po' sbrigativa dell'introduzione afferma che "la scelta dei nomi è soggettiva, ma risponde a una sua intima coerenza", e poco dopo precisa: "...i limiti di spazio e l'imperativo della maneggevolezza non ci hanno consentito una più ampia selezione".
A questo punto possiamo entrare nel merito di Jazz Music. Innanzi tutto potremmo divertirci a valutare quali jazzmen, a parità di spazio, avremmo incluso o escluso nella trattazione. Sotto la lettera B, per esempio, io non esiterei a togliere Terence Blanchard o Tina Brooks per includere Tim Berne. Alla lettera S trovo subito Arturo Sandoval, ma scopro con stupore che non vengono presi in considerazione jazzisti del calibro di Charlie Shavers, Zoot Sims, Leo Smith, Louis Sclavis... Alla T invece baratterei volentieri l'inserito John Taylor col trascurato Henry Threadgill.
Nei confronti degli olandesi sembra esserci un vero e proprio ostracismo. Infatti in "Altri protagonisti del panorama jazz", elenco posto in appendice alle biografie, vengono dimenticati Mengelberg, Bennink e Breuker. D'altra parte in questa appendice vengono trascurati anche il già citato Sclavis e von Schlippenbach, Evan Parker e tanti altri esponenti europei. La stessa considerazione vale per i batteristi americani: nel suddetto elenco sintetico non rientrano Barry Altschul, Eddie Blackwell, Andrew Cyrille, Milford Graves, Sunny Murray, Joey Baron, Gerry Hemingway... Come se negli ultimi quarant'anni, dopo le innovazioni di Elvin Jones, DeJohnette e Tony Williams non fosse successo nulla degno di nota. E così via: questa verifica delle presenze-assenze potrebbe diventare un gustoso gioco di società per un'accolita di jazzfans.
Esclusi pochi grandissimi nomi, ai quali viene riservato uno spazio relativamente più ampio, per scelta editoriale la dimensione dedicata ad ogni jazzista preso in considerazione nelle biografie è più o meno standard. Per questo Eric Dolphy, George Russell, Max Roach e perfino Ornette subiscono lo stesso trattamento, riga più riga meno, di colleghi ben meno importanti, come Gonzalo Rubalcaba, Lou Donaldson o Marcus Roberts.
Le biografie sono tracciate in modo snello, senza pedanteria, ricordando i fatti salienti della carriera dei singoli personaggi. È un po' generica invece la trattazione dei profili artistici, delle caratteristiche stilistiche di ognuno. Risulta cioè carente una valutazione estetica che faccia comprendere l'importanza, il ruolo che ogni maestro ha ricoperto nel contesto che lo ha visto operare e quindi nella storia del jazz.
A tale proposito anzi alcune valutazioni non sono condivisibili. Riguardo allo stile di Ayler, per esempio, si legge: "Il suono di Ayler è insopportabile, rabbioso, mette contro il nuovo e l'antico... Una morte misteriosa come la sua musica". Sulla più recente produzione di Carla Bley si dice: "...conferma le sue doti di grande compositrice e improvvisatrice...". È riconosciuto il rilievo della Bley come compositrice, arrangiatrice e band leader, ma lei per prima ammette di essere una pianista ed improvvisatrice molto modesta.
Da tutte le precedenti constatazioni si desume facilmente che l'autore non ha alcuna predilezione per il free e per le più recenti espressioni di ricerca, americane o europee. E questo fa parte delle legittime scelte soggettive a scapito dell'equilibrio e dell'oggettività. Proprio per questo io continuo a preferire il Dizionario Jazz a cura di Philippe Carles, André Clergeat e Jean-Louis Comolli, edito a Parigi nel 1988 e prontamente pubblicato in Italia nel 1989 da Armando Curcio. Questo lavoro d'altra parte (come ogni enciclopedia che si rispetti e a differenza delle recenti opere italiane di Boccadoro e Caprera) è tipicamente collettivo, frutto del contributo di numerosi collaboratori, esperti nei diversi periodi del jazz. In questo caso quindi l'equilibrio, se non l'oggettività, è stato perseguito con i dovuti mezzi.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.