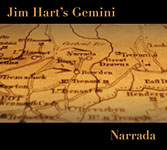Home » Articoli » Lyrics » Jazz e narrativa 2: Guignol's Band di Louis Ferdinand Céline
Jazz e narrativa 2: Guignol's Band di Louis Ferdinand Céline
L'obiettivo di "Déjà lu," la nuova rubrica di All About Jazz Italia, è appunto quello di recuperare dall'oblio testi già pubblicati in passato per riproporli ai jazzofili di oggi che leggono AAJ. Per il reperimento del materiale, oltre agli abituali collaboratori di AAJ, ci siamo rivolti a note firme nazionali e internazionali, ottenendo la loro convinta adesione. I testi a volte vengono ampliati e riveduti col senno di poi, oppure, se funzionano, lasciati nella versione integrale; in una nota viene comunque citata la fonte originaria.
Nelle opere di alcuni scrittori americani del secolo passato il jazz gode di una posizione non casuale; anzi, oltre ad essere un elemento di sfondo costante e connesso all'ambiente narrato, fa parte del background culturale degli autori, influenzandone l'atteggiamento mentale e il metodo compositivo. Nella letteratura europea, al contrario, il jazz rappresenta di solito una presenza occasionale ed eccentrica, un riferimento, spesso superficiale, ad una moda importata dalla mitica America, che non comporta un'adesione convinta da parte del narratore.
Riguardo proprio al rapporto fra musica afroamericana e letteratura europea, un caso che vale la pena di prendere in esame è Guignol's Band di Louis Ferdinand Céline, scrittore particolare e controverso, venerato da alcuni e rifiutato da altri, forse più per l'atteggiamento politico di destra ed antisemita, assunto nel periodo bellico, che per il reale valore della sua opera. E' indubbio comunque che nelle sue pagine tormentate e coinvolgenti, dalle quali sarà opportuno stralciare qualche passaggio particolarmente significativo, è frequente e si sviluppa su diversi piani il riferimento al jazz, o meglio ad una "musichetta improvvisata" in qualche modo assimilabile al jazz.
Già nell'enigmatico prologo dell'impegnativo romanzo l'autore immagina che il nonno, letterato dallo stile aulico e dalla fine retorica, dall'al di là lo approvi e lo incoraggi ad intraprendere un suo stile vivo e caotico: «Il jazz ha sbaraccato il valzer, l'Impressionismo ha sbattuto via la luce da studio, scrivete "telegrafico" o non scrivete più niente!... Tocca a voi capire! Emozionatevi! "Non ci sono che baraonde nei suoi capitoli"! Che razza d'obiezione! Che vaccata solenne! Ohé! attenzione! Imbranati! In sella! Via sull'onda! Emozionatevi dio cristo! Ratatatan! Saltate! Vibrate! Fate scoppiare il guscio! Venite fuori, granchi! Schiudetevi!». Questo tono da avanguardia futurista, di aggressiva e visionaria esaltazione, pervade tutto il libro, che, pubblicato nel 1944, presenta radicali differenze di contenuto e di stile rispetto ai precedenti Viaggio al termine della notte e Morte a credito, concepiti nella prima metà degli anni Trenta.
La dimensione musicale è incarnata in particolare da uno dei protagonisti della vicenda, l'anarchico Boro «che portava di solito una bombetta prugna, mai nient'altro sul crapone, sempre tappato col suo verde prugna, la sua uniforme. Suonava il piano a 'sto modo per guadagnarsi da vivere, tra l'Elephant e Castle, le due estremità del Mile End».
Per lui ogni occasione è buona per fare musica, ogni luogo è adatto per profondere il suo artificio magico, «...per portare dovunque l'incanto, sito togo, situazione smorta, locale ganzo, festa di cornuti, soffitte tetre, incroci sinistri, strade senza speranza, comunioni, balere di periferia, giorno dei Morti, bettole equivoche, 14 luglio!...e dzim! bam! dim! e ci si lancia... via senza ostacoli!...».
Per quanto riguarda l'esuberante stile pianistico di Boro, Céline si cala a più riprese nella sua descrizione, come colto da un vortice di partecipazione entusiastica, da una piena condivisione del mondo estetico della sua stessa creatura. «Bisognava vederlo all'opera il Boro! che brio d'artista! sulla questione musichette... scintillanti... ma cadenzate tipo volo!... e il repertorio!... che memoria!... variazioni all'infinito!... Lui piuttosto bestia di suo e francamente brutale e impossibile con la mania degli esplosivi, là diventava tutto arioso, tutto salterino, tutto folletto!... Ci aveva l'anima nelle dita... delle mani di fata!... delle farfalle sui tasti... Volteggiava tra le armonie!... ne beccava una e un'altra... un diesis!... fantasie e ghiribizzi!... ghirlande... digressioni... scherzi veloci... Posseduto... è la parola!... da venti diavoletti nelle dita!... Mai malumore o stanco! Ore e ore l'ho visto in 'sto modo far capriole di terze in quarte e puntare le brevi... in sussulto... tipo pianola... mai distratto né un sospiro... mai una parola... "Basta così!"... sempre brioso... gaio ipnotico, ondeggiante col suo testone, cinque, tre dita, a bomba!... ritorno alla tonica!... battuta d'accordo! diesis! E' fatta!...». E così via; per intere pagine, con vivace frammentazione e slancio poetico, procede la ridondante restituzione letteraria delle improvvisazioni pianistiche di Boro.
Ma a ben vedere, come può essere classificata la musica dello stravagante anarchico? In che misura essa può essere considerata jazz? Una parziale risposta ci viene data da alcune illuminanti righe dello stesso Céline: «Questa roba ha fatto furore in seguito, mille volte ripresa, rimasticata, rivomitata da tutte le macchinette del mondo, da tutti i jazz dei continenti!... dai negri di un po' dappertutto!... farfugliata a manovella... Ma all'epoca di cui vi parlo era ancora una primizia... la solfa mai sentita... il genere sentimentale a freddo, il saltellato scherzoso messaggio dei tempi così carogna a venire!...».
In queste frasi stringate c'è un concentrato di distaccata consapevolezza e di verità incontestabili: il jazz come espressione di una cultura diversa e lontana, quella americana; il suo trasformarsi in un linguaggio internazionale, ma a beneficio di minoranze segregate e tradotto in dialetti locali; la sua diffusione e relativa fortuna di pubblico, anche grazie alla riproduzione discografica; la sua forza profetica ed anticipatrice, come in altre espressioni artistiche, nei confronti degli eventi sociali; infine il rischio della formula rituale, il limite di cadere in una convenzionale ed autoreferenziale ripetizione di se stesso a beneficio di uno statico pubblico di adepti (come, più o meno negli stessi anni, ha forse troppo categoricamente messo in evidenza l'analisi di Adorno).
Inoltre, come ci ricorda Gianni Celati nella prefazione alla riedizione, avvenuta nella primavera 1996, da parte di Einaudi-Gallimard nell'elegante collana della Pléiade, è importante tenere presente la dimensione autobiografica del romanzo, in quanto l'autore si riferisce alla sua esperienza giovanile di suonatore ambulante a Londra. Afferma Celati: «... è chiaro che gli accenni in Guignol's Band servivano per parlare dell'avvento di una nuova musica che si è diffusa in Inghilterra precisamente negli anni del soggiorno di Céline, 1915-16: il jazz, lo swing, il ragtime, forme sincopate a quattro tempi, con improvvisazione delle variazioni in base a scale fisse».
Mi sembra importante sottolineare, a tale proposito, come non si possa parlare di una vera e propria diffusione discografica del jazz americano al tempo della prima guerra mondiale: pur tuttavia in Europa si verificarono sporadici contatti con il nuovo verbo musicale e si svilupparono forme molto rudimentali e addomesticate di jazz.
In particolare il termine 'swing,' usato da Celati in questo contesto, è da intendersi esclusivamente nel senso tecnico di oscillazione ritmica, certo non di corrente stilistica (lo Swing delle big band, diffusosi in tutto il mondo negli anni '30, in concomitanza della ripresa economica degli Stati Uniti). Al contrario, ben diversa doveva essere la concezione sul jazz da parte dello stesso Céline quando scrisse Guignol's Band a cavallo fra gli anni '30 e '40, in questo caso includendo anche la cognizione dello Swing, allora moda imperante.
Pertanto, per tentare una conclusione in merito alla musica di Boro, o se si vuole a quella del giovane Céline, si potrebbero riconoscere in essa molti caratteri del jazz delle origini: si tratta di una musica spontanea, improvvisata, esuberantemente comunicativa, allusiva ed immaginifica, carica di swing ed anche di un estroso virtuosismo probabilmente appreso da autodidatta... Nel caso specifico sembra più opportuno parlare però di una musica improvvisata europea, pur influenzata da quel poco che si poteva captare o immaginare del coevo jazz americano. Una musica, in sostanza, che da un lato fa trapelare qualche debole relazione con alcune espressioni della musica colta, ad esempio la "musica d'uso" di Hindemith, la "musique de tapisserie" di Satie, gli intenti popolareschi e politicamente impegnati di Kurt Weill, dall'altro dichiara il suo saldo legame con la tradizione popolare delle feste di paese, degli organi meccanici da giostra, delle occasioni rituali sacre e soprattutto profane.
Il romanzo si sviluppa come un'interminabile ed inconclusa improvvisazione, senza possedere una parabola narrativa di stringente rigore strutturale, come invece capita quasi sempre nei brani del miglior jazz. In tale senso l'opera dello scrittore francese, caratterizzata da un'abnorme ed incontrollata proliferazione su se stessa, sembra anticipare di almeno un decennio l'estetica dell'Informale, della Beat Generation, dell'Happening.
Come sottolinea Celati, «il libro va avanti per seicento e più pagine con questi burattini senza bussola che sono trascinati in un balletto vertiginoso, succubi d'un incanto da cui non possono uscire. Ma la prosa opera sul lettore lo stesso incanto, con l'ambivalenza delle esagerazioni iperboliche, con le forti scansioni ritmiche, l'adagio delle divagazioni liriche, l'andante delle fantasticazioni, il presto e prestissimo delle baraonde».
Insistendo sulla dimensione musicale della prosa di Céline, sulla ubriacante trasposizione di cadenze che trascendono il mero significato verbale, scrive ancora Celati: «In particolare ci sono alcune pagine, quando Boro suona il piano a casa di Van Claben, che suonano come una dichiarazione appassionata e tecnica, da gran conoscitore di tutti i trucchi nelle improvvisazioni sincopate su scale fisse. E sono pagine meravigliose, pura musica di parole, che a me sembrano il più audace tentativo mai fatto per narrare uno stile musicale: per suggerire quel genere di divagazione sospesa e senza oggetto che solo la musica può compiere». Risulta a questo punto evidente come in Guignol's Band la presentazione di un personaggio come Boro e la descrizione del suo modo di suonare costituiscano solo un primo, strumentale livello di riferimento al jazz. Un più consistente piano di raccordo è rappresentato dal parallelismo estetico fra il furioso stile letterario di Céline e l'esasperata pronuncia dell'improvvisazione jazzistica.
A tale proposito assume un peso non secondario l'impiego sistematico di un personale sistema d'interpunzione: il reiterato uso dei tre puntini di sospensione, utilizzati per la prima volta nel pamphlet antisemita Bagatelle per un massacro, di poco precedente. Si tratta di una frammentazione, che dà ritmo e cadenza al periodare, paragonabile alle pause per la respirazione, anche brevissime, ma indispensabili e piene di senso narrativo, nella tecnica degli strumenti a fiato.
In alcune pagine invece, nonostante il ricorso a frasi brevi, la ripetizione paranoica dei concetti, la loro variazione e ripresa, dà un senso di parossistica e dilatata reiterazione, facendo pensare all'assolo di un sassofonista che utilizzi la respirazione circolare.
Guignol's Band non è che il punto di partenza; in tutti i successivi romanzi di Céline l'insistenza ripetitiva dei temi e l'andamento ritmico prevalentemente frenetico, l'uso dei tre puntini di sospensione, dei punti esclamativi e di un vocabolario anticonvenzionale, la propensione per un tono allucinato e surreale, il rifiuto di una linearità espositiva tradizionale, vengono ribaditi e divengono cifra stilistica inconfondibile dell'autore. Per il persistere di questi connotati quindi, tutta la sua produzione matura può essere letta come un'estesa improvvisazione jazzistica.
[Nota dell'autore: Déjà lu? Probabilmente sì, ma forse no. Sono (quasi) sicuro che l'articolo su Guignol's Band sia stato a suo tempo pubblicato, ma dopo interminabili e logoranti ricerche non ho rintracciato il periodico su cui uscì. Scrissi il saggio nella primavera 1996, a seguito della riedizione del libro per i tipi della Einaudi- Gallimard; all'epoca collaboravo con Musica Jazz e saltuariamente con Ritmo, Linea d'ombra, Jazz&Blues... Ho setacciato intere annate delle riviste: nulla, l'articolo non è saltato fuori. Un piccolo mistero. La versione sopra riportata è comunque ampiamente riveduta e corretta rispetto alla mia stesura originale.] - L'articolo viene riproposto per gentile concessione dell'autore.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.