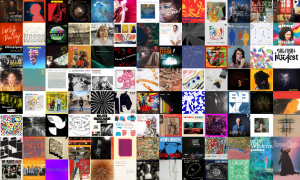Home » Articoli » Interview » Intervista ad Arve Henriksen
Intervista ad Arve Henriksen
Arve Henriksen: Oh, è una storia lunga... tutto è cominciato quando studiavo al conservatorio di Trondheim, in Norvegia, dove ho conosciuto Niels Petter Molvær, il mio idolo di allora. Lui mi ha fatto conoscere un sacco di musica diversa, ricordo che veniva e mi portava cassette su cassette... e in una c'era appunto questo flauto giapponese di cui mi sono innamorato all'istante... Da allora ho ascoltato molti musicisti di shakuhachi, anche se non l'ho mai studiato o suonato... Ero alla ricerca di una mia voce personale, del mio sound, e lo shakuhachi, con il suo timbro e il suo spettro sonoro, mi sembrava potesse essere trasformato e adattato alla tromba, perché era un modo completamente diverso di pensare allo strumento. Quello che mi attira della musica giapponese ��" ricordo che la prima volta che sono stato in Giappone, credo nel ‘96 o nel ‘97, me ne andavo a passeggiare per i templi ��" è il silenzio, la calma, il senso di tranquillità in cui ti ritrovi immerso... è una musica in un certo senso ‘ritirata', è energia trattenuta, ma che racchiude molta tensione in sé, e questo mi piace, in fondo è un po' quello che cerco di fare anch'io, è molto diverso ad esempio dal free jazz dove puoi avere tutta questa esplosione di suono. Comunque ai tempi del conservatorio non c'era solo lo shakuhachi, mi ispiravo anche ad altri strumenti come il flauto armeno duduk, e i flauti indiani di bambù, e ascoltavo musica etnica da tutto il mondo. Queste influenze le senti nei miei concerti, ma faccio riferimento anche alla musica classica... basta sentire il tipo di paesaggio musicale che cerchiamo di creare con Jan Bang, per esempio, con cui ho suonato anche in Italia la scorsa estate, a Berchidda... la musica che facciamo assieme in effetti non è jazz, e nemmeno qualcos'altro, noi la intendiamo come musica in qualche modo universale, dove prendiamo quello che ci piace da diverse tradizioni, e le cose che ci piacciono sono davvero molte!
AAJ: Il primo disco a tuo nome, Sakuteiki (2001) l'hai inciso in una chiesa, e il secondo, Chiaroscuro (2004) è una registrazione dal vivo rielaborata poi in studio. In che modo i luoghi influenzano non solo i musicisti ma anche la risposta del pubblico?
A.H.: Sakuteiki, per essere precisi, l'ho inciso in diverse chiese ed in un mausoleo ad Oslo, dove ho fatto anche altri concerti. E' un luogo con un'atmosfera particolare che dà ai musicisti, e spero anche al pubblico, una tensione speciale verso la musica, uno specifico senso di ciò in cui siamo immersi. Certamente l'ambiente crea diverse possibilità per i musicisti ed il pubblico; in una chiesa, se vuoi, si crea un senso di... [ridendo] serietà, di rispetto, mentre in un club sei più rilassato, e questo è molto importante per i vari tipi di musica che cerco di creare con musicisti diversi. Poi se cominciamo ad avere problemi di suono, come può capitare a volte ad un festival dove sei all'aperto - magari al freddo! - o sotto una tendone, beh, i musicisti in qualche modo si adattano all'ambiente, ma per il pubblico può essere ancora più problematico...
AAJ: A proposito di pubblico, come ti rapporti ai tipi di audience che puoi incontrare in vari paesi? Ci sono differenze? Ti influenzano?
A.H.: Beh, è comunque un rapporto dove si dà e si riceve, e a volte il pubblico può starsene in silenzio e, come dire, non darti molto, ma non è solo quello. Faccio molti concerti in solo, ed è una situazione per certi versi solitaria, senti tutta l'aspettativa del pubblico a ricevere qualcosa, e a volte può capitare che tu in quel momento abbia voglia di startene per conto tuo, e io comunque non sono affatto un animale da palcoscenico... Piuttosto cerco di interagire, e a volte invece che usare l'elettronica coinvolgo il pubblico a fare il loop, o magari, come mi è capitato ad un concerto in una chiesa di Dublino, scendo tra il pubblico chiedendo di creare certi suoni, o di cantare al microfono con il riverbero. Quindi ci possono essere momenti di forte partecipazione del pubblico che ti aiutano come musicista, ma dipende anche da te, da come riesci a trasmettere l'energia, e far entrare chi ascolta in quello che fai. In questo senso puó essere importante anche qualcosa che dici, raccontando di te, o il modo in cui guardi la platea... per eliminare quella specie di filtro che talvolta senti attorno a te. Beh, forse un po' di presenza scenica non guasterebbe! [ride]
AAJ: Prima parlavi delle tradizioni musicali a cui ti sei ispirato... in che tipo di ambiente musicale sei cresciuto?
A.H.: Ah, sono successe un sacco di cose strane nella mia formazione musicale! Iniziai a suonare la tromba quando avevo 7, 8 anni, e poi cominciai a suonare nelle bande di paese, un po' come quelle che avete in Italia. Dopo ho cominciato a frequentare dei “campi estivi” di musica, ci andavo ogni estate, e una volta incontrai un gruppo norvegese, i “Brass Brothers”, dai quali ho imparato a suonare senza partitura e a improvvisare, si suonava Dixieland, canzoni tradizionali africane, un po' di tutto... Beh, la prima volta che sono andato ad uno di questi campi estivi avevo 11 o 12 anni e, sinceramente, a quel tempo avrei preferito giocare a calcio! Voglio dire che la musica è arrivata gradualmente, anche se ho imparato abbastanza presto a improvvisare e a suonare ad orecchio. Per un po' di tempo ho suonato jazz di New Orleans, poi ho studiato altrove e ho cominciato a suonare in una big band, e nel frattempo ascoltavo sempre più gli standard... praticamente mi sono trovato a seguire tutta la storia del jazz in pochissimo tempo... cos�-, ta-ta-ta-ta!
E a un certo punto scopro questa band norvegese che si chiamava Masqualero, c'erano Jon Balke, Jon Christensen, Nils Petter Molvær, capisci, tutti quelli che stavano creando cose nuove, li sento e mi dico: “wow, strana questa musica, è qualcosa di più del jazz!”. Poi viene Miles Davis, Kind of Blue, il Miles degli anni '70, i Whether Report, vado a studiare al conservatorio di Trondheim e lì incontro dei musicisti con cui inizio a collaborare, in un trio che inizialmente si chiamava “Veslefrekk” e che poi è diventato Supersilent, e con loro abbiamo cominciato a comporre e ad impostare delle idee per fare improvvisazione. In effetti Supersilent è la mia formazione preferita, abbiamo inciso sette dischi finora, e i prossimi due dovrebbero uscire tra poco.
Insomma, il mio percorso musicale mi ha portato, come ti dicevo, a ripercorrere un po' la storia del jazz; ora quello che mi interessa è la musica in quanto tale, e sono più curioso verso la scena contemporanea, Ligeti, Kurtág, Olivier Messiaen, tutte queste diverse sonorità che mi possono porre in nuovi contesti.
Non sto dicendo che la mia musica sia assolutamente nuova, chiaramente ci puoi sentire echi conosciuti, ad esempio ci sono collegamenti con Jon Hassell, che è stato molto importante per me, in un certo senso anche con Miles Davis, sicuramente con Nils Petter Molvaer, con certa musica contemporanea, con la musica etnica. Quindi non è musica “nuova”, ma quello che mi interessa è trovare delle situazioni che creino dei contesti musicali, dei paesaggi sonori in cui non mi sono mai trovato prima. E se riesco ad avere la sensazione di aver creato un momento, quel momento, quell'evento particolare, mio ��" ed ogni tanto succede ��" beh, mi posso dire soddisfatto. Perché poi non è cos�- facile creare qualcosa di assolutamente nuovo, non so nemmeno se sia possibile! Da una parte perciò ho degli obiettivi, anche ambiziosi, dall'altra però cerco di essere realista e riconoscere influenze e rimandi nella mia musica.
E comunque le collaborazioni con altri musicisti non vanno viste solo in termini di influenze, ti aprono anche delle possibilità nuove. Sto pensando ad esempio a David Sylvian per il quale ho suonato in “Nine Horses”, ed ai musicisti giapponesi che ho incontrato, Ryuichi Sakamoto, è stato incredibile lavorare con loro! Devo anche dire che essere un musicista norvegese oggi è una situazione in fondo privilegiata, nel senso che c'é molto sostegno a livello istituzionale, e questo, perchè negarlo?, rende la tua vita più stabile, permettendoti di portare avanti il tuo discorso, di lavorare a progetti, girare, farti conoscere al di fuori del tuo paese.
AAJ: Senti, hai mai pensato di suonare un altro strumento? In altre parole, perché proprio la tromba?
A.H.: Ah! Beh la tromba c'é sempre stata in effetti, ma mi ha sempre affascinato anche la batteria, adoro Audun Kleive, Jon Christensen e tutti i batteristi norvegesi che conosco, Paolo Vinaccia, con cui ho suonato, il batterista dei Supersilent, Jarle Vespestad... In un certo senso la batteria e le percussioni sono sempre state presenti, e quando improvviso gli aspetti ritmici della musica sono molto, molto importanti. Se parliamo di sound, certo il suond a cui penso è quello della tromba, metti di un Chet Baker, un bel suono morbido eccetera, ma il livello ritmico, come ti dicevo, non è mai passato in secondo piano. Anzi, a dire il vero l'anno scorso mi sono comprato una batteria e ho cominciato a suonarla, ora quasi ad ogni concerto con i Supersilent la suono un po', ma la cosa buffa è che di fatto non sono un batterista, e quindi uso questo strumento come un sampler. Poi c'é l'elettronica e la voce...
AAJ: Come è arrivata la voce?
A.H.: E' come se mi avesse seguito da sempre, anche se solo negli ultimi 3, 4 anni mi sono permesso di usarla nei dischi, ad esempio in Chiaroscuro ci sono tre pezzi dove la voce è molto presente. Ora ricordo: è successo a Trondheim quando studiavo, stavamo suonando e ad un certo punto ho iniziato a cantare perchè con la tromba non andavo oltre, TSCH-TSCH-TSCH-TSCH-WAA, sentivo di dover gridare o cantare qualcosa! E più tardi ho cominciato ad usare il falsetto, perché mi sono reso conto che era qualcosa che avevo e che avrei potuto impiegare - mi venivano in mente [ride] i ragazzini dei cori, e la musica barocca o medievale dove hai queste voci maschili molto alte, che adoro. Poi ci sono i toni bassi che pure uso, e qui il riferimento potrebbe essere la tradizione tibetana... in realtà non ho mai studiato canto, ho ascoltato però molta, molta musica. Quindi sono un autodidatta che ha cercato di riprodurre certi suoni, e questo in fondo vale anche per la tromba.
AAJ: In che senso?
A.H.: Beh, voglio dire che anche con la tromba in sostanza quello che ho fatto era cercare di riprodurre, copiare se vuoi, dei suoni di altri. Ma questo è un discorso più ampio: troppo spesso si dimenticano le influenze, l'aiuto e l'ispirazione che ti danno i musicisti che hai conosciuto e che ti hanno indirizzato verso un tuo percorso... penso ad esempio a Jon Balke e alla sua Magnetic North Orchestra, dove ho suonato per 11 anni, o a Jan Bang in Chiaroscuro, a Audun Kleive e agli altri musicisti di Supersilent, o ancora a Christian Wallumrød, che come pianista è stato molto importante per il tipo di musica che faccio ora. Per quanto incredibile tu possa essere come musicista, non puoi dimenticare che tu stesso sei stato creato da molte altre persone, che ti hanno fatto loro! E per questo provo molta riconoscenza.
AAJ: Parlando di interazione tra musicisti, che ruolo svolge il linguaggio verbale nel fare musica?
A.H.: E�'un rapporto sfaccettato, sicuramente è molto importante nelle prime fasi di apprendimento (beh, in fondo sei sempre in una fase di apprendimento!) e quando cominci a suonare in qualche gruppo, poi l'interazione diventa piú intuitiva e si basa meno sul linguaggio, specie se lavori per anni con gli stessi musicisti. A quel punto ti conosci così bene che un suono o uno sguardo ti bastano per capire dove si sta andando, per essere in sincronia. Questo però si ricollega anche al fatto di lavorare con musicisti con cui condividi l'impostazione generale e con cui stai bene anche a livello umano, personale.
Del resto, che senso avrebbe passare ore e ore di prove o settimane di tour con persone con cui potresti fare a pugni? La vita è troppo breve! [ridiamo entrambi] Non va bene nemmeno per il pubblico.
Per quanto riguarda poi il mio personale uso delle parole... è lo stesso rapporto che ho con la musica: usare meno elementi, togliere note piuttosto che aggiungerle, cercare la precisione, entrare nel cuore delle cose eliminando ciò che non è essenziale, centrale.
Rispetto ai nomi dei dischi e dei pezzi, beh, per esempio puoi usare le parole per evocare situazioni o immagini ben precise, come facevamo con i Food, associando alla musica la metafora del cibo, e come ho fatto in Sakuteiki, che è anche il nome di un trattato sull'arte del giardinaggio giapponese, e a cui mi sono ispirato nell'impostazione del disco e nella progressione dei brani.
Ad esempio “Sanmon ��" main entrance” che si riferiva al tempo, “Inside tea-house”, “The Beauty of Bamboos”, o ancora “Stones Should be Never Placed Carelessly”, tutto questo è ispirato dallo stile dei giardini giapponesi, metti un sasso in un certo posto o in un altro, è un po' la stessa cosa nella musica, si tratta di estetica, di come creare certi spazi.
In Chiaroscuro invece si trattava di luce ed ombra, e in quel caso c'entrava anche il cinema, ad esempio “Bird's-eye-view” rimanda alla prospettiva dall'alto, “Blue Silk” evoca un'atmosfera ovattata, romantica, in “Parallel Action” pensavo ad un'azione parallela musicale proprio come quando in un film hai due scene in contemporanea; tutti i titoli dei brani rimandano ad un'immagine precisa, e prendono spunto da tecniche cinematografiche.
Oppure rinunci del tutto alle parole, come nei dischi di Supersilent, dove abbiamo usato una classificazione numerica per non influenzare in nessun modo l'ascoltatore. Anche le copertine dei CD sono molto sobrie, e all'interno non ci sono nemmeno i nomi dei musicisti! Più semplice di così!
AAJ: Un'ultima domanda: cos'è per te l'improvvisazione?
A.H.: Infatti, che cos�'è l'improvvisazione? Per me è reagire a ciò che fanno gli altri, è interagire. Questa è la prima definizione che ti darei, ma naturalmente ci sono molti altri elementi in gioco nel processo improvvisativo. Ha anche a che fare con un piano emozionale, con quanto tu vuoi e sei in grado di dare, e con quanto sei capace di trasporre il tuo sentirti nella musica all'interno della tua sfera emotiva. Voglio dire, ci sono musicisti che escludono la possibilità di coinvolgimento, di essere toccati, emozionati da quello che fanno perchè pensano che altrimenti perderebbero quel particolare momento... per me è esattamente l'opposto, a volte - beh, forse questo non lo dovrei dire! [ride] -, a volte, non dico che mi commuovo ma comunque sento che sta succedendo qualcosa di molto forte nell'interazione con gli altri musicisti, e insomma non cerco di evitare il coinvolgimento emotivo, come non cerco di sopprimere sensazioni di tristezza, o di malessere, quando mi ci trovo dentro.
Quindi per me l'improvvisazione diventa il luogo perfetto, il luogo ideale dove essere, è quello che ti concedi, può essere un piacere immenso come può essere uno scivolare sempre piú giù. Certo, anche suonare musica notata è incredibile a volte, entrare nel pezzo e portarci la tua migliore energia, ma mi sento più vicino all'improvvisazione, per quel senso di imprevisto, di sconosciuto che ti dà.
Naturalmente se suoni in una formazione che conosci molto bene, per me ad esempio i Supersilent, in parte sai già quello che potrebbe succedere, ma quando riesci ad avere anche quei 10, 15 secondi con quel certo sapore, con quel gusto unico, beh, non saresti mai riuscito a scriverlo! Qualche musicista contemporaneo che ha sentito i Supersilent mi ha detto: “vorrei poterla comporre, la vostra musica”.
Ma non è facile, è il momento, come essere nel momento, come riuscire a far emergere... beh, potremmo parlarne per ore in termini di elementi musicali, ma l'improvvisazione ha anche a che fare con la sincerità. Quando suoniamo, con i musicisti con cui collaboro, sento che tutti abbiamo questo approccio, è come aprire una porta e dire: “eccomi, sono qui, questo è quello che sono, what you hear is what you get, sono questo e non qualcos'altro”. E quando ci sei, quando sei in questo spazio... eh! [sospiro di soddisfazione]
A volte quando un concerto non va come vorrei, non c'ero come avrei voluto, mi verrebbe da dire: datemi un'altra possibilità! Fatemelo rifare, please!
Insomma, non sempre riesci ad essere completamente concentrato, focalizzato, esserci, lasciarti trasportare... e poi non è solo quello: a volte devi porti di fronte alla musica e pensare a dove stai andando, ma se ti fermi a pensare a com'è stato pazzesco 10 secondi fa ti sei già perso. E questo deve avvenire anche a livello collettivo. Sono rari i momenti in cui ce l'hai, in cui ti dicono che c'era swing... ma cos'era poi? Era il ritmo, erano gli accenti, era... questi sono aspetti tecnici, ma c'è molto, molto di più.
AAJ: Qualcuno parla di una specie di “telepatia” tra musicisti...
A.H.: Esattamente! Perché vedi, ti formi magari in qualche scuola, poi cominci ad analizzare i solisti, li ascolti, li trascrivi, li imiti per imparare, e così via... c'é molto artigianato in tutto questo, per poter suonare devi sviluppare determinate abilità. Ma ad un certo punto ti dovrai lasciare andare, e per farlo sarà importante che tu conosca i musicisti con cui stai suonando, che ti senta bene e che abbia fiducia, che ti fidi di loro. Perché, come ti dicevo, se sei sincero metti tutte le carte in tavola, ma chi ti garantisce che gli altri ti sosterranno? Ti daranno una mano o ti lasceranno magari andare avanti a fare CRRRRRR? [ridiamo]. E' questo: ci vuole un'estrema fiducia, e finchè non ce l'hai, la musica non potrà arrivare veramente al pubblico.
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.