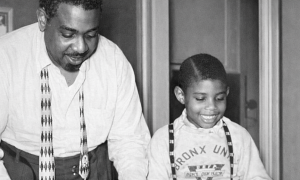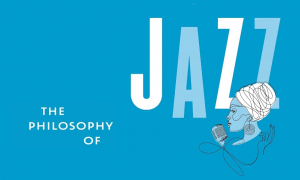Home » Articoli » Interview » Intervista a Stefano Bollani
Intervista a Stefano Bollani
Perché è importante fare sempre “una cosa diversa”? Perché me ne piacciono tante!
Lo incontriamo sul set della trasmissione radiofonica Il Dottor Djembé, che conduce assieme a Davide Riondino e Mirko Guerrini, con la scusa del recentissimo riconoscimento come “miglior musicista europeo” per l’European Jazz Prize, ma soprattutto per provare a capire come un personaggio così multiforme e tuttavia sempre capace di trasmettere contenuti di altissima qualità affronti, anche mentalmente, il palcoscenico e la sfida sempre ardita dell’improvvisazione creativa.
AAJ: Bollani miglior musicista europeo; Bollani intervistato dai giornali per ogni cosa che riguardi la musica (recentemente perfino sugli Ipod); Bollani come il prezzemolo. Però anche Bollani personaggio autentico, buontempone che sul palco si circonda spesso di amici. È dura o è divertente?
Stefano Bollani: No, è solo divertente. Non c’è nessuna controindicazione. Come dice Rava e come io ricordo sempre - perché è una bellissima filosofia - i premi e i concorsi sul miglior musicista o il miglior disco sono una colossale stupidaggine, perché non ha senso mettere in competizione artisti diversi, ciascuno dei quali fa cose diverse e non direttamente confrontabili. Però, visto che esistono, conviene vincerli!
Questo vuol dire che sono ben contento d’aver vinto l’European Jazz Prize, soprattutto perché entro a far parte di una piccola famiglia della quale fanno parte Tomasz Stanko, Bobo Stenson, Bojan Zulfikarpasic, personaggi che ammiro molto, e poi perché grazie al premio mi conosceranno meglio in zone d’Europa dove ancora non ero noto, e se mi si sposta il baricentro dei concerti mi fa piacere. Detto questo, però, rimane che il premio in sé non significa nulla: non è cambiata la mia vita, non è cambiata la mia percezione di Stefano Bollani. Forse anche perché non sono una di quelle persone un po’ insicure che hanno continuamente bisogno di conferme: non penso di essere il miglior musicista europeo, però non ho neppure bisogno di conferme (peraltro, ne ho anche troppe!).
Quindi, alla fine rimane la pubblicità: per la prima volta ho la copertina sulle riviste di jazz austriaca e svizzera, per la prima volta tutti i giornalisti d’Europa sono “costretti” a sapere chi io sia, per la prima volta vado a suonare in certe città - ad esempio, a Zagabria, dove mi hanno cercato quando hanno saputo che ho vinto il premio.
AAJ: Problemi di convivenza con altri “fenomeni di successo”?
S.B.: Nessuna. Io faccio le mie cose, gli altri le loro. Potrei dire che forse c’è il rischio che qualcuno ci confonda, ma vista la differenza di stili e musiche, può accadere solo all’ascoltatore poco accorto. Per cui la cosa non mi preoccupa proprio.
AAJ: Ci sono però una certa quantità di critici che, forse influenzati negativamente dal tuo successo, pur non disconoscendo le tue qualità tendono a enfatizzare un tuo aspetto, quello “spettacolare”, cabarettistico, sostenendo che il tuo passare da Piano solo ad Arbore, dal trio danese al Dottor Djembé non ti aiuterebbe a trovare un “tuo stile”.
S.B.: Mah, a me sembra che lo stile sia proprio lì! Nessuno fa queste cose, dunque proprio questa è la mia specificità, no?
Detto questo, capisco il pericolo e anch’io lo temo un po’. Però credo che la cosa vada misurata sui risultati. È un pericolo che corro fin da quando ho iniziato, quando cioè, a diciotto anni, suonavo in un gruppo jazz, ma anche musica brasiliana con Barbara Casini, e poi andavo in studio con Raf. Allora mi sentivo più scisso di adesso, perché ora faccio quello che voglio e mi sento sempre me stesso, anche se quando accompagno Cristina Donà suono ovviamente in un modo diverso di quando accompagno Cristina Zavalloni... Però in realtà posso sempre fare Bollani, né più e né meno che al Dottor Djembé, dove dico quello che voglio.
Quindi, visto che faccio quello che mi piace, non posso che essere sereno. Dopodiché, se i risultati vengono a mancare, se mi si dice - e me lo si deve dire chiaramente - che suono in maniera sempre più scontata o, peggio (sempre che abbia senso dire “peggio”!), che a fare il Dottor Djembé perdo il mio tempo, beh, se ne può parlare. Ma mi pare che tutti puntino il dito sul pericolo che questo possa accadere e non sul fatto che accada già! E con questo trascurano un fatto, cioè che per me tutte queste attività sono linfa vitale, perché da questo tipo di divertimento traggo anche la motivazione per fare altre cose. Tanto che - e di questo sono stato molto contento - nella motivazione dell’European Jazz Prize viene sottolineato il fatto che io porti una ventata d’ironia grazie alle cose che faccio e al mio modo di stare sul palco. Ovviamente il premio nasce dal Piano solo dell’ECM, che è arrivato a tutti i giornalisti europei - se no in Lituania non avrebbero mai saputo che esistevo! Però, partendo da quel disco, la motivazione parla de I visionari, del trio danese e anche del fatto che parlo, faccio lo spiritoso, faccio altre cose. E ne parla non dicendo “è tanto bravo, ma...”, bensì sottolineando che il premio mi viene dato anche per questi aspetti “altri”. È un premio a tutto tondo. Direi che siano stati lungimiranti a capire che o mi prendono così, o è inutile fare. Non si può dire “bella quella cosa li, ma quell’altra non lo riguarda”, perché tutto quello che faccio mi riguarda!
Comunque, i dubbi ce li ho eccome: che ad andare in TV e a partecipare a tanti eventi extramusicali rischi di andare troppo in là è una possibilità che mi prospetto spesso. Infatti ultimamente ho rifiutato alcune offerte e sono quasi sparito!
Poi c’è anche un altro tipo di problema, cioè l’eccessivo rilievo che viene dato agli aspetti “extramusicali” dei miei spettacoli: magari faccio una serata in cui suono un’ora e racconto una barzelletta e il giorno dopo sul giornale parlano della barzelletta... Purtroppo questo fa parte del modo in cui ci si occupa delle figure di successo, vale per me come per gli altri: su tutti si fa gossip. Certo, magari dal giornalismo jazz mi aspetterei che ci si limitasse a valutare se abbia o meno suonato bene, tralasciando le barzellette...
AAJ: Ma c’è qualcosa di male a raccontare le barzellette?
S.B.: No, solo che diventano importantissime! O meglio, per il pubblico no: se c’è uno, anche solo uno che viene a teatro, pagando mediamente 20 euro di biglietto, perché vuol vedere un comico che suona il piano, credo che la volta dopo non ci torni, perché in un’ora e mezza le parti divertenti sono al massimo dieci minuti. Troppo poco! Quindi io non credo che il pubblico venga perché racconto le barzellette: con la recessione che c’è, andrebbero a vedere Aldo, Giovanni e Giacomo. No, il pubblico viene per il musicista. Per uno che non ama il jazz, un’ora di jazz per una barzelletta è una punizione troppo dura!
AAJ: Però si potrebbe vedere la critica anche da un punto di vista rovesciato: Piano solo è certo una delle cose più “pure” e raffinate che tu abbia mai fatto, perfino più del trio danese - che pure ha un’identità jazzistica molto precisa ed è indiscutibilmente di una qualità assp;ita. Ma, proprio per questo, si potrebbe dire che manca proprio il Bollani al quale siamo abituati, il Bollani multiforme e spiritoso...
S.B.: Ah, sì, ricordo la tua recensione, e ricordo anche che dissi: “ma non sono mai contenti! Una volta che faccio più il serio, si lamentano perché non faccio ridere”. È vero, uno che mi conosce sa che posso essere molto più diretto con l’umorismo - vedi il colpo di pistola in Concertone - ma, in realtà, se uno non sa nulla e ascolta Piano solo ci trova anche delle cose divertenti. Certo sono più sul piano musicale: c’è “A media luz” che è fatta in maniera divertente (oltre ad essere divertente di per sé, essendo un tango popolare), c’è “Ragtime” che è trattata in un certo modo, e via dicendo. Un po’ poco, forse, rispetto ad altre cose mie, che sono più eclatanti.
AAJ: Direi che, oltre il divertimento, l’inventiva - che pure c’è eccome - è più “compassata”.
S.B.: Sì, capisco, ma questo vale anche per The Third Man con Rava, se non fosse che essendo a due voci si nota forse un po’ meno.
AAJ: La mia impressione è che in The Third Man tu sia meno compassato, che la presenza in primo piano di Rava ti permetta maggiore libertà rispetto a Piano solo
S.B.: È un giudizio interessante, perché non corrisponde alla mia sensazione. Ma, a parte questo, io ho smesso ormai da diverso tempo di pensare che il disco debba essere il riassunto di tutto quello che sai fare. Ho smesso anche di pensare che l’uomo sia un animale in evoluzione e che il disco appena fatto sia meglio di quello precedente. Semplicemente, vorrei che i dischi fossero tutti diversi. Per cui, se un disco è un po’ più compassato dell’altro a me va benissimo, così come mi va benissimo di fare un disco di cazzate e basta. Poi i giornalisti scriveranno che ho deciso di smettere di suonare il piano e di fare solo cazzate. No! È quel disco lì, non è che da lì in poi farò tutto in quel modo, così come non è che da Piano solo in poi ho avuto intenzione di fare solo cose di quel genere.
Più in generale, direi che nei dischi l’umorismo tendo ad attenuarlo, perché un conto è far ridere le persone sedute contemporaneamente tutte assieme in un teatro dicendo e facendo qualcosa anche visivamente e poi è finita lì (il giorno dopo si ricordano la battuta e basta), un altro è un disco, che chi lo ha comprato si presuppone lo ascolti trenta volte: una battuta non funziona per trenta volte, diversamente dalla musica che, se è bella, funziona e la si riascolta volentieri. A volte ho registrato cose buffe che poi ho tolto perché alla terza volta che le ascoltavo non facevano più ridere.
In effetti, se ci pensi bene, a parte il colpo di pistola in Concertone, non è che i dischi siano pieni di cose divertenti. C’è qualcosa su I visionari, ma anche lì si tratta di due canzoncine all’interno di un doppio. Non così tanto come dal vivo.
AAJ: Ne I visionari, peraltro, tu tendi ad essere più controllato, probabilmente perché sei il capo orchestra.
S.B.: Sì, certamente. Infatti suono più liberamente con Rava, in particolare quando suonavamo in quintetto: lì mollavo proprio gli ormeggi, perché non avevo responsabilità e quindi godevo di più libertà. Se hai il tuo gruppo è ovvio che hai altri pensieri, vuoi che suonino bene tutti e la responsabilità perché ciò accada è tua, quindi devi fare più attenzione agli altri e meno a quello che fai tu, limitandoti.
AAJ: Accennavi al fatto di non essere un insicuro, cosa molto importante, perché ti lascia libero di muoverti senza doverti preoccupare di avere schemi prestabiliti; mi hai anche detto che per te è importante lavorare in ambiti diversi, perché ti offre altri stimoli, ti dà altre cose da mettere dentro la creazione musicale. Poi ti si ascolta, anche in situazioni poco preparate con artisti che non sono tuoi partner abituali, e si assiste - con piacere, aggiungerei - al tuo dirigerti in territori inattesi, seguendo la tua strada senza però collidere con gli altri, né prevaricarli. Sei Bollani, ma al tempo stesso non sei scontatamente Bollani. Cosa succede in questi casi? Detta in una forma a cui non si può rispondere, cosa pensi quando improvvisi?
S.B.: Cercando di esprimere in parole un procedimento che è spontaneo - almeno quello, perché poi i dubbi sulla carriera e sull’immagine li ho anch’io, non sono spontanei e anzi sono piuttosto faticosi! - la prima cosa che mi sento di rispondere è che, da ascoltatore, non voglio annoiarmi. Non voglio fare un pattern, perché se lo faccio mi deprimo e la prima cosa che penso è che ho messo il “pilota automatico”. Quando accade, vuol dire che mentre suonavo pensavo ad altro, e mi dispiace. Può succedere, fortunatamente mi succede molto raramente, però vorrei che non accadesse mai. Andando avanti con l’età e continuando a suonare tutte le sere, questo è il pericolo maggiore. Perché certo è dura suonare di continuo e non annoiarsi mai! Per ora sono contento, mi capita magari una sola volta all’anno, perché sei stanco, il pianoforte non ti piace, qualcosa fin dall’inizio girava storto, parti male, insomma qualcosa ti rovina il concerto... Ecco, quello è brutto! Quando te ne accorgi ti dà fastidio, ma è tardi, perché poi non ti riesce più niente.
È come quando leggi un libro, arrivi a pagina venticinque e ti accorgi di non ricordare cosa hai letto prima, perché pensavi ad altro. Ecco, anche se mi succede una sola volta all’anno, quella volta ce l’ho ben presente, perché - a prescindere dalla qualità della musica - è proprio l’ultima cosa che voglio. Perché non mi va di fare quello che sale sul palco e suona ciò che sa che la gente vuole per applaudire. Io so bene cosa fare per farmi applaudire, ma è troppo facile, mi annoierei a farlo, e non ho voglia di annoiarmi. Rischierei di smettere, preferirei fare un altro mestiere.
La prima cosa, quella che guida tutti i miei movimenti, è questa. Per cui, mentre suono cerco sempre di evitare di fare la cosa che potrei fare, vado alla ricerca di una cosa diversa.
AAJ: Una cosa diversa da quel che potresti fare: molto interessante. Tutto questo, ovviamente, spontaneamente: non pensi a fare una cosa diversa, ma cerchi una cosa diversa, e quella che mi hai appena detto è una ricostruzione a posteriori, sul tipo delle teorie sull’improvvisazione di Davide Sparti.
S.B.: Sì, certo. Infatti è una cosa che non mi coglie impreparato, ci ho pensato a lungo e ho presente anche i libri di Sparti.
AAJ: Dunque, la spontaneità si verifica perché quando studi, quando ti prepari a suonare, non appronti pattern e schemi preconfezionati, ma metti invece avanti un’esigenza di creatività, di ricerca del nuovo.
S.B.: Esatto. È quel che ho cercato di fare da poco dopo che ho iniziato a studiare jazz, cioè diciamo cinque o sei anni dopo. All’inizio trascrivi i soli di Charlie Parker e cerchi di suonare quelle frasi lì. È come quando apprendi una lingua nuova e impari le frasi fatte: “posso andare al bagno, per favore?”, oppure “mi fa un caffè, grazie?”. Le devi imparare, altrimenti non puoi comunicare. Una volta che hai superato lo stadio delle frasi fatte, cominci a pensare in quella lingua. Per me è la stessa cosa. Forse neanche Sparti la spiega così. Perché la musica è un linguaggio: la gente non capisce come si fa a improvvisare, ma parlando improvvisiamo continuamente! È che padroneggiamo la grammatica, e talvolta utilizziamo anche delle frasi fatte, certo, e spesso iniziamo le frasi nello stesso modo...
Io ad esempio inizio spesso dicendo “il problema è...”, me ne sono accorto quando insegnavo. Non ci posso far nulla, mi viene così, l’importante è che quando vado avanti riesca a far dimenticare che inizio sempre nello stesso modo. Infatti, se vai ad analizzare le frasi di Parker ti accorgi che ha più o meno dieci modi di iniziarle: per fortuna, però, va avanti in modo diverso! Ed è questo l’importante.
Si può anche parlare tutta una giornata per frasi fatte: se infili una serie di “cielo a pecorelle, acqua a catinelle” ti prendono per matto, ma se lo fai bene chi ti ascolta non se ne accorge neppure. Una volta ho sentito suonare i preludi di Debussy da Jörg Demus, senza sapere che fosse lui: ebbene, credevo fosse uno che improvvisava! Il fatto che uno esegua uno spartito e invece sembri costruire il pezzo nota per nota è bellissimo.
AAJ: “Costruire”: questo mi sembra un concetto molto importante.
S.B.: Così come di contro mi piacciono i famosi assoli che sembrano scritti: “ha fatto un assolo che sembra scritto” è sempre un complimento. Viene da dirlo anche a me, sebbene sia un complimento un po’ strano per il jazz... Mi piacciono i soli jazz che hanno una costruzione tale che, anche se avvenuta istantaneamente, potrebbero essere composizioni; e mi piacciono i pianisti classici che suonano delle composizioni in un modo tale da farle sembrare improvvisate. Cosa vuol dire che sembrano improvvisate? Che ogni accordo sembra arrivare per una scelta precisa, fatta però sul momento dall’esecutore, quando invece è Debussy che l’ha deciso, e l’ha deciso un secolo e mezzo prima. Quando ho sentito Demus avevo l’impressione che il pianista la stesse costruendo allora. Sentivo anche delle esitazioni: “che accordo faccio ora?”. E la mia reazione era: “ah, che bello! Che bella scelta!”. Per forza, era Debussy, non era mica uno qualsiasi! Io pensavo che fosse un emulo di Jarrett che stava improvvisando...
Lì ho pensato: “che bello riuscire a fondere le due cose, dare l’impressione di una cosa scritta quando improvvisi e di un’improvvisazione quando esegui una cosa scritta”. Riuscire a padroneggiare una lingua, come il portoghese o il francese, usando delle frasi fatte ma inserendole nel discorso e costruendo dei discorsi improvvisati talmente bene da sembrare un oratore!
AAJ: Però per non annoiarsi è necessario che, partendo dalla stessa base, si abbia a disposizione molto materiale da costruzione.
S.B.: Assolutamente, molti vocaboli. Ma questo è anche il motivo per cui io preferisco di solito partire da canzoncine o da standard semplici...
AAJ: Altra cosa che ti viene spesso rimproverata in modo anche aspro, perché abbandoni la tradizione afroamericana...
S.B.: Ma io non sono afroamericano, non so se se ne sono accorti! A parte le battute, il fatto è che mi è più facile smontare una canzoncina come “Figlio unico”, e poi rimontarla come preferisco, che smontare e rimontare Prokofiev, come mi ero ripromesso per Piano solo. Perché Prokovief quando lo rimonti non funziona più, andava bene così com’era, sia perché era un genio quello che lo ha montato, sia perché vanno persi la sua idea originale e la cultura di partenza. È una cosa che puoi fare su Ravel o Chopin, o anche su Mozart o Beethoven, perché hanno delle celle melodiche che funzionano da sole e quindi puoi improvvisarci.
[Improvvisa oralmente su un concerto per pianoforte di Beethoven]
Ma sulla musica del Novecento, su Strawinsky o Ligeti, o prendi tutto il pezzo, o improvvisare su segmenti non ha senso. In molta musica contemporanea il bello è nella forma in cui è costruita, non nella melodia. Per cui è più facile prendere una melodia di Modugno: quella già funziona, ha un suo mondo, tutti la conoscono, e io posso giocarci. Se prendessi una cosa che nessuno conosce, sarebbe bello solo per me, e solo fino a un certo punto, perché il pubblico non ha appigli, e alla fine io stesso ne avrei pochi per poter giocare. Perché un conto è prendere una cosa e dire al pubblico: “lo conosci questo giocattolo? Sì? Guarda un po’ cos’è diventato: una colomba!”, e un conto e dire “Lo conosci questo?” e sentirsi rispondere “no!”. Il gioco è finito ancor prima di cominciare...
Questo è forse molto postmoderno, me ne rendo conto, però è vero che noi andiamo sul palco e il pubblico, anche se non lo sa, conosce così tanti linguaggi musicali che si diverte quando smonti e rimonti anche se non sa riconoscere o esprimere cosa stai facendo. Ad esempio, se prendo un pezzo e lo suono ragtime, nessuno sa dire “ragtime”, ma tutti riconoscono in qualche modo uno stile: “Ah, La stangata!”. Oppure se lo faccio a valzerino, magari non riconoscono che è un valzer e tantomeno che è in 3/4, però sentono un’atmosfera. Questo giocare con gli stili oggi si può fare, perché spiazza e contemporaneamente è un gioco sul linguaggio che il pubblico capisce. Se faccio un valzerino e poi, stroh, vado giù con i gomiti, lo capisce anche mia nonna che quella cosa lì è una rottura di linguaggio!
AAJ: Certo, e questo rinvia ad un altro aspetto che mi sembra importante e che trovo che tu non trascuri affatto. Nel jazz si improvvisa, ma lo si fa con qualcuno: con i musicisti, innanzitutto, ma anche con il pubblico. Invece oggi tra i musicisti è in crescita la tendenza a trasformarsi in quelli che Daniele Sepe definisce “i sacerdoti della musica”, vale a dire a stare sul palco con freddezza e distanza nei confronti del pubblico. Per te questo non vale: lo si percepisce bene ai tuoi concerti, ma - era evidente dalle tue parole - è anche una cosa ben presente nella tua concezione della musica: vuoi avere un rapporto con il pubblico, vuoi giocarci.
S.B.: Non solo, ma giocare con il linguaggio non vuol solo dire far ridere il pubblico. Questo aspetto risaltava negli esempi che ho fatto prima, o nel colpo di pistola di Concertone: sono episodi umoristici talmente evidenti che si risale a prima dei fratelli Marx, è il clown che prende la torta in faccia. Poi però ci sono mille microgiochi, come quelli in Piano solo. Alcuni dei quali sono anche pericolosi, perché non vogliono essere divertenti, ma lo possono diventare. Per riprendere il paragone con il linguaggio, se io sono con una ragazza, l’atmosfera è molto romantica, stiamo parlando d’amore - ed abbiamo perciò un vocabolario molto limitato, perché lo è quello con cui si parla d’amore - e io a un certo punto dico: “Hai presente Robert Musil? Vedi, cara, questa situazione mi ricorda Musil...”, beh, mi faccio ridere dietro! Ecco, questa situazione è a rischio, così come se mi sfugge una volgarità... Analoga situazione si può verificare nella musica: vorresti fare una cosa raffinata, ma è profondamente fuori luogo e diventa comica, anche se tu non volevi che lo fosse, ed era meglio se evitavi del tutto.
Talvolta, quando cerco di effettuare dei passaggi da un linguaggio all’altro, succede che non mi riesca bene, che lo scarto non sia sufficientemente “morbido”... e allora la butto sul ridicolo! “Apro”, e suggerisco che sto scherzando! Mi capita, ad esempio, quando suono e mi sembra di citare un altro pianista. Ad esempio, se suono e mi viene frase così...
[si alza e va al piano, dove suona una frase smaccatamente tyneriana]
... ecco, allora mi scappa subito da ridere e penso “eh, ma che vogliamo fare, McCoy Tyner dei poveri?”. In questi casi, ci puoi scommettere che la frase dopo è uno sberleffo! Ma perché? Perché sono io che voglio dire al pubblico: “sì, lo so, m’è scappato McCoy Tyner... Però lo so!”. Non mi va d’esser preso in castagna, non mi va di leggere il giorno dopo “bravo, però ricorda McCoy Tyner”, e allora dico subito che l’ho fatto apposta... Anche se magari non l’avevo fatto apposta, m’era uscito perché ce l’ho nel linguaggio.
AAJ: Anche questa è un’osservazione molto interessante, perché sta a significare la presenza di uno spontaneo controllo critico che hai su quello che stai improvvisando.
S.B.: Sì, ma questo è evidente anche in altri contesti. Ad esempio nel Dottor Djembé se qualcuno di noi dice una battuta troppo lunga, o troppo seria, o comunque fuori dal contesto, gli altri o lui stesso prima o poi la massacra. Ma vale anche, altro esempio, per il mio libro La sindrome di Brontolo, che contiene una certa quantità di frasi plateali che funzionano solo contestualmente. Me ne sono reso conto quando, una volta, nel corso di una presentazione un’attrice ha letto alcuni passaggi e si interrompeva sempre su frasi lapidarie, tipo: “la vita è sempre più fantasiosa di come ce la immaginiamo”. Punto. Tremendo! “Ma davvero ho scritto questo?”, mi veniva da pensare. Il fatto è che nel libro subito dopo un personaggio interveniva dicendo ad esempio “ah, che bella frase sulla vita, questa me la segno!”, cioè sdrammatizzava. Se invece quella frase viene letta a sé, diventa terribile! Quella frase è fatta apposta perché subito dopo qualcuno la demolisca; tolta la demolizione, diventa un luogo comune!
Per questo dico che anche nella musica è importante prendere tutto il pezzo: perché la frase da sola può essere di una semplicità disarmante, ma nel contesto può assumere un significato completamente diverso.
AAJ: Passiamo invece all’importanza del rapporto con i musicisti. Tu sei solito circondarti di ottimi musicisti, che però sono anche e forse soprattutto amici con cui stai bene.
S.B.: Sì, anche perché nel jazz spesso siamo un po’ troppo “individui” e talvolta si sente la mancanza di un “gruppo”. Così ne I visionari ho voluto tutti coetanei, persone con cui andare in giro e condividere un progetto. Ora, non vorrei mai far parte dei Rolling Stones, che stanno assieme da quarant’anni, però neppure suonare con altri tre diventando inevitabilmente (a meno che non siano Rava e Gato Barbieri) lo Stefano Bollani Quartet. Con I visionari il tentativo, sostanzialmente riuscito, è di essere un gruppo in cui tutti si sentono importanti e partecipi del progetto.
AAJ: Però mi sembra di vedere che questo contatto umano, questa trasmissione di aspetti che vanno aldilà del mero contenuto professionale, funzioni anche in altri contesti e con musicisti con cui ti ho visto suonare solo occasionalmente.
S.B.: Si, certamente, anzi ti dirò che, quando faccio qualcosa con musicisti in incontri occasionali e la cosa funziona, di solito non voglio neppure risentire quel che abbiamo fatto, perché lo giudicherei da musicista, mentre l’impressione immediata è da performer e mi va bene così. Questo vale anche con musicisti con cui suono spesso, ma con i quali faccio determinate cose. Con Antonello Salis, ad esempio, se facessimo un disco sarebbe pieno di sporcizia, di lungaggini, di cose non sviluppate; però nel live con Antonello è perfetto così, non me ne frega nulla della sporcizia, perché quello che mi interessa è che a me e al pubblico arrivi un’energia.
AAJ: Qui c’è questa differenza interessante tra il live e il disco: nonostante che prima tu abbia detto che non ti interessa che nel disco ci sia tutto quello che uno sa fare, resta il fatto che nel disco ci deve essere...
S.B.: ...un’identità! Il disco BollaniCarioca, che è tutto brasiliano, ha un’identità, anche se sarebbe limitativo nel caso dovesse essere il mio passaporto per l’eternità. Peraltro, se dovessi spedire un mio disco su una sonda nello spazio, non saprei quale scegliere!
AAJ: Però la sporcizia non deve esserci...
S.B.: No, ci può anche stare... Però è anche vero che quel disco lì arriverà in una copia in un paesino della Polonia, dove non mi vedranno mai e non sentiranno più altri miei dischi, e allora ci tengo che mi piaccia. Tutto quello che pubblico voglio che mi piaccia.
AAJ: Hai citato il tuo duo con Antonello, e non c’è alcun dubbio che ci sia una bella differenza tra vedere una cosa del genere dal vivo e ascoltarla su disco: come ascoltare la colonna sonora di un film o vedere anche le immagini.
S.B.: Certo. Ma poi, intendiamoci, anche i dischi sono pieni di sporcizia; il punto è che nei dischi mi interessa meno l’energia, e mi interessa invece che dieci anni dopo possa ancora ascoltarlo senza esserne pentito. Magari senza riconoscermi più, con affetto, come si va ad ascoltare un vecchio amico o si legge una lettera d’amore che hai scritto vent’anni prima... Però se non la trovi piena di errori grammaticali e non ti sembri ridicolo, non ti vergogni e sei più contento!
Poi è chiaro che non è pensabile che uno ascolti i suoi vecchi lavori come il giorno che li ha registrati. Non credo che Miles impazzisse quando riascoltava Kind of Blue: magari pensava che fosse un capolavoro, ma non gliene fregava più nulla! Per me lui è sempre l’esempio principe: ha fatto un sacco di capolavori, conscio di averli fatti, però conscio anche del fatto che non gli interessavano più. È una mia idea di Miles, ma sono convinto che non pensasse a un’evoluzione, cioè che non fosse preoccupato del fatto che Kind of Blue fosse meglio di On the Corner: non gliene fregava nulla, l’importante era fare una cosa diversa. Dopodiché, se il mio disco migliore, secondo tutti, rimane quello di dieci anni prima, pace!
AAJ: Perché è importante fare “una cosa diversa”?
S.B.: Perché me ne piacciono tante! Non è presunzione: ognuno ha delle possibilità e nella vita sceglie quale realizzare e quali no. Questo vale per tutte le attività che uno può fare: usiamo solo una parte delle possibilità che ci sono state date, mentre sarebbe bene, sarebbe bello provare a utilizzarle idealmente tutte. Una scelta artistica ti costringe a farlo più di altre. Io da bambino volevo stare sul palco: cantare, suonare o recitare era uguale. Quando mi chiedevano chi volevo essere non sapevo rispondere. Non volevo essere Bill Evans... e certo non volevo essere neppure Vargas Llosa...
Non me lo sono dimenticato. L’importante era e rimane stare sul palco e trasmettere qualcosa. Che cosa e come trasmettere è secondario, l’importante è sapere che lo vuoi fare e ogni volta fare una cosa diversa perché te ne piacciono tante. E, visto che ti piacciono, metterle assieme - che poi è quello che ha sempre fatto il jazz, senza stare a distinguere troppo se quel che veniva messo assieme era bianco o nero, popolare o colto.
AAJ: Come mi diceva qualche tempo fa Gabriele Coen, ci si dimentica spesso che al centro del jazz delle origini non c’era tanto la componente afroamericana, pur maggioritaria, quanto la compresenza di tante componenti - italiana, caraibica, ebraica - che si fondevano assieme senza troppe mediazioni. Infatti già il termine “afro-americano” è indice della contaminazione.
S.B.: È vero, ed è curioso che esistano “puristi” del jazz, perché musica più impura di questa non esiste al mondo! Peraltro il “purismo” è cosa che riguarda ascoltatori, critici e musicologi, perché tra i musicisti non ho mai sentito dire niente di tutto ciò: l’importante è che sali sul palco e suoni.
Che il jazz non fosse una musica pura l’avevano già capito i nazisti: non a caso l’avevano proibito! E - dando una patente d’intelligenza ai nazisti... - il problema non era tanto il fatto che ci suonassero neri ed ebrei, ma che si trattava di un esempio di interazione che mostrava come da un incrocio di culture venisse fuori qualcosa di migliore del materiale di partenza. Quest’ultima cosa vale per ogni elemento che sta dentro al jazz: il blues da solo, ad esempio, è bellissimo, ma dopo venti minuti che suono blues e basta, per quanto bello sia, non ne posso più. Vuoi mettere gli stimoli di un contesto nel quale può succedere qualsiasi cosa? E credo che anche per il nazismo il problema fosse questo: “c’è questa cosa qui che si basa sulla contaminazione delle culture e piace, sta piacendo a tutto il mondo: è un pericolo! Se sfonda, allora sì che i tedeschi si sposeranno con i neri e con gli ebrei, e i neri e gli ebrei tra loro, e via dicendo. Dobbiamo proibirla!”
Intendiamoci, un fenomeno analogo si verifica anche in altre forme artistiche, per esempio nelle avanguardie europee, che si sono alimentate della fusione di culture e sensibilità diverse. Il surrealismo o il dadaismo crescevano a Parigi grazie a tedeschi, italiani, francesi, russi, polacchi... Ed infatti anche questo era un modello “impuro”, che poggiava sulla contaminazione e si scontrava con ogni progetto di “purezza” e perciò andava proibito. Il modello giusto era Wagner, tedesco che musicava testi in tedesco, che in tal modo lasciava la possibilità di giudicare su base nazionale chi fosse più bravo.
Oggi accade quasi il contrario, dato che sta diventando necessario fare cose che travalichino i confini nazionali. Sai quanto si sente dire “eh, sì, è bravo, ma suona sempre solo con italiani”, o “vorrei sentirlo con gli americani”, quasi che fossero una categoria di riferimento? Oppure, per essere interessante devi avere nel gruppo il bassista ceco, il trombettista vietnamita, il pianista lituano.
AAJ: Il “multietnico” come etichetta...
S.B.: Sono cose che in certi posti, ad esempio a New York, possono avvenire, ma perché accadono naturalmente: ci sono musicisti di mille nazionalità e culture diverse, si incontrano in un bar, suonano assieme. Bene! Ma quando ci sono addirittura leggi in base alle quali per partecipare a un festival devono esserci progetti con elementi di almeno tre nazionalità diverse, che senso ha? È l’opposto del nazismo, ma per certi versi, in realtà, è l’analogo...
Foto di Roberto Cifarelli (la prima, seconda. quarta, quinta, settima) e Claudio Casanova (la terza, sesta, ottava).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.