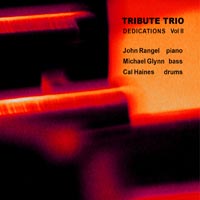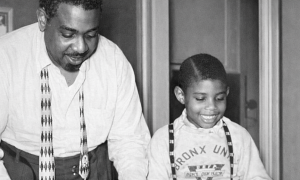Home » Articoli » Interview » Intervista a Osvaldo Coluccino
Intervista a Osvaldo Coluccino
L'uscita di quest'ultimo CD è stata l'occasione per approfondire alcune tematiche di ricerca con uno dei più stimolanti compositori italiani.
All About Jazz: Molte delle tue opere nascono e si sviluppano nel tempo, penso in particolare a Stanze (2004-2011) e agli String Quartets (2002-2008), ma anche a tante altre che hai scritto. Mi piacerebbe che raccontassi come si sviluppano questi lunghi "cicli".
Osvaldo Coluccino: È un atteggiamento piuttosto classico quello di voler riunire le proprie composizioni entro raccolte per organico o genere ecc. E nel mio caso la registrazione audio rappresenta lo scrigno entro cui depositare durevolmente tal genere di progetti. Ognuno di essi, peraltro, ha un suo habitat, con proprie nuances. A volte costruisco dentro di me per anni - addirittura già da quando il tutto è ancora intelaiatura - questi progetti unitari, monotematici. Un progetto acustico e tre elettroacustici sono già realizzati e in attesa di etichetta discografica, altri tre sono sulle partiture già finite e ancora da realizzare, e un paio sono nella mia testa, speranzosi d'esser buttati su pentagramma entro il tempo del mio passaggio.
AAJ: L'opera Stanze è giocata sul doppio significato della parola che in italiano indica sia il fatto di stare, di fermarsi e sostare, di dimorare in un luogo, ma anche un ambiente interno, limitato e diviso da un altro da pareti, infine (nella metrica italiana) la strofa di una canzone, intesa anche come componimento a sé stante. Quale di questi significati ha pesato maggiormente nella tua costruzione di questo ciclo?
O.C.: I titoli delle mie creazioni molto spesso sono duplici (a volte c'è polisemia, anagramma come nel caso di Neuma q, ecc.), e, quando non lo sono, vengono sovraccaricati di risonanza semantica per via di qualche stratagemma ineffabile. Ciò premesso, ogni percorso di senso che hai elencato è ugualmente valido.
C'è l'atemporale staticità (di cui ha detto bene Paolo Petazzi); c'è, quale entità che mi emoziona, lo spazio fisico (assieme, volendo, al suo rovescio); e c'è... Posso fare una liaison andando ad unire il tuo rilievo riguardo la strofa di un componimento poetico (una canzone), con la conclusione del testo introduttivo di Alberti incluso nel libretto del CD, che individua nella dodicesima stanza un enigmatico e soave "canto" finale a sé stante.
AAJ: Nelle note al libretto hai fatto riferimento a varie celebri stanze, riferendoti "alla stanza pacata e statica di Vermeer o a quella statuaria e solenne di Piero della Francesca," o a "quella di Morandi ove la dialettica imbastita fra vasellame e piano del tavolo satura le propensioni e pone quel momento di vita fragile come imperitura offerta, lo fa assurgere a nesso - posto fra i silenzi d'intorno, sospeso entro il vuoto da cui si inizia". La pittura mi pare giochi un peso importante nella costruzione della tua musica.
O.C.: Direi che la pittura gioca un ruolo importante nella mia vita. Di conseguenza infonde la mia musica.
Io sono uno di coloro che davanti a certi capolavori dell'arte piange con lacrime. Le opere d'arte (e di conseguenza gli artisti) che mi portano a questo stato sono decisamente in numero maggiore rispetto a quelle musicali (e quindi i compositori sono in numero ampiamente minore). Poi vengono quelle poetiche in versi, sempre parlando per numero e non per pregi o effetti. Ciò non significa che, negli altri due capitoli, cioè musica e poesia, io avverta una sorta di carenza. Tutt'altro: reco nel bagaglio delle mie preferenze composizioni musicali e poetiche che mi sconvolgono per la bellezza. E bastano a tutto. Cito solo tre esempi: l'extra-umano di un Beethoven degli ultimi quartetti per archi, la splendida opera per pianoforte di Schubert, i misteriosi, commoventi racconti di Kafka.
La mia mente è fortemente visiva, percepisco la vita suonata, detta, fiutata, quasi a fotogrammi di inediti film e a scorci di ex novo astratta e figurativa pittura.
AAJ: Dall'elenco delle tue opere si evince che la maggior parte di ciò che hai composto è musica da camera. Le dodici "stanze" sono dunque (forse non tanto metaforicamente) l'essenza delle tue riflessioni sulla musica?
AAJ: Potrebbe anche essere. Nondimeno per me è importantissimo per esempio anche il mio lavoro con le voci. Peculiarità di quel progetto per ensemble vocale: Note e versi poetici della stessa fonte. Ovviamente nulla di egocentrico in questa bipolarità ma appunto "musica + parola" quale cifra del progetto dovuta alla mia doppia, separata specializzazione. Quindi ho già pronta una serie di composizioni per ensemble vocale (2003-2013, l'ultimo brano è in cantiere) che attende di essere eseguita e suggellata in una registrazione. Certo sarebbe bello che ci fosse una fondazione o associazione ecc. disposte a far diventare fruibili quelle composizioni. Poi, ho anche in mente un progetto con Orchestral Works.
Ma tornando alle "stanze": potrei vedere nel percorso lungo di esse, fra spostamenti nel limbo del corridoio e negli ingressi e nelle uscite in vita, l'emblema di un processo che si ritrova anche in tutto il resto, fra consistenza formale e silenzio.
AAJ: Il silenzio acquista un peso notevole via via che ci si addentra nelle diverse "stanze". In particolare la "sesta stanza" custodisce l'essenza del lavoro, anche se la "dodicesima" lo svela. Che rapporto hai con il silenzio?
O.C.: Il silenzio è una delle materie principali che maneggio. Bisogna saper conquistare la naturalezza del silenzio, in "dare e avere," e ciò prevede sacrifici, dedizione mirata e predisposizione.
È un argomento delicato, mi stimoli anche a considerare che al giorno d'oggi non è così raro imbattersi in composizioni con tensione verso quell'assoluto, ma che spesso io trovo sia fare la maniera del silenzio (anche a cura di rinomati Maestri).
AAJ: Questa considerazione mi porta a domandarti di Oltreorme appena pubblicato per Another Timbre. Silenzio, ma forse meglio suono impercettibile, impalpabile, elusivo che trova spazio, materia, forma...
O.C.: Esattamente. Qualcosa si materializza così. Non si tratta di un'opera che si avvale anche di quel... chiamiamolo "secondo tempo" ossia di una sezione pacata a completamento di un quadro espressivo assortito ritmicamente, timbricamente e dinamicamente, con anche escursioni dinamiche dalle punte critiche improvvise, ma si tratta di un'opera giocata interamente, per ben 53 minuti, in quella dimensione elusiva. Le analisi su quell'opera... ad altri.
AAJ: Tornando a Stanze mi pare non potesse essere immaginata in altra forma che per solo pianoforte (per altro con una magica interpretazione di Alfonso Alberti). Forse per potenzialità intrinseche di questo strumento, capace di ricreare da solo ambienti tanto ampi e al tempo stesso silenziosi. Hai immaginato quest'opera in altra forma?
O.C.: Penso sempre alla specificità degli strumenti per i quali compongo. Succede addirittura che, quando mi dedico alla scrittura, io mi invaghisca di essi, e arrivi a considerare quel tal strumento (o quella formazione) come genuina predilezione... del momento. Certamente gli spartiti di Stanze non sono trascrivibili per altri strumenti.
AAJ: In Voce d'Orlo c'è un pezzo intitolato "Senza Soglia". Che relazione ha (se ne ha) con Stanze?
O.C.: Ne ha assolutamente. È ancora una ricerca sullo spazio e sulla prospettiva. Lo spazio circoscritto di un interno (anche stanza come interiorità riparata, entro "le quattro mura" dell'essere) vs lo spazio sconfinato. In un cross-fade: spazio in e out in dissolvenza incrociata, il quale si offre, si nega, si affaccia, scompare, appare...
AAJ: I tuoi Quartetti per archi colgono l'effimero e il fugace: "l'attimo suggellato in ogni nota," scrivi per il quartetto Attimo (2007); per Eco immobile (2002) parli di "pietrificazione della volatilità". Hai cercato di rendere in musica concetti di grande complessità. Cosa dici al riguardo?
O.C.: Sì, "pietrificazione della volatilità" quale volontà di attribuire al, di scorgere nel "fugace" oltranza e durata impossibile, oltre le gabbie temporali. Cézanne perseguì qualcosa di simile, per altra via.
Ma lasciando parlare gli esempi che hai riportato, con la loro carica figurale, dirò qui di séguito invece qualcosa in generale riguardo la complessità cui alludi, dirò qualcosa di apparentemente intricato e contradditorio, ma al fine invece di far chiarezza.
Quando penso all'arte penso al Linguaggio, che basta a se stesso; cioè esso non necessita di stampelle ai margini che spieghino, traducano, che illustrino con immagini recate da altri campi apparentati dell'espressione.
Ma ampliamo un attimo il caso. Quando penso ad un soggetto il quale, indipendentemente dal proprio campo di ricerca, si cimenta anche con un altro linguaggio a fianco, penso che costui debba agire con maestria anche con quel linguaggio, al punto tale che la sua seconda espressione sia onnicomprensiva e sufficiente a se stessa. Faccio solo un esempio: se un filosofo decidesse di scrivere - e non, quindi, mettiamo il caso, di restare mero pensatore-oratore - sarebbe bello che diventasse anche uno scrittore provetto, cioè sapesse gestire la scrittura con spessore di lavoratore della parola scritta (evitando l'imperante sciattezza scrittoria). Quel linguaggio diverrebbe perciò autonomo, quasi separato dal pensiero, con pregi di significante.
Questo per dire anche: la musica "dice" tutto ciò che deve dire senza bisogno di sostegni a lato; e tutto ciò che ad essa si affianchi - titolo, testo musicato, autoriflessione, intervista, critica in prefazione e a posteriori ecc. - potrebbe essere pregevole e stimolante, ma è altro, è autonomo ed è un esterno.
Ma... tanto per non lasciar tranquilli e per ripristinare il fascino del paradosso, dico anche, per far da contraltare al mio secco enunciato "la musica basta a se stessa," dico che mi interessa la musica (come qualsiasi altra forma d'arte) che sia portatrice di un quid di oltranza che mi faccia dire: la musica di per sé non mi interessa.
Ergo, io non lavoro mai in subordine ai concetti (e, in un mordi-e-fuggi che qui c'entra poco, aggiungo anche che non amo l'arte concettuale). E allora giustamente qualcuno potrebbe chiedersi quale sia il ruolo dei miei testi introduttivi alle musiche. Sicuramente non è un interpretare; anzi, a volte - penso ad esempio al testo su Neuma q - il pezzo introduttivo sbandiera estrinsecamente un'indole depistante e sfuggente, pur essendo tutto preciso dal punto di vista del senso e della costruzione. Cosa sono dunque quei contributi testuali sommati alla composizione musicale? Sono complementi di artisticità, lavorano attorno, ammantano, con metafore, paralleli figurati e stimoli poetici, ma senza voler interpretare la musica né tanto meno anteporre a monte concetti che la musica debba poi saper edificare a valle; sono tentativi, semmai, di far aprire ulteriormente i pori percettivi dell'ascoltatore, o, meglio ancora, di stordirli, di renderli arrendevoli, schiusi all'epifania sonica.
AAJ: Nelle note agli String Quartets riporti una lunga citazione tratta da Logica del senso di Gilles Deleuze. Hai poi dedicato il tuo lavoro Dimensioni (1999) a Jacques Lacan e Francis Bacon. Quanto è importante la prospettiva di ricerca filosofica per il tuo lavoro?
O.C.: Per risponderti bene, comincio spostandomi un poco di campo, per rientrare velocemente nel binario. Il mio interesse per l'inconscio è sostanziale. Il mio approccio è opposto a quello surreale: non sono attratto dalla bizzarria in arte, così come non lo sono dal tentativo di trascrizione, in linguaggio lineare, del sogno e di ciò che presumiamo essere il "sommerso". Il discorso si farebbe lungo e complesso, mi fermo qui.
Per esempio amo la poesia oscura, ma precisa e (presumibilmente) voce diretta dell'inconscio, e facente brillare di magia la realtà, e amo anche la poesia a-reale e quella visionaria; ma non amo la poesia surrealista né quella modernamente surreale e avanguardisticamente non-sense (come nemmeno quella del quotidiano e quella ideologizzata). Più o meno la stessa cosa valga per l'arte, e anche - seppur ora, qui, non sia possibile scriverne - per la musica.
I miei densi studi di certa psicoanalisi e filosofia del Novecento, Lacan, Deleuze, Derrida, Matte Blanco ecc., che segue anche ad Al di là del principio di piacere dell'antesignano, hanno corroborato la mia inclinazione a viaggiare con l'inconscio e a godere delle filosofiche disquisizioni contemporanee prettamente su quello e sul linguaggio ma anche su altro.
"Dimensioni" è un brano che mi dà i brividi. C'è una voce bianca, poi la voce di uno dei due soggetti che tu hai nominato nella domanda, e c'è dell'altro. E, astrattamente, c'è anche il mio rimando a quel match fra due menti che arbitrariamente e idealmente faccio lì confluire. Il rimando per esempio alla potente qualità di Bacon di far sentire quel taglio, quello spacco, quella distorsione sul sipario della realtà, che conduce verso un oltre. E non sto parlando necessariamente in termini metafisici.
AAJ: Atto contiene una musica bellissima creata a partire da oggetti non musicali. Senza manipolazione elettronica. Hai voglia di raccontare come nasce e come l'hai registrato?
O.C.: Cercherò di dire qualcosa, anche se in merito alle mie suggestioni devo rimandare, per non ripetermi, all'intervista per Atto. Rimando anche all'altra intervista per Oltreorme fattami da Simon Reynell titolare dell'etichetta inglese Another Timbre, che ha pubblicato Atto e da poco Oltreorme. Colgo l'occasione per dire che ho lavorato bene con Reynell, il quale ha creato un contesto discografico coerente, rigoroso e selettivo, e lo ha fatto con passione (zero lamenti e militanza sulla propria pelle) e poi è rispettoso del ruolo dell'artista. La sua etichetta in pochi anni ha acquisito il ruolo di una delle più accreditate nel genere. Che a mio avviso è uno dei sentieri del nostro futuro musicale.
Il tentativo di creazione di un'opera musicale conchiusa pur a partire da elementi faticosi da domare quali gli oggetti d'uso quotidiano, cioè "strumenti non-strumenti" i cui esiti sono "suoni acustici ma senza analogia con suoni acustici riconoscibili" (a differenza di quanto avviene con la musique concrète e il field recording), non sarebbe di per sé un'avventura - in quanto la creazione per me è sempre straordinariamente speciale e affascinante quanto faticosa indipendentemente dal mezzo impiegato - sennonché il rituale, più da alchimista-stregone che da compositore-performer, dello spargere in una hall i più disparati oggetti, e poi del perdersi come soggetto nel maneggiarli, e poi far scaturire da essi una voce mai esplicitata, può aver fatto la differenza.
AAJ: Proprio perché hai scelto la non manipolazione elettronica dei suoni volevo sapere: qual è il tuo rapporto con l'elettronica e come intendi il suono? In particolare penso al tuo lavoro elettronico per Die Schachtel Neuma q.
O.C.: Non c'è gerarchia, nella mia fucina, riguardo gli strumenti da impiegare, tutt'al più vengono a galla, di volta in volta, differenti necessità interiori o estetiche, e - rarissimamente nel mio caso - l'adesione a richieste.
L'elettronica di ricerca ritengo sia per eccellenza lo "strumento musicale nuovo" dell'area cólta del XX secolo; geniale quando si è affiancato con onestà e morigeratezza alla compagine dei nostri strumenti in uso da secoli. Guardo ancora alla "classicità" di tale esperienza, cioè vedo in alcune delle early sperimentazioni degli anni '60 del secolo scorso un momento di buon gusto. Anzi, convertendo l'interesse in termini di spessore creativo individuale, traduco in termini di ammirazione circostanziata, anche per chi poi andò in là con i decenni.
Anche se per ora la maggior parte delle mie composizioni elettroacustiche resta ignota (sebbene attorno ad esse ruotino episodi graziosi o ragguardevoli, per esempio su Absum del 1999 la tesi di due studenti di conservatorio per il diploma nel Corso di Analisi della Musica Elettroacustica nel 2005), ignota in quanto non ancora pubblicata (ho 4 raccolte complete già sui master, di cui una sola pubblicata su disco), posso dire di essermici dedicato tanto, sin dalla metà degli anni '80, e che trovo l'elettroacustica uno strumento e un suono adeguato ad assecondare la mia necessità di intervenire sulla realtà.
Nell'alterazione e nell'alterità che tale strumento promette, vedo la virtualità del raggiungimento di una visione estetica che provenga dalle distorsioni della percezione di partenza, al fine di far passare un altro livello di conoscenza.
AAJ: Molte delle cover dei tuoi CD sono realizzate da te. Quanto sono relazionate con la musica che componi?
O.C.: La maggior parte delle copertine dei dischi in circolazione è kitsch, credo che ciò sia innegabile, come innegabile la mia esigenza estetica dalla A alla Zeta in faccende di arte nelle quali sono ingaggiato. Ho sempre cercato di tenere sotto controllo più cose mi fosse possibile nella realizzazione dei miei progetti (per dire: dalla precisione dell'esecuzione degli incastri contrappuntistici sino al corpo del carattere di stampa del booklet). Perlomeno, ho sempre cercato di fare del mio meglio, contro mille ostacoli. Ad ogni modo sono io, in tutti e 7 i miei dischi, il produttore (dedito alle scelte iniziali, all'organizzazione, alle decisioni tecniche e alla ricerca del discografico). Non è sfoggio né esuberanza né eclettismo ma mera esigenza pragmatica pro buon esito di un prodotto d'autore che stia in piedi. Si veda per esempio il caso estremo di Oltreorme, ove sono l'unico soggetto all'opera: ho designato i "non-strumenti," ho composto, "suonato," montato, sono stato ingegnere (ma anche decostruttore) del suono, ho utilizzato macchine di registrazione mie, ambiente mio, ho fatto ed elaborato le due foto per la copertina e per l'interno della confezione del disco, e... al rash finale potrei pure buttarmi via tranquillamente con essa (scherzo!).
Tornando specificamente alle copertine: ho sempre discusso o combattuto per avere copertine che non infingessero il senso del mio percorso, a volte ho semplicemente scelto o rifiutato le copertine. Dal tempo della copertina del CD RAI Trade (per la quale cercai quell'opera di Fausto Melotti, contattai gli eredi e il museo proprietario di quell'opera e ottenni i permessi scritti per poterla utilizzare) sino alla semplice ma non da darsi per scontata delicatezza dei colori della copertina delle edizioni Col legno di Vienna, ho sempre cercato di scongiurare il debordare di gusto anche sotto quell'aspetto.
AAJ: La parola (poesia e prosa poetica) mi pare una dimensione altrettanto fondamentale del tuo essere e ricercare. Mi pare soprattutto nella fase iniziale della tua carriera sia stata al centro anche del tuo fare musica.
O.C.: Ho iniziato a studiare musica da ragazzino, la letteratura è arrivata in un secondo momento ma posso dire che la poesia è stata un'esperienza capitale. Parlo al passato perché ho completato il mio apporto nel 2003. Avevo anche smesso di militare su riviste di ricerca. Il fatto che io abbia smesso di scrivere non significa però che io non sia più un poeta; direi anzi che nell'operare quella scelta massima, nel divenire silenti per quella via, potrebbe esserci del poetico. Mi scoprì, e mi portò ad esordire su un almanacco di Crocetti editore, Stefano Agosti, che rappresentava per me il lettore ideale, per via delle sue raffinate analisi sugli autori francesi che amavo, Rimbaud, Mallarmé, Char ecc. Quindi Agosti, Contini ecc.; per l'arte Longhi ecc.; alcuni per la musica... Ancora guardo alla critica dei maestri.
La grande poesia è meravigliosa.
AAJ: Il tuo libro di poesie Appuntamento è accompagnato da interventi pittorici di Marco Gastini. Come è nato il vostro incontro?
O.C.: Coup d'idée, cioè il marchio di quel libro, era intenzionato a ri-pubblicare le poesie di Appuntamento (1994-97) in versione libro d'arte fatto a mano da rinomata stamperia. Il titolare di quell'iniziativa pensò poi di unire alle parole gli interventi di un pittore. Riflettemmo di concerto, con anche l'art designer di quel libro, su quale potesse essere l'artista adatto da affiancare. Marco Gastini, per via della sottile natura della sua più recente produzione, ci sembrò l'artista adatto. Egli lesse il libro, gli piacque e ci lavorò su; con i suoi tipici "segni" pagina per pagina e con una bella acquaforte. Presentammo quel libro alla Galleria d'Arte Moderna di Torino.
AAJ: Gamete, Quale leggerezza, Scomparsa, Prematuri umori, L'abbaglio del volatile e Manto sono tutte opere non pubblicate (da case editrici). Sul tuo sito ci sono delle immagini che ritraggono copertine (fatte da?) di Due punte edizioni. Volevo sapere di più di queste raccolte.
O.C.: Due Punte è un mio marchio, a volte preprint, col quale fra l'altro avevo pubblicato il CD Gemina in 500 copie. Le raccolte cui ti riferisci sono libri fatti a mano da me, copertine incluse, in tre copie. Ho voluto raccogliere così la mia opera poetica conclusa. Diciamo, per ora sono oggetti privati in attesa di pubblicazione presso (altro) editore. Per lo più si tratta di opere che nessuno conosce, se non per alcuni estratti pubblicati in riviste letterarie negli anni '90, e delle quali non si può sapere/dire se siano pochezze o capolavori. Qualcosa di simile anche con la musica. Sicuramente, peccato! Anzi, forse.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.