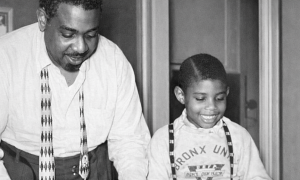Home » Articoli » Interview » Intervista a Ciro Longobardi e Agostino Di Scipio su "El...
Intervista a Ciro Longobardi e Agostino Di Scipio su "Electronic Music for Piano" di John Cage
All About Jazz: Dal libretto si evince che l'idea di suonare Electronic Music for Piano è stata di Ciro. Partirei da qui.
Ciro Longobardi: La collaborazione tra me e Agostino dura ormai da molti anni. Esiste un repertorio piuttosto vasto per pianoforte ed elettronica, ma principalmente con supporto preregistrato - una volta si chiamava nastro magnetico. Più rari, e probabilmente più stimolanti, sono i brani con elettronica dal vivo. Nel cercarne per il nostro duo mi sono imbattuto in questo pezzo di Cage, davvero poco eseguito e addirittura sconosciuto ai più. Ho ordinato lo spartito e l'ho subito proposto ad Agostino perché mi è sembrato che il suo lavoro ecosistemico sui processi di elaborazione sonora in tempo reale si adattasse in maniera perfetta alle indicazioni cageane. Per quanto riguarda specificamente la registrazione, essa è il risultato di un lavoro di sottrazione: pensavamo inizialmente a un cofanetto che comprendesse gran parte del nostro repertorio, ma le enormi difficoltà che ciò comportava ci hanno indirizzato via via verso un'opzione più snella e, se si vuole, più realistica. Ecco quindi l'idea di dedicare un intero disco a Electronic Music for Piano.
AAJ: Poi, come dice Agostino nelle note di copertina, "ci son voluti tempo e cura per escogitare e verificare le strategie di un'interpretazione non arbitraria che fosse anche una lettura personale, musicalmente e concettualmente convincente". Cosa ha fatto la differenza nei vostri ragionamenti?
C.L.: Scegliere un brano per poi trovarsi davanti a uno spartito che è un foglio/memo di appunti - una sorta di largo "post-it" indirizzato a se stesso e all'amico pianista David Tudor contenente indicazioni sparse, generiche, di non facile lettura dal punto di vista calligrafico, con collegamenti concettuali interni tutti da definire - è una assoluta sorpresa anche per chi è avvezzo a esperienze di lettura estreme, come me, Agostino e chiunque si occupi di nuova musica. Fortunatamente balzano subito all'occhio alcune inequivocabili indicazioni. Innanzitutto il materiale pianistico di base da usare, Music for Piano 4-84, una serie di brani preesistenti composti utilizzando le imperfezioni della carta. E poi il concetto di feedback, che è stato assolutamente centrale e ha sicuramente plasmato l'intera realizzazione. Di fatto, queste indicazioni, questi punti di partenza nel ragionamento, hanno definito l'ambito di lavoro fin dall'inizio.
Agostino Di Scipio: Nell'interpretare Cage è sempre questione di un delicato equilibrio fra adesione allo spirito con cui ti propone di agire e libertà personale nel quadro di quelle possibilità di azione. Cage spinge il suo interprete in questa situazione contraddittoria che deve sciogliere da sé. Con Electronic Music for Piano si tratta in fondo di inventarsi una prassi esecutiva, e per me questo voleva dire configurare e verificare una catena elettroacustica ibrida (elementi meccanici, elettroacustici, numerici) e verificarne alcune tra le infinite possibilità. Le indicazioni nel manoscritto di Cage sono del tutto generiche, ma che poi in definitiva ti vincolano fortemente. In generale, in Cage l'"opera aperta," come si diceva a quel tempo, ti spinge a fare un lavoro sui vincoli necessari, su ciò che chiude, che contorna. L'anarchia di Cage non è mai un lavoro senza regole, ma un lavoro sul far funzionare le cose in assenza di regole pre-esistenti, oppure scoprendo che quelle che lo stesso Cage ti fornisce sono insufficienti. Insomma una permanente e mai ultimata né ultimabile ricerca di regole minime. Naturalmente è una questione (assai novecentesca) che si è presentata in varie forme. Posso segnalare l'esempio di Xenakis che, proprio negli stessi anni di Cage, era alla ricerca di un "minimo di regole" necessario e sufficiente alla composizione. Dal diverso modo di articolare la questione, nascevano due mondi sonori diversi, quasi antitetici...
AAJ: Negli appunti-partitura Cage ha annotato una serie di parole. Vorrei che ciascuno di voi ne desse una sua spiegazione alla luce, eventualmente, della sua personale interpretazione.
- feedback
- changing sounds
- transformations
- variation
- repetition
C.L.: Come dicevo, fondamentale è stata la parola feedback, intesa semplicisticamente come interazione tra strumento ed elettronica, oppure, in maniera più appropriata, come creazione di un sistema strumento/elettronica capace di automodificarsi in base ai risultati sonori prodotti volta per volta. Detto questo, anche parole più usuali in ambito di lavoro elettronico, e perfino concetti di "ordinaria amministrazione" musicale come variazione e ripetizione acquistano un significato del tutto nuovo.
A.D.S.: Nella nostra esecuzione, il funzionamento del processo esecutivo è garantito da uno stato quasi permanente di feedback, cioè di retroazione positiva e/o negativa: ogni causa è effetto di cause precedenti, ogni effetto potenzialmente diventa causa di effetti ulteriori. Nel suono (una specie di effetto Larsen attraverso le parti di legno e di metallo del pianoforte), come nell'articolazione del gesto musicale. Ogni intervento pianistico ha conseguenze di breve e lungo termine, spesso imprevedibili, e queste conseguenze creano il contesto che suggerisce il momento e il modo di ulteriori interventi. Changing sounds e transformations per me significa che i meccanismi di retroazione sono giocati non solo per produrre suono, ma anche appunto per sviluppare gli eventi sonori nel tempo e per trasformare il suono del pianoforte, sempre però in un orizzonte temporale che non si esaurisce nella simultaneità. Variation e repetition sono classiche devices compositive: qui vuol dire la possibilità di tornare su alcune, assai poche, configurazioni della catena elettroacustica, con esiti sempre diversi, perché sensibili al diverso contesto. Di particolare importanza è, per me, anche l'indicazione direct contact of microphone with each vibrating element, in base alla quale ho fatto un certo lavoro sul corpo materiale del pianoforte, su questo spazio semichiuso, una piccola nicchia nell'ambiente più ampio della stanza.
AAJ: Il materiale pianistico di base di questa composizione è costituito dalla serie di pezzi Music for Piano 4-84. Come avete lavorato (o in cosa vi siete eventualmente discostati da) sul metodo di composizione di Cage di quegli anni e questi pezzi?
C.L.: Parliamo degli anni compresi tra il 1953 ed il 1956. Cage era alla ricerca di una fast procedure compositiva che potesse integrare la consultazione dell'I Ching o, in alcuni casi, addirittura sostituirla. Come i pittori lavorano lentamente con la pittura a olio e velocemente con gli acquerelli, Cage era alla ricerca della sua tecnica ad acquerello e la trovò nella trascrizione in notazione musicale delle imperfezioni presenti sui fogli di carta: "I looked at my paper, and I found my "water colors": suddenly I saw that the music, all the music, was already there" [in: Steven Johnson, The New York Schools of Music and Visual Arts, Routledge, 2002]. In questi pezzi durate, tempi e dinamiche sono dichiaratamente liberi, ma c'è di più. In un articolo del 1957 [To Describe the Process of Composition Used in Music for Piano 21-52] Cage pone una corrispondenza tra spazio/pagina e tempo/durata, cioè la disposizione dei suoni nel tempo dovrebbe riprodurre la disposizione delle altezze sulla pagina, ma poi afferma che il tempo può essere interpretato "as moving, not only constantly, but also faster or slower". E ancora, in Electronic Music for Piano c'è un'altra interessante annotazione: without measurement of time (no observation of notation). Se aggiungiamo la dichiarata mancanza di più specifiche indicazioni riguardo ai suoni stoppati e pizzicati, risulta chiaro che Cage concede all'interprete una grande libertà di azione. Detto ciò, possiamo tranquillamente affermare di esserci presi tutta la libertà implicita nelle indicazioni cageane, ferma restando la precisione nell'esecuzione delle altezze indicate, naturalmente.
AAJ: Nella serie dei pezzi di Music for Piano, solo Music for Piano 85 prevede "elettronica con feedback e glissando". Questo pezzo è stato in qualche modo un punto di riferimento anche se non si tratta di un vero e proprio pezzo di Electronic music?
C.L.: No, non l'abbiamo preso in considerazione. Partendo dall'idea di realizzare una versione di Electronic Music for Piano ampia, che potesse sostenere la durata di un intero concerto, abbiamo pensato che un piccolo brano di due pagine, con indicazioni ugualmente criptiche, non ci sarebbe stato d'aiuto.
AAJ: Mi pare evidente che il valore aggiunto di Electronic Music for piano sia in tutto e per tutto l'elettronica. Le scelte di Agostino, "disporre di un reticolo di trasformazioni sonore tra loro interagenti (usando meccanismi di amplificazione e controllo del feedback elettroacustico secondo principi adattivi e di auto-regolazione) e considerare il pianoforte come un nodo particolarmente attivo in quel reticolo" mi sembrano marcare profondamente la vostra interpretazione e dare un fortissimo senso "elettro-acustico" ad una composizione che, forse, all'inizio prevedeva una più semplice aggiunta dell'elettronica ad un pezzo per piano.
A.D.S.: Mi fa piacere quello che dici, però non sono d'accordo su quest'ultima annotazione. Electronic Music for Piano nasceva per un concerto di David Tudor. Ora, tutto il lavoro di Tudor con l'elettronica ha senso fortemente anti-naturalistico, dove l'elettronica non è proprio per nulla una "aggiunta," un "effetto" aggiunto al suono naturale dello strumento, ma un intero nuovo potenziale di musica, di articolazione sonora nel tempo. Cage ovviamente conosceva bene Tudor, ed è improbabile che pensasse a una "semplice aggiunta". Inoltre, è vero che nella nostra interpretazione il ruolo dell'elettronica è decisivo, però faccio notare che non abbiamo affatto nascosto né violentato il materiale pianistico originale, che anzi è perfettamente in evidenza e per lunghi tratti procede anche senza elettronica. Non manca un solo suono delle pagine di Music for Piano che abbiamo selezionato.
Secondo me Electronic Music for Piano non è un lavoro per due mezzi strumentali distinti, "pianoforte" da una parte ed "elettronica" dall'altra: si tratta di una sorta di meta-strumento, di un processo fortemente integrato. Il materiale di Music for Piano ha una sua autonomia, ovviamente, ma è talmente reinterpretabile da potersi in qualche modo eteronomizzare in un rapporto paritario con l'elettronica. Gli interventi elettronici dipendono dal gesto pianistico, e questo, a sua volta, dipende dagli esiti dell'elettronica. Già il titolo Electronic Music for Piano lo dice: il pianista suona musica elettronica, non suona il pianoforte e ci aggiunge dell'elettronica. Lo strumento diventa l'interfaccia per agire dentro un processo di generazione e trasformazione del suono che lo trascende.
AAJ: Oltre ai suoni del piano avete voluto lasciare largo spazio "alle imperfezioni del silenzio in cui la musica è suonata". Trovo significativo quel che scrive Agostino a riguardo: "il pianoforte non è soltanto fonte di suono, ma anche luogo di transizione, di trasferimento, velo che separa e unisce gli estremi di una costruzione chiusa su sé stessa (feedback, appunto) ma aperta all'ambiente e al rumore circostante". Inevitabilmente vi chiederei una riflessione su questo...
A.D.S.: Beh, tornerei a quello che accennavo sopra. Mi pare che questo pezzo in fondo estenda il concetto di "pianoforte preparato". Una volta "preparato" il pianoforte è un nuovo strumento, e la musica che Cage ha scritto per quello strumento, da Bacchanale in poi, non è "per pianoforte con aggiunta di preparazioni," ma appunto "per pianoforte preparato". Nella nostra esecuzione di Electronic Music for Piano, la "preparazione" assume la struttura di un insieme di processi di elaborazione del suono perfettamente deterministico nel suo funzionamento ma estremamente sensibile alle sfumature di suono, alle condizioni dell'ambiente acustico dentro il corpo del pianoforte e fuori di esso, al punto da aprire, nell'evoluzione del processo, un certo margine di indeterminazione.
AAJ: A questo punto penso sia importante spiegare in che senso Electronic Music for Piano è un pezzo "indeterminato". O se volete quale sia il senso di indeterminatezza e alea che ciascuno ha dato/lasciato a questa composizione.
C.L.: Cage parlerebbe di "...composition which is indeterminate with respect to its performance" [Composition as Process. Indeterminacy, 1958]. In questo interessante articolo egli analizza diversi esempi, ma anche alcuni non-esempi. Tra questi, con spirito apparentemente provocatorio, elenca la sua Music of Changes, in cui, dice, il ruolo dell'interprete è paragonabile a quello di un appaltatore che, seguendo il progetto di un architetto, costruisce un edificio. In altre parole, l'aspetto aleatorio si è esaurito a monte, all'atto della composizione, con la creazione di tabelle e procedure compositive governate attraverso i sorteggi dell'I Ching. Il risultato è una partitura/progetto determinata in maniera talmente precisa e dettagliata che all'interprete/appaltatore non resta altro che metterla in opera con la massima accuratezza possibile.
Invece, come esempi a conferma cita opere di altri autori, tra cui Klavierstück XI di Karlheinz Stockhausen e Intersection 3 di Morton Feldman. In questi casi l'interprete può assolvere al suo compito di provvedere in maniera creativa ad uno o più aspetti indeterminati della composizione in molti modi diversi. Cito sintetizzando: in maniera non coscientemente organizzata (e quindi non soggetta ad analisi); o in maniera arbitraria, seguendo i dettami del proprio ego; o più o meno inconsapevolmente, seguendo i dettami del proprio subconscio, come nella scrittura automatica; o seguendo l'inconscio collettivo della psicanalisi junghiana; o seguendo il sonno profondo della pratica mentale indiana; o attraverso "chance operations". Cage elenca ulteriori possibilità, con un dettaglio che non è possibile riportare qui, ma è chiaro che 1) non si vede perché queste opzioni non debbano essere applicate anche alle sue composizioni "indeterminate" 2) che le operazioni di sorteggio sono soltanto una delle varie possibilità, e che esse sono obbligatorie soltanto dove espressamente prescritte. Tutto ciò per confermare che non abbiamo usato sorteggi vari - da nessuna parte è scritto che per scegliere dei brani da Music for Piano bisogna necessariamente effettuare un sorteggio - essendo il sistema messo a punto da Agostino già settato secondo parametri casuali rispetto al materiale pianistico di base. Inoltre, non posso davvero escludere che in certe scelte abbiamo seguito i dettami del nostro ego o del nostro subconscio... insomma, cageani sì, ma non più cageani di Cage!
AAJ: Che ruolo ha il silenzio in questa composizione?
A.D.S.: Il silenzio, il silenzio... è... la condizione sonora fondamentale nella quale e sulla quale interveniamo, come musicisti, e questo intervenire causa delle alterazioni di quella condizione, e il modo di alterare e tornare a quella condizione di silenzio (che non è assenza di suono ma presenza di suono rimosso) è musica. Magari un giorno parleremo del mio Studio sul rumore di fondo...
AAJ: La composizione non prevede che il pianoforte sia preparato. Tuttavia a suo modo lo è, se si segue quanto scritto da Agostino: "lo svolgimento dei processi di elaborazione è costantemente dipendente dal gesto pianistico, così come il gesto pianistico è condizionato dall'esito di quegli stessi processi. Si pensi ad un'estensione del pianoforte preparato...Ma si pensi, soprattutto, ad un pianoforte tanto preparato da diventare fattore non solo di straniamento timbrico, ma di articolazione (anche ripetizione e variazione) nel tempo". Volevo una vostra opinione a riguardo perché penso sia stato un argomento oggetto di discussione.
A.D.S.: Se ricordo bene, non ne abbiamo parlato molto. Personalmente me ne sono reso conto nel corso del lavoro, poco alla volta, non tanto quando mi sono ritrovato dentro il pianoforte a posizionare dischi piezoelettrici e altoparlanti, ma quando era ormai chiaro che l'intera configurazione meccanica-elettroacustica-numerica produceva risultati materici e formali che ciascuna delle componenti, presa in sé, era inadatta a produrre. È caratteristico di una prospettiva "ecosistemica" alla composizione e alla performance vedere emergere proprietà di timbro e di articolazione musicale che le singole componenti non possono conseguire. Ed è altrettanto caratteristico che le parti coinvolte devono ciascuna a suo modo limitare la propria azione per favorire l'interazione costruttiva con le altre parti. Il tutto è più della somma delle parti, ma anche molto meno. Il pianoforte, da solo, può fare cose che il nostro meta-strumento non può fare, e lo stesso vale per le componenti elettroacustiche. Ma né il pianoforte né l'elettronica possono fare, separatamente, quello che accade complessivamente nel nostro Electronic Music for Piano. Ci dev'essere equilibrio tra il margine di manovra individuale e il senso della responsabilità che si ha, con la propria azione, rispetto alle altre componenti in gioco.
AAJ: Dal punto di vista pianistico avete scelto di costruire sette sequenze o movimenti, ciascuno con specifiche modalità esecutive. Anche qui vi chiederei una spiegazione:
1) Pianissimo-con pedale;
2) Fortissimo-risonante-con-echi;
3) Pianissimo-staccato;
4) Forte-frammentato-gestuale;
5) Libero;
6) Pianissimo-con-rumori-pedale-ed-armonici;
7) Coda-libero.
C.L.: Abbiamo seguito l'indicazione secondo cui dinamiche e durate sono libere, e questa sequenza rientra sicuramente tra le centinaia di combinazioni possibili. D'altra parte il materiale cageano è piuttosto omogeneo e la differenziazione è funzionale ad ottenere una certa varietà.
AAJ: La scelta di non usare mappe stellari è coerente alla vostra interpretazione, in particolare per l'elettronica. Vi chiederei maggiori dettagli su questa scelta.
A.D.S.: Beh, intanto nello schizzo manoscritto di Cage c'è scritto: "come se si utilizzasse un disegno dei controlli disponibili con, sovrapposta, la trascrizione di una mappa stellare...". Il riferimento è a lavori in cui l'indeterminazione della partitura si ottiene con l'applicazione di carte astronomiche, cioè con un procedimento del tutto arbitrario a livello musicale (ma da applicare cageanamente con grande rigore!). Ora, nello schizzo manoscritto di Electronic Music for Piano, l'ipotesi di usare carte astronomiche si riferisce ai controlli elettronici disponibili: però si tratta appunto di un ipotesi, di un "come se...". Lo schizzo fu preparato per un'esecuzione che avrebbe avuto luogo dopo poche ore (un paio di giorni dopo, mi pare): Cage insomma suggerisce a Tudor di agire sui controlli senza regolarità apparente, "come se" li avesse determinati ricorrendo ad una mappa stellare, ma non ne prescrive l'effettiva applicazione. Nel nostro caso, poi, i processi elettronici che ho messo a punto hanno già un loro grado di imprevedibilità, essendo ipersensibili a un gran numero di fattori in gioco durante l'esecuzione. Pensare di guidare questi processi con carte astronomiche sarebbe stato, come dice Ciro, avere un atteggiamento inutilmente "più cageano di Cage"...
AAJ: Questa è, che io sappia, la terza incisione di Electronic Music for Piano. La prima è quella di Steffen Schleiermacher, il quale, tra l'altro, nelle note di copertina ha dato anche indicazioni sul metodo usato per la sua incisione ("Description of the method of Interpretation Employed in Music for Piano 1-85 and Electronic Music for Piano" [MDG]). Volevo sapere cosa ne pensate di questa incisione, se vi siete consultati a riguardo, cosa eventualmente (non) vi ha convinto.
C.L.: Sì, conosciamo quella registrazione. Piuttosto interessante da un punto di vista timbrico e per certi suoni ambientali presenti, ma mi pare del tutto assente il concetto di feedback.
AAJ: La seconda incisione di Electronic Music for Piano è quella di John Tilbury (pianoforte) e Sebastian Lexer (electronics) [Another timbre at10]. Cosa ne pensate?
A.D.S.: Da un certo punto di vista sortisce esiti significativi, in senso materico, timbrico, e anche come nell'andamento complessivo, molto aneddotico e discontinuo, con scarti improvvisi. Però ci è anche sembrata un'esecuzione "più cageana di Cage," appunto, e inoltre praticamente non c'è traccia alcuna di Music for Piano... Suona molto come una realizzazione interamente "di studio," frutto di montaggio, e non eseguibile in concerto.
AAJ: Alla prossima Biennale realizzerete questo pezzo live. Quali, se eventualmente sono previste, le differenze rispetto alla versione che avete inciso?
C.L.: A Bologna (Angelica) abbiamo realizzato la prima esecuzione assoluta parziale. A Venezia realizzeremo la prima esecuzione assoluta integrale. Sarà quindi molto vicina alla versione del CD, anche se ho intenzione di allargare la tavolozza timbrica per quanto riguarda i rumori interni ed esterni allo strumento.
A.D.S.: A parte questo, direi che non sono previste differenze, per il semplice fatto che non possono che esserci differenze, talvolta molto profonde, a ogni esecuzione, pur partendo sempre dalla stessa economia di mezzi.
AAJ: Chiederei a ciascuno una riflessione sul senso ultimo della figura di Cage nella musica contemporanea.
C.L.: Cage è una delle figure più note e celebrate nel campo delle arti contemporanee. Allo stesso tempo è tra le più soggette a luoghi comuni e semplificazioni. Quante volte abbiamo sentito nominare i concetti di "alea," "indeterminazione," tutto ridotto a un'espressione uniformante, come se il suo vastissimo catalogo possa essere univocamente ridotto a poche parole identificative. Ma abbiamo visto che due composizioni tecnicamente "aleatorie" come Music for Piano e Music of Changes sono diversissime tra di loro. Per non parlare di opere più tarde, come Freeman Etudes e Etudes Australes, in cui entra in gioco l'uso costante di carte astronomiche per scrivere brani dal virtuosismo estremo. E i pezzi precedenti la svolta zen? Ancora due parole identificative: pianoforte preparato e percussioni. Ma si dimentica, tanto per citare un esempio, che quei brani sono caratterizzati da rigorosissime strutture ritmico-metriche, spesso organizzate in tabelle, molto simili alle tabelle di parametri che Cage riempirà usando i sorteggi dell'I Ching, segnando quindi una continuità tra i procedimenti pre e post-svolta zen. Insomma, io credo che aggirare certe semplificazioni, approfondire alcune importanti articolazioni nell'opera di Cage possa solo rendere noi "fans" più consapevoli della sua reale importanza... e spuntare le armi ai non pochi detrattori.
A.D.S.: Mmmhh... non so, non cercherei un "senso ultimo"... sarebbe un po' come chiudersi in gabbia per conoscere i confini del mondo... Cage è un pezzo di storia della musica - ma non nel senso della storiografia musicale, con date, nomi, titoli, ecc., piuttosto nel senso della storia dell'esperienza della percezione e dell'intelligenza creativa. A me interessa molto, in tutta la sua produzione, il rapporto mezzi-fini (cioè: la tecnologia), la dialettica di disciplina e anarchia. Reputo di grande importanza storica il momento dell'esperienza nella stanza anecoica nel 1951 (ma la data è incerta), con ciò che ne è conseguito nella sua produzione, il superamento del concetto di arte come "rappresentazione," ma come lavoro sulla presenza, che implica un ripensamento anti-metafisico dell'esperienza percettiva e creativa.
C'è una vulgata del lavoro di Cage che gli attribuisce categorie filosofiche e artistiche estetizzanti, l'immagine del provocatore post-dadaista (vicinanza a Duchamp, poi a Fluxus), quella del profeta di una sorta di "metafisica del silenzio," e altri luoghi comuni... C'è anche chi dice: la musica di Cage è musica di buona qualità e basta, indipendentemente dal contenuto concettuale e operativo; naturalmente questa posizione poi finisce per accogliere certe cose di Cage e per rifiutarne altre (farebbe certamente a meno di Electronic Music for Piano...). Per me Cage è l'ideatore di strumenti di consapevolezza, di percezione delle condizioni umane, molto umane, molto materiali e finite, dell'agire umano. Ed è ormai la nostra "tradizione" - non è più questione di accettarlo o rifiutarlo, è questione di capire che è una parte delle nostre capacità di pensare in musica, una parte che poi in ciascuno di noi, oggi, ha un futuro diverso.
Foto di Kai Bienart Berlin (le prime due di Di Scipio), Alessandro Leone (la prima di Longobardi), Claudio Casanova (la seconda di Longobardi), Paolo Rotili (la foto dal concerto di Di Scipio/Longobardi), Fabio Falcioni (l'ultima di Longobardi).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.