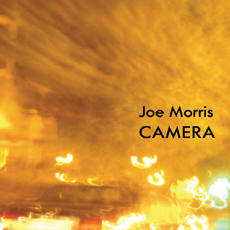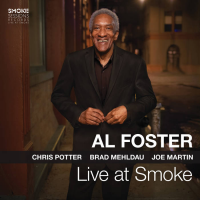Home » Articoli » Interview » Il jazz è un gioco capace di trasformare l’orrore del mo...
Il jazz è un gioco capace di trasformare l’orrore del mondo in un sorriso - Conversazione con Claudio Cojaniz
All About Jazz Italia: Questo che sta finendo è stato per te un anno particolarmente prolifico, che si chiude con l'uscita di Howl, splendido disco della tua Not In Our Name Orchestra (N.I.O.N.). Potresti dirci come nasce e come hai pensato questo progetto?
C.C.: La N.I.O.N. è un sogno che avevo fin da ragazzo. Una realtà sognata - e questo è importantissimo per un musicista - nella quale per la prima volta lavoro con un organico più ampio del trio o del quartetto. In questa orchestra ho misurato un mio personale metodo di lavoro, che prevede ovviamente conoscenza delle strutture, ma soprattutto concentrazione e apertura totale all'altro, cioè suonare ma anche lasciarsi suonare. In quest'orchestra ho voluto privilegiare molto l'aspetto ritmico, danzante, ma anche quello "innico," cioè l'inno inteso come canto di un'anima profonda, che sia tanto liberatorio, quanto superamento dell'attuale. Infatti, il supporto ideale di quest'orchestra è il suo essere totalmente postmoderna, nonostante il richiamo all'antico - in sostanza al blues e all'Africa - sia stato necessario fin dall'inizio.
AAJ: In che senso intendi il termine "postmoderna"?
C.C.: Nel senso che l'orchestra non fa nessun riferimento alla modernità, ma propone una musica tribale, cioè antica ed eterna, non necessariamente legata a storie né recenti, né paleorecenti: sono gli uomini che la compongono, prima ancora degli strumenti.
In quest'orchestra ho potuto avvalermi di grandi talenti individuali: da Cuong Vu a Francesco Bearzatti, da Giancarlo Schiaffini a Zeno De Rossi, da Danilo Gallo a Romano Tedesco, fino alle "sorprese" Luca Grizzo e Maria Vicentini - violinista, grande spirito klezmer e capacità di volare alto. E l'ho fatto realizzando una musica libera, su strutture semplici. E realizzando, come dicevo, un sogno che avevo fin da giovanissimo.
AAJ: Che riferimento e rapporto c'è tra la tua orchestra e la Liberation Music Orchestra di Charlie Haden? Perché se quest'ultima viene richiamata fin nel nome (Not In Our Name è il titolo dell'ultimo lavoro della L.M.O.), è anche vero che la musica è piuttosto diversa.
C.C.: Musicalmente, infatti, non ci sono molti riferimenti. E anche il nome di fatto non l'ho messo io, ma Giancarlo Velliscig di Euritmica di Udine e Claudio Donà di Caligola di Venezia, cioè coloro che hanno fatto sì che un progetto come questo trovasse le forze per andare avanti. Sono stati loro (non so di preciso chi dei due) ad aver fatto uscire il nome N.I.O.N., che a me peraltro è andato benissimo. Ma, a parte il nome, l'unica cosa che la mia orchestra ha in comune con la Liberation è il senso anche politico del fare musica: la voglia di cambiare il mondo che è propria del jazz! Ma su questo punto direi che se il jazz non vuol cambiare il mondo, non si capisce più cosa stiamo a suonare... Arredamento, come aveva già proposto Erik Satie?
AAJ: Come avete scelto i brani raccolti poi nel disco, visto che nel repertorio dal vivo vi sono anche diversi altri pezzi?
C.C.: Innanzitutto c'erano due pezzi del tutto fondamentali, veri e propri emblemi dell'orchestra stessa: "African Market" e "Howl". Quest'ultimo è pensato come l'urlo dei bambini del mondo, che ci invitano a svegliarci. La scelta degli altri brani è perlopiù legata a questioni stilistiche e di coerenza. Comunque, in generale la selezione dei brani da mettere in un disco ha sempre qualcosa di arbitrario e anche per questo ho scelto abbastanza istintivamente. Vorrei però fare presto un nuovo disco per registrare anche gli altri brani in repertorio.
AAJ: In organico figurano alcuni strumenti atipici per un'orchestra di questo tipo: volevo chiederti se il ruolo che svolgono - che per inciso è fortemente caratterizzante - sia legato alla sola interazione o avevi pensato espressamente a un posto per loro.
C.C.: Gli strumenti meno frequenti in un'orchestra che fanno invece parte della N.I.O.N. sono la fisarmonica e il violino. Ora, in tutto il mio fare musica prevale sempre la persona, l'uomo che sta dietro lo strumento e io non scriverei mai qualcosa che non comprendesse lo stile, le aspettative, l'anima di quella persona. Quando ho messo in piedi la N.I.O.N. avevo in mente un certo suono che riprendesse anche quello dell'etnia che mi è più vicina - quella slava - per cui fisarmonica e violino erano per me una necessità ineludibile. Per questo sono andato a cercarmi musicisti che suonassero questi strumenti e che fossero anche persone adatte al progetto. Così come Francesco Bearzatti è importante per il soul che riesce a esprimere, come Giancarlo Schiaffini lo è per gli aspetti lunari ed estemporanei del suo modo di suonare, come Cuong Vu per il modo limpido di affrontare la tromba, tradizionale ma non alieno al free, così Romano Todesco e Maria Vicentini sono importanti perché gli strumenti che suonano conferiscono un certo colore e un'originalità al sound dell'orchestra, ma soprattutto per richiamare all'Europa dell'est, per ricondurre il jazz anche a quel territorio musicale.
Perché secondo me, dal bop in poi, il jazz e il blues sono stati liberati dal loro essere una musica etnica e si sono trasformati in una musica universale. Ma se il jazz e il blues sono universali - perché trasportano pensiero - allora ognuno adatta al suo cuore questo vocabolario. È un po' quel che accade, ad esempio, all'yiddish, che è un modo di parlare, un tronco di vocaboli e tensioni ideali, che però adegua i suoi rami di volta in volta ai luoghi dove viene a trovarsi e a vivere: l'yiddish tedesco è molto diverso da quello di Belgrado, però la pronuncia è la stessa e si comprendono tra loro. Per il jazz è lo stesso e questa è la sua grandezza: assumere al proprio interno le diversità. Nel mio caso, volevo dare un carattere slavo alla mia musica, che peraltro si richiama anche moltissimo all'Africa. Siamo uomini del XXI secolo e dobbiamo concepire la vita come un tutt'uno, il mondo nella sua interezza.
AAJ: Veniamo all'altro importante progetto che stai portando avanti negli ultimi anni, il duo con Francesco Bearzatti, che ha prodotto anche il bel CD della Caligola (Beat Spirits.
C.C.: Con Francesco la cosa è nata ormai da qualche anno. Che lui sia un musicista straordinario lo si sa e non c'è bisogno di ripeterlo; nel nostro incontro sono nate alcune cose che non ci aspettavamo e che ci hanno spinto a continuare. Abbiamo così fatto vari concerti, abbiamo messo a punto un po' di cose e abbiamo registrato il disco. Ma la cosa non si è per niente fermata lì e il progetto è andato ancora avanti.
In realtà, si tratta di una sorta di "piccola N.I.O.N," nella quale però siamo ovviamente molto più liberi: Francesco di esprimere tutta la sua grande potenza interiore, io di improvvisare sulla tastiera. Però il nostro duo è fondamentalmente un dialogo: molto serrato, molto affascinante, ma per questo anche molto impegnativo, perché si è sempre lì, sul punto della cosa. Spesso è capitato di non fare nemmeno le scalette della serata: si sapeva da dove si partiva e il resto - citazioni, temi inventati, improvvisazione nel dialogo, brani già noti - capitava per strada. E anche quando abbiamo registrato è successa la stessa cosa. Questo è possibile perché abbiamo una bella intesa: ci comprendiamo, camminiamo nello stesso solco, ma diamo risposte molto diverse, e proprio questa è la cosa interessante.
AAJ: Mi sembra che ciò che unisce i due progetti sia l'importanza della forte interazione tra i musicisti, che sovrasta ogni "programmazione" e favorisce la spontaneità della musica offerta all'ascolto.
C.C.: Esatto. Perché in ogni gruppo che ho fondato o con cui lavoro - e persino quando suono da solo! - io chiedo ai musicisti, come dicevo, non solo conoscenza del progetto, ma soprattutto concentrazione e apertura verso gli altri. Il musicista deve spogliarsi prima di suonare, essere il più possibile nudo, per potersi lasciare penetrare dall'altro, perché è l'altro che lo suona. In questo modo succede che tu stesso ti meravigli mentre suoni. Quindi, il concetto di istant composer, del comporre nell'immediato, richiede una grande concentrazione e una grande apertura verso gli altri. Chiaramente, è necessario avere una grande fiducia in se stessi e negli altri.
AAJ: E tutto questo nel solo come lo realizzi? Ovvero, detto in altro modo, che valore ha per te il lavoro in solo? Anche considerando che di lavori in solitudine ne hai fatti molti e tutti di grande livello, come Intermission Riff.
C.C.: Nel lavoro in solo chiaramente sei più libero, ma io ho anche lì sempre in testa l'idea dell'orchestra: il pianoforte è fatto di tante persone/strumenti con cui si dialoga, anche se poi tu che lo suoni sei una sorta di dittatore che ha sotto di se 55 bianchi e 33 neri... Attraverso di loro detti delle cose che sono decise da te, come se, su una macchina da scrivere, producessi un racconto mettendo giù le parole. In più, però, il pianoforte è anche un individuo - fatto di legno, avorio, rame, con i suoi odori e i propri umori - con il quale ti incontri e con cui si producono delle alchimie, fino al crearsi, talvolta, di una vera e propria storia d'amore.
AAJ: Quel che colpisce dei tuoi concerti in solo è la tua forte tensione nei confronti di ciò che ti accade intorno: il luogo, il pubblico, la situazione storica e politica in cui l'evento avviene, quel che hai vissuto o che stai vivendo. Ricordo un concerto di qualche anno fa durante il quale, con mia grande sorpresa, improvvisasti su "La canzone di Marinella" di De André, l'ultima cosa che ci si sarebbe potuti aspettare... Poi ti girasti verso il pubblico dicendo "Eccola qua!" al fotografo Luca D'Agostino, presente in sala. Il quale poi mi spiegò che durante il viaggio avevate animatamente espresso un divergente giudizio sulla canzone, che lui aveva fatto casualmente andare sull'autoradio... Questo episodio macroscopico è l'esempio di quanto tu sei solito fare sempre, raccogliendo umori in sala o dalla tua vita per riversarli nella musica.
C.C.: Sì, per me si tratta sempre di un processo sia melodico che armonico, un processo nel quale il musicista è in verticale rispetto al suono e in orizzontale rispetto al mondo. L'armonia c'insegna proprio questo procedimento: mentre la linea melodica va avanti, nel tempo si crea verticalmente l'armonia. Ora, stare in armonia con il mondo significa dire le proprie cose ascoltando il mondo. Questo per me è suonare: non una masturbazione solitaria e nemmeno un darsi completamente, ma essere capaci di dire le proprie cose riuscendo a capire, negli umori del pubblico, quali sono le parole giuste per far arrivare il tuo discorso, senza mai rinunciare ad esso.
AAJ: Un progetto attorno al quale non hai mai smesso di lavorare è il trio. Parlaci del trio che stai portando avanti attualmente, magari anche in relazione a quelli che hai condotto in passato.
C.C.: Il trio è forse la formazione ha cui ho sempre tenuto di più e proprio per questo è anche quella che più è stata faticosa da mettere a punto. Perché se è vero che il duo è immediatamente dialogico e ti costringe alla concentrazione, il trio assomiglia di più a un'orchestra intera. E poi ha una propria storia straordinaria all'interno della storia generale del jazz: è un po' come il quartetto d'archi nella musica classica, si è scritto per questo tipo di formazione, ce ne sono moltissimi di formidabili. Per cui, per un pianista lavorare al trio è una delle opportunità più grandi. È anche per questo che ho sperimentato tante situazioni diverse, senza quasi mai esserne completamente soddisfatto. Oggi posso dire, dopo tantissimi anni, di aver messo insieme un trio con due ragazzi formidabili - anche come persone - che mi piace moltissimo. I miei compagni sono giovani - Alessandro Turchet, il bassista, ha 28 anni, Luca Colussi, il batterista, ne ha 32 - ma sono preparatissimi e hanno una grande sensibilità. È inutile che dica quanto li adoro, perché sono i primi a darmi veramente soddisfazione in trio dopo tanti anni, dopo cioè il mio primo trio "Hasta Siempre" con Giovanni Maier e U.T. Gandhi. Quel trio fu attivo dalla fine degli anni Ottanta fino alla metà dei Novanta, allargandosi anche a quartetto con l'ingresso di Giancarlo Schiaffini (in quella formazione pubblicammo Alea, per la Splasch, nel 1995). Per me fu un'esperienza importantissima, sia musicalmente che umanamente. Ma le cose poi vanno avanti, le persone prendono strade diverse, tutti si cambia e oggi, con le debite proporzioni, con questo trio riesco a fare quel che facevo allora. Il trio si chiama AP Trio, ma non chiedermi per cosa stia l'acronimo: dovrebbe infatti essere "Altro Pianeta," ma per me è invece "Arte Pura"... Abbiamo registrato un CD, anche questo spero esca al più presto.
AAJ: Nel frattempo, però, so che hai un progetto molto articolato e originalissimo, con musicisti di provenienze diverse e tante influenze, anche popolari, che vi convergono. Una cosa che si annuncia molto interessante. Puoi dirci qualcosa?
C.C.: Dopo l'esperienza con la N.I.O.N. ho capito che posso scrivere, arrangiare e condurre un'orchestra. Così, ho recuperato una vecchia idea: mettere insieme in una formazione grossa - ben diciassette elementi - vecchi lupi di mare e giovani talentuosi. Ma non necessariamente tutti provenienti dal jazz, anzi: il chitarrista Jimi Barbiani e l'armonicista Gianni Massarutto sono blues puro. Poi ci sono ben quattro percussioni, due contrabbassi e una sfilza di fiati: flauto, clarinetto, sax, tromba, tromboni e fagotto. Poi io al piano e Alessandra Franco alla voce. Abbiamo fatto un po' di prove ed è stato entusiasmante: suonare con il sorriso, danzando, in diciassette persone! Partiture follissime, al punto che mi sembrava di essere Frank Zappa! Sono felice, sì, sono felice, anche se stiamo ancora provando. Ed è anche una bella sfida: tutti chiudono bottega e noi mettiamo su un'orchestra di diciassette persone... Sempre controcorrente!
AAJ: Un'altra cosa particolarmente originale alla quale hai lavorato nell'ultimo anno è il progetto sull'organo della Basilica dei Frari di Venezia.
C.C.: Si tratta di una cosa nata grazie alla Caligola e a Claudio Donà, che mi hanno proposto di fare un concerto d'organo a canne in quella splendida cornice in occasione del trentesimo anniversario dell'etichetta. Oltre ad avere un organo splendido, la basilica contiene opere di straordinaria suggestione, come la famosa pala del Tiziano e la tomba di Monteverdi, per cui suonarci è terribilmente evocativo. L'organo è un Mascioni, tra i migliori dell'arte organaria di tutti i tempi, appena restaurato: tre tastiere, centinaia di canne, pedaliera larga e comoda. Ben sei mesi prima ho cominciato a fare studi e prove, e ho conosciuto Fra' Nicola, esperto d'arte e responsabile di questa straordinaria chiesa. Il progetto si è poi intitolato Shadows of Colours, ombre di colori: nove pezzi che sviluppano due clusters che stanno alla base del lavoro. Ho molto improvvisato, ma avevo previsto delle strutture che prevedevano nove colori diversi. Ho registrato sia con la chiesa chiusa, sia in occasione del concerto, fatto in maggio. È stata un'esperienza splendida, un'altra delle opportunità che la vita mi ha offerto e di cui sono grato: non avrei mai pensato di fare una cosa del genere. Anche perché l'organo non è uno strumento che abbia molto a che fare con il pianoforte: a parte la tastiera, la disposizione dei suoni è tutta diversa, per non parlare della pedaliera, che rappresenta tutti i bassi orchestrali.
Mi ha fatto poi particolarmente piacere che Fra' Nicola alla fine fosse commosso e contento, anche perché inizialmente era preoccupato e intimorito: forse pensava che fosse arrivato Satana! Invece, in realtà, in me c'è sì l'aspetto satanico, ma c'è anche quello angelico..., tra Dioniso e Apollo, insomma!
AAJ: Come hai mediato tra la tua anima di pianista jazz e uno strumento come quello dell'organo, suonato per giunta in chiesa?
C.C.: Beh, io sono sì un pianista jazz, ma sono anche una persona che ha ascoltato e ascolta molta musica. E poi mi sono formato su Johann Sebastian Bach - che è un mio riferimento continuo - e sui virginalisti inglesi del Seicento, dell'epoca elisabettiana - William Bird, Orlando Gibbons. E, ancora, ho fortemente amato organisti come Jan Peterszoon Schwelink e ho lavorato a lungo su Monteverdi, del quale conservo ancora le mie trascrizioni per pianoforte. Infine, c'è quest'idea del corale, che io ritengo una delle grandi conquiste della civiltà umana: infatti nella N.I.O.N., nel trio, da solo, di corali ce ne sono sempre a bizzeffe. Così, il fatto di poter far questo sull'organo mi ha riportato ai miei antichi ascolti, è stato per me una sorta di importantissima autoanalisi, che mi ha svelato alcuni miei aspetti ancora oscuri.
AAJ: Claudio Cojaniz, dunque, musicista a 360 gradi...
C.C.: ... ma mai a 90, però!
AAJ: Come dimostra anche il fatto che Claudio Cojaniz è anche uno scrittore, venato anche qui da un pizzico di follia. Raccontaci qualcosa della tua anima di scrittore e della tua ultima fatica, Angelo di Dolegna per leggerne la recensione).
C.C.: Il libro si intitola Angelo di Dolegna, ma il titolo - come si vede bene leggendolo al contrario - è un palindromo, così come lo sono i titoli di tutti i capitoli. È la storia di un matematico e di un sognatore che non si conoscono l'uno con l'altro. Le due storie parallele vengono narrate in modo ondivago - e lo dico non a caso, perché nel romanzo c'entra molto il mare. È dal mare che esce una sirena, capace di portare messaggi dell'uno all'altro. I due, verso la fine, si incontreranno, e succederà qualcosa. In realtà tutto quanto è un sogno di Angelo, che ogni giorno andava su una rupe a guardare il mare, si addormentava e sognava una sirena che lo veniva a trovare. Un giorno si sveglia e la sirena è lì ad attenderlo. Questo è il romanzo.
AAJ: Come ti è venuto di scrivere una storia così strana, onirica e tutta intrecciata di palindromi? Ha a che fare con la musica?
C.C.: Certo. Premesso che non mi interessa essere uno scrittore e che per me scrivere romanzi è un divertimento - alcuni vanno nell'orto, molti fanno footing, altri si lanciano con paracadute, io scrivo delle cose... - io di romanzi ne ho scritti tre e tutti hanno a che fare con la musica. Il primo - Questione Lagrand - e questo ultimo sono addirittura scritti come partiture. Il primo si muove sulla falsariga della partitura delle Variazioni Goldberg di Bach: sono trentadue capitoli e arrivati al sedicesimo il basso diventa il tema del libro, come avviene in Bach. In Angelo di Dolegna il riferimento è la dodecafonia: lo stesso palindromo era usato da Webern e anche la serie dei dodici suoni era divisa in due metà speculari. Il secondo libro - Cobra 13 - è un po' diverso, una sorta di uscita di senno, scritto quando ho capito che non potevo cambiare il mondo e ho iniziato a cambiare la mia vita. E infatti oggi sono... come prima! Ma no, dai, sono un po' più felice!
AAJ: C'è però un particolare progetto in piano solo che è di per se già a cavallo tra musica e narrazione: quello di Non son tornati, nel quale sonorizzi dal vivo documentari della Prima Guerra Mondiale e la cui musica è confluita nell'omonimo e apprezzatissimo CD (clicca qui per leggerne la recensione). Parlaci un po' di questo progetto, che meriterebbe di calcare più di quanto abbia fatto finora le scene nazionali e al quale hai comunque scritto una bellissima introduzione per il libretto del disco.
C.C.: Il progetto mi fu proposto da Cinemazero di Pordenone e riguardava dei documentari recuperati da Flavio Massarutto e concernenti tre momenti essenziali della Prima Guerra Mondiale, tra il 1916 e il 1918: gli Alpini sull'Adamello; la presa di Gorizia da parte dell'esercito Italiano; la liberazione di Trieste. Nel finale si vede arrivare la nave del Re e il popolo che lo applaude.
Flavio è un amico e una persona che stimo molto, e questo era per me già una garanzia. Poi però mi hanno fatto vedere i filmati e, francamente, quelle scene sono così vere, così terribili, da essere incommentabili... Inoltre, è così arbitrario fare musica sulle immagini, che ogni musica può essere adattata, perché alla fine è il cervello di chi ascolta che "adatta" la musica. Per rispetto del film e dell'operazione, ho preso tempo. Poi, però, è successa una cosa. Riguardando il filmato, mi sono concentrato su una scena pazzesca, che si vede verso i tre quarti: un soldato austriaco e uno italiano si accoltellano a vicenda e cadono a terra morti. In quella scena c'è tutta la stupidità e tutta l'infamia della guerra: due ragazzi che non si conoscevano si uccidono l'un l'altro, in quel modo atroce! E allora ho pensato di costruire tutta la musica attorno a quest'evento, a partire da quei 12-15 secondi di silenzio che accompagna la scena e che è inspiegabile se non dalle immagini stesse. In questo modo, ho lavorato al contrario, come a partire da un graffio in una carta da parati: levandola via e liberando il dipinto che c'era sotto. Ho cioè scritto la musica a partire dai tre quarti. Chiaramente, ho cercato di metterci dentro anche la mia memoria, a partire dai racconti che della I Guerra Mondiale mi faceva mio nonno, poi inserendo citazioni di canti popolari che sentivo da ragazzo - Il signore delle cime e Inno Festevole. E ho preparato anche un bel finale, perché dopo aver visto migliaia e migliaia di morti - sul Carso, con il gas, fucilati - vedere anche i cappelli gettati in aria per festeggiare il Re è veramente troppo! Così, ho deciso di trasformare tutto come in un film comico, con un Dixieland di maniera e, al suo interno, la citazione ben storpiata dell'inno d'Italia! Insomma, ho preso per il culo il nano dell'epoca...
AAJ: A dimostrazione che con la musica, con il jazz, è ancora possibile esprimere la propria critica nei confronti di ciò che ci circonda.
C.C.: Certo. Perché la musica - e soprattutto il jazz - è un gioco, capace di trasformare l'orrore del mondo in un sorriso.
Clicca qui per visitare il MySpace di Claudio Cojaniz
Foto di : Luca D'Agostino / Phocus Agency.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.