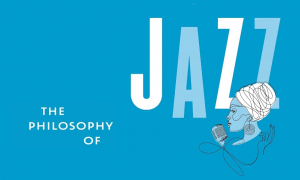Home » Articoli » Book Review » Derek Bailey: Improvvisazione. Sua natura e pratica in musica
Derek Bailey: Improvvisazione. Sua natura e pratica in musica
Di Derek Bailey
ETS
Non è un caso che la nuova edizione italiana dell'Improvvisazione di Derek Bailey sia uscita per iniziativa di un filosofo, Arnold I. Davidson, che ne ha proposto la pubblicazione in una collana di filosofia. Il libro di Bailey resta non solo un volume di importanza capitale sulla questione dell'improvvisazione in musica e sulla scena "radicale" europea - non è esagerato dire che il libro fu un evento d'importanza pari a tante esperienze musicali dirompenti di quel movimento -, ma ha la capacità di trattare i suoi problemi in modo così lucido e al tempo stesso non tecnico da andare persino oltre l'interesse specificamente musicale. La prima edizione italiana, uscita esattamente trenta anni prima, era ormai introvabile; la seconda, sempre a cura di Francesco Martinelli, è stata ora condotta sul volume rivisto e aggiornato da Bailey del 1993.
Innanzitutto un po' di storia: nel 1974 Bailey cura una trasmissione radiofonica per BBC Radio 3 dedicata all'improvvisazione in musica: intervista e fa ascoltare musicisti di svariati generi, dalla musica indiana a quella classica europea, dal flamenco al jazz, dal rock agli esponenti dalla "free improvisation" europea. Sulla base di questo ricco materiale scrive poi il libro (edito nel 1980) che raccoglie interviste e osservazioni personali, con ampio spazio all'esperienza e alla concezione musicale dell'autore. In seguito Bailey realizza un documentario - scrive i testi ed è la voce narrante - in quattro puntate sullo stesso argomento in onda nel 1992 per la televisione inglese Channel 4, dal titolo On the Edge; parte del materiale raccolto in questa nuova produzione confluisce nella nuova edizione del libro (importanti soprattutto le sezioni aggiuntive sui game pieces di Zorn e sulla storia della Company), che Bailey integra con qualche modifica lasciandone però sostanzialmente intatta l'impostazione.
Ciò che Bailey si propose di fare era un'indagine inedita per metodo e oggetto: isolare il concetto di improvvisazione in musica e analizzarlo in tutte le pratiche musicali note in cui l'improvvisazione venisse in qualche modo praticata, e fare tutto ciò chiedendo direttamente ai musicisti di descrivere la loro personale esperienza improvvisativa. Non solo: l'intuizione che sta alla base del libro è una convinzione per nulla scontata, cioè che non sia la trattazione strettamente tecnica quella in grado di rendere meglio conto di cosa sia l'improvvisazione in un ambito musicale; che il problema dell'improvvisazione si collochi in un certo senso a un livello intuitivo e discorsivo più ampio, non semplicemente descrivibile in termini di indicazioni operative determinate. La grande forza di questo libro, che ne fa un modello inarrivato al di là di inevitabili carenze o parzialità storiche, è proprio la sua capacità di parlare così acutamente di fenomeni storicamente e tecnicamente specifici impiegando un linguaggio generale.
Sia ben chiaro - e il confronto serrato e spesso polemico di generazioni di musicisti ed esperti con le categorie introdotte nel libro sta a dimostrarlo - che Bailey è tutt'altro che un osservatore neutrale: si può dire anzi che tutto il libro sia costruito sulla base delle convinzioni radicali e le inconciliabili alternative concettuali proposte dal suo autore. Le distinzioni nette, che nelle convinzioni di Bailey - e nella sua musica - lasciavano poco o nessuno spazio a vie di mezzo, tra composizione e improvvisazione, tra improvvisazione "idiomatica" e "non idiomatica," tra approccio empirico-pratico alla produzione musicale e musica come disegno intellettuale e "arte" ("l'arte è un'attività criminale" disse una volta a Peter Niklas Wilson, definendosi orgogliosamente "player" e non "artist"), prese di per sé sono assai problematiche, se si pensa soprattutto a come molta parte della migliore musica improvvisata degli ultimi decenni sia un modo di tracciare "vie" plausibili tra quelle alternative. Bisogna però tenere ben presente che sono proprio quei categorici aut aut che in definitiva resero possibile una ricerca così penetrante: in primo luogo la convinzione che, nonostante tutto, esista qualcosa che caratterizza l'improvvisazione come tale, e che questo qualcosa sia alla radice differente da ogni altro tipo di pratica musicale.
Come Bailey la pensasse in proposito bisogna almeno accennarlo. L'improvvisazione come attività essenzialmente pratica, organicamente legata al rapporto empirico con lo strumento (grandiose le pagine in cui viene trattato il rapporto con lo strumento e la sua dimensione "tattile," il cosiddetto "impulso strumentale"), che ha la sua radice nel "continuum psicofisiologico" dell'improvvisatore ed è refrattaria a una piena autoggettivazione: sono idee che attraversano tutto il libro, cariche com'erano anche di precisi riferimenti polemici. Per Bailey tutto questo aveva infatti un significato radicalmente anticoncettuale: voleva dire il rifiuto di ogni sistema "intellettuale" di organizzazione della materia sonora (l'atteggiamento dichiaratamente antiaccademico di Bailey ha come bersaglio pure gli approcci della cosiddetta musica "sperimentale," sicuramente il chitarrista aveva in mente anche Cage) e di ogni elemento preordinato, compositivo nella pratica musicale. In una parola: la pratica contiene informazioni, possibilità si scelta, è un livello operativo concreto, che la teoria non può immaginare, né codificare.
Tutto questo veniva dall'esperienza musicale di Bailey, e come per gli altri musicisti intervistati il modo migliore per trattare queste idee era raccontarle nella propria pratica musicale concreta. E' ciò che Bailey fa nei capitoli decisivi, dedicati alla "free music" o "total improvisation," termini che indicano innanzitutto il punto d'arrivo di un percorso personale iniziato con i leggendari Joseph Holbrooke (il gruppo che Bailey formò negli anni Sessanta con Tony Oxley e Gavin Bryars, di cui restano pochissime registrazioni frammentarie) e poi illustrato attraverso alcuni momenti chiave dell'intera vicenda dell'improvvisazione europea: la Music Improvisation Company, le sue storiche performance in solo e l'organizzazione delle Company Weeks, quegli incontri di improvvisatori che Bailey organizzò per vent'anni e che furono quanto di più vicino al suo ideale di improvvisazione collettiva "totale". Molti dei problemi in un certo senso insolubili quanto affascinanti di questo libro sono legati in fondo proprio a questa situazione aporetica: la "free music," l'improvvisazione "totale," liberata da concetti e pratiche estranee, che è l'asse portante del libro, era al contempo l'esperienza musicale specifica, irripetibile di Bailey, il suo personale mondo sonoro.
Il che porta dritti alla distinzione forse più discussa del libro, quella fra improvvisazione "idiomatica" e "non idiomatica". Come è noto Bailey inquadrava tutti i generi musicali in cui l'improvvisazione funzionasse all'interno di una cornice di strutture "codificate" come "idiomatici," e ciò assumeva una valenza apertamente polemica o limitativa in relazione a un genere soprattutto: il jazz. La faccenda è in realtà molto intricata - Bailey suonò e collaborò per tutta la vita con musicisti dalle radici "jazz" - e molto dipende da cosa si intende con i termini in questione; resta il fatto che Bailey aveva in mente qualcosa di diverso da un "genere" musicale, ossia una "universal music" non idiomatica, che corrispondeva alla pratica dell'improvvisazione radicale. Ma ovviamente qui si potrebbe fare a Bailey la stessa obiezione da lui rivolta persino al free jazz: le straordinarie tecniche estese di Bailey, il suo modo pure così inedito di esplorare i suoni producibili sul suo strumento, non costituiscono alla fine pure loro un linguaggio determinato, non sono in ogni caso un modo di operare entro specifici ambiti sonori con le loro regole interne e i loro limiti? Insomma: non si può forse definire "idiomatica" anche la musica di Bailey, come ogni altra?
Sono questioni aperte, che riguardano in generale tutto il panorama della musica improvvisata, la sua vitalità e la sua capacità di non risolversi in formule consolidate e ripetitive. Si possono fare a proposito due osservazioni. L'una non riguarda specificamente Bailey, ma l'uso comune del termine "idiomatico" (e il tipo di ragionamento che spesso sottende): esso ha in effetti la capacità di portare facilmente fuori strada. Sa molto di etichetta attaccata a ciò che non piace, più che spiegare le cose. In un certo senso ogni linguaggio, anche quello più innovativo, è un "idioma": la differenza fra un linguaggio morto e un linguaggio vivo, tra ciò che è scontato e ciò che non lo è, va cercata altrove. Su Bailey invece: a leggere alcune interviste rilasciate negli anni successivi all'uscita del libro, in cui gli vengono mosse obiezioni simili a quella riassunta qui sopra, il chitarrista non sembra avere interesse a difendere il suo specifico linguaggio (va bene, anche il suo sarà un idioma), quanto a rivendicare il senso della musica "non idiomatica" a un altro livello: l'improvvisazione "totale" come dimensione capace di far incontrare musicisti differenti e i loro relativi linguaggi e mondi sonori. Era esattamente l'esperienza delle Company Weeks, e il modo in cui Bailey intendeva normalmente tutte le sue collaborazioni: incontri ex abrupto, senza mediazioni. Basti ascoltare, per dire, i suoi splendidi dischi in duo con Steve Lacy o Anthony Braxton per notare come queste performance siano letteralmente un incontro stupefacente di blocchi sonori del tutto eterogenei eppure capaci di "ascoltarsi" a vicenda, al punto che si ha una netta impressione di tensione estrema, di "espansione" di entrambi i linguaggi.
Lo stile discontinuo, idiosincratico della chitarra di Bailey era poi l'elemento ideale per questi incontri. Ed era un atteggiamento che si estendeva alla stessa gestione dei rapporti: Bailey non amava le collaborazioni di lunga durata - era convinto che il meglio di un incontro tra musicisti fosse nel periodo iniziale, prima dell'inevitabile formazione di clichè - e aveva un rapporto perlomeno controverso con la registrazione (tutte cose ampiamente dibattute nell'Improvvisazione). Al di là di tutto sembra che una delle chiavi della musica e della concezione creativa di Bailey fosse conservare un rapporto in parte opaco con l'esperienza creativa, come se le "forze" (come si esprimeva lui) che sovrintendono all'improvvisazione non fossero del tutto oggettivabili, e tali dovessero restare. Non è necessariamente l'idea degli altri improvvisatori "liberi" intervistati nel libro: Steve Lacy ed Evan Parker, per esempio, sembrano propendere per una continua riconsiderazione anche teorica di tutto ciò che accade nell'improvvisazione, per un serrato processo di (auto)analisi. E qui, come si diceva all'inizio, gli interrogativi a cui il libro dà una sua personale risposta toccano non solo l'improvvisazione. A che livello avvengono realmente le nostre scelte? E' veramente quello che ci rappresentiamo "teoricamente" che guida le nostre decisioni? Oppure in realtà la pratica funziona a un altro livello, e implica un tipo di consapevolezza tutto diverso? Bailey, come si è visto, la pensava in quest'ultimo modo.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.