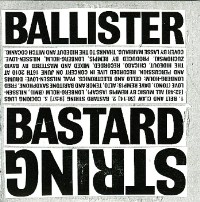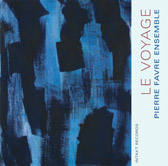Home » Articoli » Lyrics » Un popolo di poeti e... improvvisatori
Un popolo di poeti e... improvvisatori
Il tentativo di parlare delle orchestre di improvvisazione in Italia non può prescindere dall'esperienza dell'Italian Instabile Orchestra). Nata nel 1990 all'Europa Jazz Festival di Noci, la formazione ha via via raccolto successi significativi ( all'inizio più all'estero che in patria) che la hanno collocata tra le più importanti orchestre secondo la rivista statunitense Down Beat e alla collaborazione con uno dei maestri della musica afroamericana come Cecil Taylor, argomento oggetto della relazione di Marcello Lorrai contenuta nel presente volume. Non è intenzione di queste brevi note soffermarsi sulla genesi e lo sviluppo dell'Instabile per i quali rimandiamo all'acuto ed esauriente volume Italian Instabile Orchestra-Jazz come ricerca collettiva negli anni '90 ( a cura di Marcello Lorrai e Roberto Masotti, Ed. Auditorium, 1997) e al recente Previsioni del Tempo-Forecast (Imprint, 2002).
All'Instabile va ascritto il merito di aver tenuto aperta la prospettiva per una musica creativa di ispirazione jazzistica sprovincializzata e non derivativa e, attraverso il suo riconoscimento a livello internazionale, di aver favorito la praticabilità di itinerari autonomi rispetto ai modelli imposti dal mercato ( per quanto piccolo sia quello che si occupa di questa musica). All'Instabile va riconosciuta anche una funzione di raccordo tra le figure storiche del jazz d'avanguardia italiano e le nuove leve che nel corso di questi tredici anni di vita sono transitati nelle sue fila. Ricordiamo infine che l'orchestra ha fatto e sta facendo da volano ai gruppi nati al suo interno o preesistenti tra i suoi musicisti che animano il Festival Instabile di Pisa e le frequenti trasferte nazionali od estere della compagine.
Parallelamente o successivamente a questa vicenda si è assistito nel corso degli anni Novanta al prendere corpo di tendenze coagulative di singole personalità e percorsi creativi verso forme associative di vario tipo. Tramite queste sono stati realizzati concerti, attività editoriali e discografiche, gestite le attività di collettivi e orchestre. In questo modo si è garantita la necessaria autonomia e al tempo stesso si sono create condizioni perché una nuova progettualità avesse strumenti per inverarsi. Nate perciò come risposta militante verso un individualismo vissuto solo nel suo versante competitivo che ha pervaso ogni ambito politico, economico e culturale queste esperienze possiedono tratti comuni pur nell'inevitabile eterogeneità di organici, repertori, strategie compositive.
Difficile, se non impossibile definire un'estetica comune se non nel senso di assumere come qualità fondanti le salde radici con il proprio vissuto inteso come memoria e contemporaneità. Ecco che allora questi musicisti sentono come loro naturale approdo il misurarsi, senza le reticenze del passato, con la tradizione della loro terra come con i maestri del jazz o la musica sperimentale europea. Molto spesso le diverse scene locali sono in collegamento tramite il nomadismo ancora diffuso nel jazz oppure riunendosi in specifiche occasioni offerte da festival o rassegne. In alcuni casi si avvalgono del sostegno di enti pubblici in altri devono confrontarsi con l'aperta ostilità di questi. Queste realtà faticano a trovare riconoscimento da parte dei media (a parte le solite e lodevoli eccezioni) e più in generale anche dal circuito dei festival nel nostro paese più conservatori che nel resto dell'Europa. Il microcosmo costituito da un'orchestra poi deve fare i conti con le dinamiche interne ad esso in un contesto che sommando la precarietà in qualche modo congenita del mondo del jazz ad un elevato individualismo tipico dei jazzisti lo costringe a conquistarsi ogni giorno quello successivo. A dispetto di ciò queste realtà sono vive e vitali. Nel proclamare con la loro opera l'idea di una musica democratica ed eterodossa coltivano utopie necessarie.
Le schede che seguono provano a descrivere il brulicante panorama dell'improvvisazione orchestrale coscienti che queste non sono che una parte, per quanto significativa, di quello che esiste e si muove nel nostro paese.
Blast Unit Orchestra
Nato nel 2002 con l'intento apertamente polemico di colmare il vuoto di iniziative nei confronti della scena jazzistica milanese il Collettivo Jazzisti Autogestiti Milanesi (C-Jam, sito: www.freejazz.it) riunisce musicisti dell'area lombarda (ma con significativi apporti esterni) e ha trovato anche una forma associativa fondata da Paolo Botti, Tito Mangialajo Rantzer, Antonio Ribatti e Alberto Tacchini. L'associazione ha ideato e organizzato i festival AH-UM e SOMETHING ELSE!!! Nonché l'etichetta indipendente C-Jam Joint che documenta i lavori dei musicisti dell'associazione come Paolo Botti, Beppe Caruso, Dimitri Grechi Espinoza. Questa esperienza che si rifà a quella che è una pratica consueta del jazz di ricerca ovvero l'autogestione, l'autoproduzione e l'autopromozione rese necessarie non solo in contesti geograficamente marginali ma, paradossalmente ancora di più in una realtà come Milano che presta poca attenzione ai fenomeni di elaborazione dal basso per rincorrere produzioni esterofile o più "accademiche". La Blast Unit Orchestra ne rappresenta il frutto collettivo e, in qualche modo riassuntivo.
L'organico è ricalcato su quella che si può considerare una formazione-base per le orchestre di improvvisazione con ance, ottoni e ritmica con doppia batteria. Spicca la presenza di uno strumento anomalo come la viola di Paolo Botti, che ne costituisce anche una delle più apprezzabili voci e menti.
Il repertorio è prevalentemente di propria composizione ma non disdegnando di eseguire brani altrui come "Django" di John Lewis o "Sonia" del sudafricano Mongezi Feza. L'orchestra si rifà in modo marcato alla tradizione delle orchestre jazz con echi che vanno da Ellington a Charlie Haden e alterna momenti che sfruttano il pieno orchestrale (i colori e il sound) a grandi spazi riservati ai solisti, spesso senza accompagnamento. Esemplari del primo caso sono "1913" di Tito Mangialajo Rantzer e "Una rosa...le nubi dei nostri cuori...respira" di Dimitri Grechi Espinoza nei quali si sentono una infinità di riferimenti e che potrebbero rappresentare una possibile direzione personale e innovativa. Più convenzionali i brani come "Stelle Filanti" o "Blast Unit Orchestra" che mettono comunque in rilievo le belle voci dei musicisti che sono: Riccardo Pittau, Giovanni Falzone, Luca Calabrese (trombe), Beppe Caruso, Michele Benvenuti (trombone), Simone Mauri, Achille Succi (clarinetti), Dimitri Grechi Espinoza, Massimo Falascone, Edoardo Marraffa (sax), Paolo Botti (viola), Alberto Tacchini (piano), Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso), Ferdinando Faraò, Cristian Calcagnile (batteria).
Nei concerti viene esaltata anche la componente teatrale della musica con momenti di performance che de-sacralizzano il palcoscenico con atteggiamenti dadaisti. In realtà si percepisce in queste pratiche la misura di un pensiero che punta a rifondare una ritualità della musica, essendosi questa persa nella ripetizione meccanica di modelli ormai ridotti a vuoti simulacri di un'arte che si meriterebbe ben altro.
Takla Makan e Circadiana
Sul finire degli anni '90 l'attività di una parte dei musicisti di ricerca dell'area milanese si è coagulata nell'associazione Takla Improvising Group. Il nome scelto, derivato dal deserto asiatico Takla Makan, rende bene l'idea delle intenzioni del gruppo: la musica come esplorazione, come ricerca dello/nello spazio. Affini alla tedesca FMP (che non a caso distribuisce i dischi della loro Takla Records) ma non tanto al nichilismo sonoro degli esordi quanto ad una certa idea di ricostruzione dopo una sorta di "tabula rasa" guardando da un lato agli esiti della musica colta contemporanea (Webern, Cage) e dall'altro alla scuola dell'avanguardia afroamericana (AACM, Braxton) omaggiata ad esempio nel CD Art.68.
Tra i dischi e i progetti che hanno visto protagonisti i suoi membri ci sono formazioni che vanno dal solo fino al quartetto e anche un orchestra-laboratorio diretta da clarinettista Fabio Martini denominata "Circadiana" che ha prodotto nel 1998 un notevole disco per l'inglese Leo Records: Clangori. Un'ora di musica che si forma sotto un severo controllo sfruttando i molteplici colori al suo interno dilatando e addensando gli spazi e mantenendo un preciso profilo collettivo pur nell'ampia libertà concessa ai singoli. Oltre al leader ci sono: Giancarlo Locatelli ai clarinetti, Sergio Notari al corno, Marina Ciccarelli al trombone, Luca Venitucci alla fisarmonica, Angelo Avogadri e Luciano Margorani alla chitarra, Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso, Filippo Monico e Fabrizio Spera alle percussioni e Massimo Falascone ai sax alto, sopranino e baritono. Quest'ultimo ha utilizzato parte degli stessi musicisti (Avogadri, Martini, Locatelli, Ciccarelli, Spera) affiancando loro Alberto Braida al piano, Pasquale Innarella al corno e sax e Gianfranco Tedeschi al contrabbasso per il bel lavoro HAL.
Realizzato tra il 1998 e il 2000 esso è un'interpretazione musicale del celebre "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick formata da composizioni, improvvisazioni e strutture dinamicamente ma strettamente collegate al film. Frutto di un impegno che ha comportato un anno di studio e documentazione e un altro per la composizione il lavoro è un interpretazione musicale del film e non una colonna sonora, con momenti di grande interesse e alterna parti solistiche (notevole quella del pianista Alberto Braida) e collettivi con la presenza di due brani non originali: "Jesus Maria" di Carla Bley e l'incantevole, spiazzante "Over the Rainbow" che conclude perfettamente il viaggio sonoro. Va detto che l'opera non ha avuto, come spesso accade, l'attenzione che merita da parte degli operatori. Falascone partecipa oggi anche ad altre orchestre di improvvisazione come "Mondo Ra," nata al festival Controindicazioni e la "Blast Unit," legata al C-JAM (Collettivo Jazzisti Autogestiti Milanesi).
Disciolto il nucleo dei soci fondatori oggi Takla Improvising continua con Martini e Monico l'attività di ricerca organizzando tra l'altro un festival su musica e danza e preparando un secondo lavoro dell'ensemble Circadiana.
Bassesfere
In quanto città universitaria dalla solida tradizione politica, civile ed artistica Bologna è uno dei poli della musica di ispirazione afroamericana. L'area dell'improvvisazione si coagula attorno ad un circuito di locali e spazi dedicati alla sperimentazione (spesso multidisciplinare), al Festival Angelica e all'Associazione Bassesfere (www.bassesfere.it). Nata nel 1993, ha organizzato diverse rassegne nel capoluogo emiliano e ha fondato una propria etichetta, la Bassesferec. Attualmente ne fanno parte il sassofonista Edoardo Marraffa, i pianisti Fabrizio Puglisi e Stefano De Bonis, i bassisti Luigi Mosso e Vincenzo Vasi, il chitarrista Alberto Capelli e i percussionisti Mirko Sabatini e Paolo De Gregorio.
Da quando il violoncellista Tristan Honsinger si è stabilito nell'appennino emiliano frequenti sono le sue collaborazioni con i musicisti dell'area che ne hanno caratterizzato ancora più marcatamente i riferimenti alla scuola olandese di cui Honsinger è tra i più significativi esponenti. A questo proposito si può segnalare il progetto Dilemma che lo vede in compagnia di Vasi, Marraffa, Enrico Sartori (sax e clarinetto), Antonio Borghini (contrabbasso) e Cristiano De Fabritiis (batteria) oppure l'opera "Galleria San Francesco" su libretto dello scrittore Ermanno Cavazzoni con la partecipazione della cantante Cristina Zavalloni, altra musicista emersa da questa fertile scena.
Multidisciplinarietà, cabaret musicale, improvvisazione collettiva, jazz e musica contemporanea segnano l'estetica delle formazioni come il notevole trio Atman, il Collettivo Bassesfere, Perpetual Workshop on Monk e Specchio Ensemble. Quest'ultima formazione, diretta dal chitarrista Domenico Caliri, ha pubblicato due lavori discografici che costituiscono una significativa testimonianza della ricerca dell'area bolognese. Registrati a distanza di quattro anni (1994-1998) i due dischi presentano un doppio quintetto che nel primo caso è esattamente speculare (ance, chitarre, piano, contrabbasso, batteria) mentre nel secondo la formazione è modificata e accanto ai succitati Marraffa, Capelli, Puglisi, Vasi, Sabatini, Mosso compaiono anche Riccardo Pittau alla tromba, Guglielmo Pagnozzi alle ance e Francesco Cusa alla batteria; un collettivo orchestrale dove anche la musica assume una diversa direzione. Nel primo Suite no.1 per quintetto doppio (Pierrot Lunaire, CAICAI 005) troviamo un'opera dal sapore intellettualistico e aspro con abbondanti riferimenti alla musica "colta" d'avanguardia mentre nel successivo Porcyville (I dischi di Angelica, IDA 017) si coglie una maggiore istintività e debiti nei confronti della lezione della ICP e di certa scena avantjazz statunitense. Come nella copertina del disco (ad opera del leader) il metodo è un collage stratificato, denso di figure e riferimenti eruditi e pop, mutevole nella sua frammentazione e costante rimessa in discussione di sé. In entrambi i casi Caliri dimostra idee precise e i suoi compagni di viaggio singolarità non comuni.
Dolmen Orchestra
Che la Puglia sia una terra ricca di talenti jazzistici non si scopre certo ora ma questa orchestra merita certamente più di una attenzione. Nata nel 1996 intorno alla M.I.A. (Musicisti Italiani Associati), un'associazione a carattere sindacale, su spinta del batterista Aldo Bagnoni, dei sassofonisti Nicola Pisani e Felice Muzzino e dei pianisti Gianni Lenoci, Pippo Fumaroli e Nico Marziliano la Dolmen (nome più bello non lo potevano trovare) è un vero e proprio progetto culturale. La direzione è affidata a Nicola Pisani che vi pratica anche le conduction; il repertorio è il risultato di un lavoro a più mani che vede all'opera diversi membri della formazione come i sassofonisti Claudio Lugo e Vittorio Gallo o il trombettista Marco Sannini. Nel corso della sua vita l'orchestra ha chiamato a collaborare con sé numerosi esponenti della musica di ricerca come Tim Berne, Louis Sclavis, Keith Tippett, Gianluigi Trovesi.
L'organico è a geometria variabile e viene costruito intorno ai progetti che si decide di perseguire. Una caratteristica da sottolineare è l'ampio raggio di interessi non solo musicali che la hanno portata ad interagire con danzatori e pittori in performance improvvisate scegliendo anche di esibirsi in spazi non convenzionali come porti, chiese e giardini.
Le due documentazioni discografiche, entrambe uscite per l'inglese Leo Records rendono bene l'idea dell'estetica e della assoluta qualità della formazione pugliese. Sequenze armoniche, del 2000, si basa sull'interpretazione e la riscrittura del brano di canto gregoriano "Victimae Paschali Laudes"; ospiti del lavoro sono tre musicisti europei che più di ogni altro hanno operato a far incontrare la musica improvvisata con quella antica: John Surman, Michel Godard, Linda Bsiri. L'incontro è riuscitissimo, empatico e la musica di grande effetto. Il secondo lavoro uscito l'anno scorso si intitola Minotrauma e si basa sul racconto dello scrittore elvetico Friedrich Durrenmatt "Minotaurus" che narra la vicenda mitologica vista dalla parte del mostro metà-uomo e metà- toro. Questa volta viene utilizzata la versatile voce di Cristina Zavalloni per gli inserti di testo in tedesco e italiano e per i cantati mentre al trombone del francese Yves Robert è affidato il compito di rappresentare il tragico minotauro. Tre conduction scandiscono in apertura, a metà e in chiusura un lavoro molto vario da un punto di vista ritmico e che concede ampi spazi all'improvvisazione grazie alle composizioni di Pisani, Gallo, Lugo, Lenoci e Antonio Dambrosio. Da segnalare la presenza dei clarinetti del modenese Achille Succi che contribuisce in modo significativo alla riuscita di un lavoro complesso e stratificato che sancisce l'affermazione della Dolmen come tra le più importanti orchestre del momento.
Meridiana Multijazz Orchestra
Nata nel barese alle soglie del terzo millennio la Meridiana Multijazz Orchestra si affida ad una direzione a quattro che rende bene l'idea del progetto. I quattro direttori artistici sono infatti quattro personalità storiche del jazz pugliese: il sassofonista, poeta e operatore culturale Vittorino Curci, il trombettista Pino Minafra, i sassofonisti Roberto Ottaviano e Nicola Pisani. Quattro vulcani di iniziative: la Dolmen Orchestra, l'Italian Instabile Orchestra, il Festival di Noci, il Talos di Ruvo, Monomanie a Bari e poi circoli culturali, battaglie quotidiane in favore di un jazz e di una cultura sprovincializzati. Nell'ensemble ( riunito per la prima volta nel 2002) troviamo altre figure quali i percussionisti Vincenzo Mazzone e Marcello Magliocchi, il pianista Gianni Lenoci o il giovane Gaetano Partipilo. Elemento originale e assai poco utilizzato nelle orchestre di improvvisazione è la presenza delle voci con l'ensemble Faraualla.
Obiettivo dichiarato: proporre un punto di vista culturale autonomo del sud che connetta idealmente tutti i sud del mondo; un punto di vista meridiano, appunto. Nella musica di Meridiana trovano posto perciò accanto alla inequivocabile "Terronia" di Pino Minafra "Fratello Balcanico" di Admir Shkurtaj e le liriche del poeta pugliese Vittorio Bodini. L'estesa "Fabula Fabis" di Nicola Pisani è probabilmente esemplare con la sua struttura aperta a molteplici influenze anche nordeuropee senza perdere colore (e calore). Questa musica è per forza di cose eclettica e multiforme nell'inglobare jazz, memorie di Bande di paese, marcette, ironie cabarettistiche, echi etnici e sbandate rock. Molta improvvisazione naturalmente ma con una solarità che se a volte può sembrare euforica è frutto di un vissuto fatto di tenace speranza e di una militanza culturale che non è mai venuta meno.
Phophonix Orchestra
Quando a Pordenone il 30 dicembre 2000 all'interno di capannoni abbandonati e occupati per protesta contro il degrado culturale della città si sono riuniti i musicisti del jazz d'avanguardia del nordest per dar vita ad un concerto di musica improvvisata è apparso chiaro a tutti che la spontaneità dell'evento era maturato in un clima preesistente. La scena dell'improvvisazione dell'area aveva infatti non solo fatto emergere singolarità particolarmente forti ma tentato fin da subito di costituire collettivi e orchestre. Dall'esperienza seminale del collettivo Tarahumara al Jazz Transition Group, dalle sedute di improvvisazione presso la scuola Progetto Exit a Vittorio Veneto alle esperienze di Dobbia nel Goriziano è stato tutto un tentativo di riunire la multiforme scena jazzistica in contesti allargati in grado di connettere le ricerche che i musicisti stavano elaborando. L'occasione offerta dalla battaglia per gli spazi destinati alla cultura è venuta perciò a collocarsi in un momento nel quale l'esigenza era sentita e i percorsi potevano di nuovo incrociarsi.
Il flautista pordenonese Massimo De Mattia da tempo meditava un'orchestra di improvvisazione, Giovanni Maier stava vivendo l'esperienza dell'Instabile e saranno loro a convocare i musicisti su sollecitazione dell'autore di queste note. Dopo una serie di concerti viene decisa nel 2001 la costituzione dell'omonima associazione culturale che gestisce la formazione. La Phophonix Orchestra lavora su brani che i diversi compositori che ne fanno parte adattano da precedenti partiture o elaborano appositamente alternandosi alla conduzione durante i concerti. Il ventaglio degli stili è molto ampio in considerazione del background eterogeneo dei musicisti e spesso si propongono pezzi che utilizzano in tutto o in parte il metodo della conduction oppure libere improvvisazioni collettive. Nell'organico si avvicendano, come è normale in questi contesti, diversi musicisti anche se il nucleo maggioritario rimane in questa sua prima fase stabile generando anche collaborazioni tra i suoi membri esterne all'orchestra.
Parallelamente vengono perseguiti progetti multidisciplinari come "I Fofoni Animati," sonorizzazione dal vivo di cortometraggi di cinema d'animazione e incontri con la letteratura. Grazie ai rapporti che l'associazione riesce a costruire e consolidare sul territorio l'orchestra si esibisce in occasione di manifestazioni a carattere socio-politico e di festival e rassegne nei teatri come nelle piazze di grossi centri ma anche di paese portando la propria musica anche in realtà diverse dagli abituali contenitori del jazz. Questa funzione di superamento di schematismi e convenzioni caratterizza la propensione militante dell'orchestra Phophonix.
Foto di Claudio Casanova (le prime due) e Luca D'Agostino (l'ultima)
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.