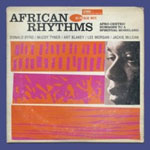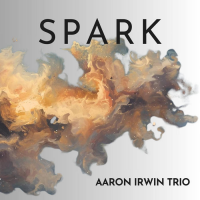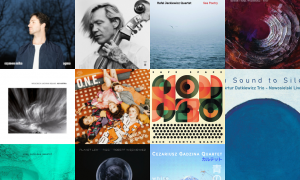Home » Articoli » Live Review » Ravel - Hurel - Boulez - Wang / Divertimento Ensemble
Ravel - Hurel - Boulez - Wang / Divertimento Ensemble
Philippe Hurel - Cantus
Pierre Boulez - Dérive 1
Lin Wang - Ba Yin
Teatrino di Corte della Villa Reale - Monza - 10.05.2008
Dopo il breve ma puntuale incontro introduttivo con Philippe Hurel e Lin Wang, coordinato da Alessandro Solbiati, spetta ai sapori spagnoli curati da Giulia Tommasi aprire il concerto monzese del Divertimento Ensemble con un variegato “contrappunto enogastronomico”, di cui sono protagonisti la freschezza del gazpacho, la gustosa paella, il vigore della tortilla ai peperoni e del baccalà, addolciti da una delicata bavarese alle fragole, che completa l’opera a mo’ di coda primaverile.
Non meno ricco di energia ed eterogeneo, per quanto sotteso da un’innegabile coerenza, il programma del concerto, aperto dalla sonata per violino e violoncello scritta nel 1922 da Maurice Ravel in memoria di Debussy. Nell’esecuzione priva di sbavature, fornita da Lorenzo Gorli e Martina Rudic - esponenti di spicco dell’ensemble - risaltano le asperità timbriche, talvolta percussive, non di rado dissonanti, del brano, nel quale il compositore francese rielabora in maniera molto personale la lezione di Béla Bartók. Gli interpreti affrontano con sicurezza tutte le difficoltà, districandosi bene in una densità contrappuntistica che si fa via via più fitta.
La proliferazione delle voci e dei motivi è una caratteristica che si riscontra, a un livello di complessità maggiore, in “Cantus”, composizione di Philippe Hurel, presentata in prima esecuzione italiana, che vede la partecipazione di Donatienne Michel-Dansac, una delle voci più apprezzate del panorama musicale contemporaneo, alla quale hanno dedicato significativi lavori Aperghis, Leroux, Romitelli, Francesconi e Lanza, tra gli altri. Partendo da canoni ritmici e polifonie germinate da un semplice cantus firmus, il brano si ramifica in un intrico di sottigliezze timbriche concepite con il software Open Music, connotate da un grado di energia e densità variabili dal soffio appena percepile a parossismi che scompaginano l’intero organico, per ritornare all’esile linea iniziale nella sezione conclusiva, impreziosita dalle tenui sonorità della m’bira. Il testo, redatto a posteriori da Hurel come una sorta di descrizione, ironicamente oggettiva, degli accadimenti sonori (non casualmente il brano è un omaggio a Georges Perec e al suo “La vie mode d’emploi”), acquista un’insospettata efficacia drammaturgica grazie alla formidabile espressività del soprano, che padroneggia da par suo una trama vocale connotata da ritmi irregolari (che ricordano la flessibilità metrica del jazz, da sempre apprezzato dal compositore) e bruschi scarti intervallari. Davvero un lavoro riuscito, in cui convergono istanze diverse come la ricerca concentrata sulla struttura interna del suono perseguita dallo spettralismo e una concezione architettonica strutturalista interpretata in maniera affatto originale.
Quando si parla di strutturalismo, d’obbligo è il riferimento a Pierre Boulez, del quale viene presentata “Dérive 1”, concepita nei primi anni ’80 per un organico di sette strumenti.
In questo lavoro, in realtà, i dettami del postwbernismo seriale non sono seguiti rigidamente, in favore di un gusto per iridescenze e impasti sempre cangianti, ben restituiti da un esecuzione che ne evidenzia le seduzioni timbriche insospettate, le deviazioni da regole troppo strette.
Una felice scoperta si è rivelato l’ascolto di “Ba Yin”, lavoro scritto nel 2004 dalla cinese Lin Wang (classe 1976) con l’intento di trasfondere in un organico europeo un’idea compositiva d’ispirazione orientale, senza nulla concedere, al tempo stesso, all’eclettismo di maniera. Il titolo del brano (letteralmente “otto suoni”) allude agli strumenti dell’antica musica cinese, che venivano catalogati in base ai materiali di cui erano fatti: la ricerca di corrispondenze con la tradizione è dunque alla base della composizione, concepita per un gruppo di otto elementi “classici” occidentale, ai quali si unisce la versatilissima voce della stessa autrice. E’ quest’ultima, ora ritmicamente scandita, ora cantilenante, talvolta onomatopeica (quasi a imitare i suoni strumentali), o ancora prossima agli stilemi dell’opera cinese o alla cadenza della lingua parlata, a orientare un avvicente percorso sonoro dai caratteri gestuali piuttosto marcati, sottolineati dai musicisti dell’ensemble con interventi vocali e una nutrita schiera di percussioni (piatti, in particolare).
Più che su una rigorosa armonia, l’attenzione della Wang si concentra sul timbro e sull’intonazione (un’attitudine evidente, in particolare, nell’uso non raro dei microintervalli, specie per quanto riguarda i fiati), in modo da organizzare il materiale secondo una logica coerente ma, al contempo, continuamente fluttuante tra l’accumulo dell’energia e la liberazione di quest’ultima. Ne scaturisce un multiforme teatro musicale, che, malgrado diverse smagliature e sincronismi non sempre precisi nell’esecuzione, risulta comunque vivace e raffinato, con un impatto “narrativo” (in senso lato) decisamente efficace.
E’ questo il tratto distintivo del linguaggio della compositrice, sviluppato e costantemente rinnovato nel tempo, a partire dalle suggestioni più disparate (dall’epidemia di SARS, apparsa in Estremo Oriente tra il 2002 e il 2003, al non-sense poetico di e.e. cummings), con la collaborazione di complessi prestigiosi come il Nieuw Ensemble e l’Ensemble Modern, tra gli altri. Non resta che seguire con attenzione i prossimi passi di Lin Wang, attesa alla Biennale di Venezia 2008 e nella prossima stagione del Divertimento Ensemble, con la creazione di un’opera da camera commissionatale a seguito del superamento di una selezione, da cui sono usciti vincitori altri due giovani autori, l'italiano Daniele Ghisi e l'argentino Fernando Fiszbein.
Visita il sito di Philippe Hurel
Visita il sito del Divertimento Ensemble
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.