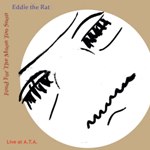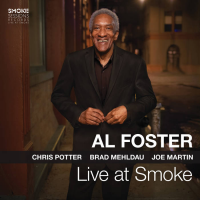Home » Articoli » Lyrics » Psychomingus
Psychomingus
Introduzione
Fra i tanti jazzmen che potremmo stendere sul lettino dello psicoanalista, Charles Mingus ha un punto di vantaggio: quello di essercisi rivolto realmente, alla psicoanalisi, con fervore e convinzione. Come in tutto ciò che intraprendeva. La cosa può senz'altro favorirci, ma attenzione: non è tanto ciò che chi l'ha avuto in analisi ha saputo rivelarci circa una personalità complessa come poche a venirci incontro, quanto piuttosto la molla che quella pratica autoconoscitiva ha saputo innescare in lui direttamente, consigliandogli, nei secondi anni Cinquanta, la stesura di quell'autobiografia molto speciale che s'intitola Beneath the Underdog, in italiano Peggio di un bastardo [Nota 1].
Lo psicoanalista di Mingus era in ogni caso il dottor Edmund Pollock, fra l'altro autore, su richiesta del contrabbassista, delle note di copertina di The Black Saint and the Sinner Lady, uno dei massimi capolavori mingusiani, inciso nel 1963 per la Impulse!. Note che, di fatto, non c'illuminano granché circa l'intricata psiche mingusiana, arenandosi sostanzialmente in quel limbo misto di luogo comune e condiscendenza che Mingus per primo si attendeva da Pollock, ebreo, e in quanto tale potenziale frère d'adoption di un uomo ossessionato dal complesso del sangue misto, del bastardo. Un Pollock che, come nota Mario Luzzi, "finì per subire il fascino di Mingus" [Nota 2].
Uno e trino
Spesso non c'è nulla di più insidioso, come ben sanno gli specialisti di settore, di un trattamento analitico intrapreso con un paziente già in possesso di un'infarinatura in materia. Costui tenderà ad "agevolare" il lavoro del medico, instaurando in prima persona rimandi e connessioni nello svelare la propria attività psichica - e più ancora onirica - al fine di renderne più diretta, lineare, la lettura. Col risultato, non di rado, di ingarbugliare ulteriormente la matassa.
Sono semmai il procedimento, i ritorni e gli occultamenti ricorrenti riscontrabili nella sua esposizione, a svelare più di quanto l'interessato magari vorrebbe i segreti del suo vissuto e la rielaborazione operatasi all'interno della sua psiche.
E' appunto questa l'angolazione in cui dobbiamo porci avvicinando Beneath the Underdog, scritto da Mingus quando già si trovava in analisi [Nota 3]. Il prologo è in tal senso illuminante: con un autentico uppercut, tipico di un uomo che non ama certo i convenevoli e le mezze misure, Mingus ci somministra una rappresentazione tripartita della sua psiche, operando un rimando alquanto scoperto al tripolarismo freudiano Io/Es/Super-Io. In altre parole, il contrabbassista, che ci regala un primo capitolo interamente di botta e risposta col suo analista, sembra ammonirci: non cercate di penetrarmi; sono io ad aprirmi a voi spontaneamente. Così ci fa subito sapere che lui è tre: nella migliore delle ipotesi, c'è un uomo mansueto e generoso, nella peggiore "un animale spaventato che attacca per paura di essere attaccato" [Nota 4]; in mezzo una sorta di supervisore, di grande burattinaio che scruta pacato le conflittualità degli altri due.
Un ritratto un po' troppo edificante per assomigliare a un individuo che si è rivelato, per chi ha avuto a che fare con lui, una pistola col colpo perennemente in canna.
Certo, all'uomo rissoso, collerico, "difficile, imprevedibile, (...) disadattato ai limiti della psicosi, infantilmente vittimista ed esibizionista," come ha osservato Arrigo Polillo si affiancava quello "onesto come pochi, ingenuo in modo sorprendente, brutalmente sincero," e ancora "patologicamente incapace di controllarsi, spesso ingiusto e ingrato [Nota 5]. Una continua girandola di umori e sfaccettature, quindi. Ma da questo a immaginarlo come un uomo che, mal che vada, colpisce per legittima difesa ce ne corre. La violenza, la crudezza, non solo delle situazioni narrate, ma anche verbale, umorale, è in effetti il tratto più scoperto che emerge da Beneath the Underdog, che finisce così per ricalcare molto da vicino l'essenza di un'altra celebre autobiografia, quella di Malcolm X. Parallelo è per più versi il tragitto iniziale della vita di entrambi: cresciuti in mezzo alla violenza, a iniziare dalla famiglia, da ragazzi anelano l'integrazione - loro, neri chiari: giallo Mingus, rosso Malcolm X [Nota 6] - in un mondo dominato dai bianchi, per prendere quindi coscienza, una coscienza aggressiva, della propria negritudine (anche se in Mingus, come vedremo, tale processo assume connotati un po' particolari) e finire in quel sottobosco in cui musicisti, prostitute e trafficanti appartengono alla stessa famiglia.
In un contesto del genere, un ruolo decisivo gioca ovviamente il sesso, un sesso di segno inequivocabilmente maschile (e - va da sé - maschilista), elemento centrale dell'intera autobiografia mingusiana così come dei primi capitoli di quella di Malcolm X [Nota 7]; un sesso esplorato con precocità e poi assunto a vero e proprio talismano per l'ostentazione della superiorità della razza nera. Mingus, peraltro, rimane come detto un nero giallo, un mulatto, un bastardo (un underdog, appunto) ed è questa la luce sotto la quale si è voluto leggere per lo più l'insistente esibizionismo delle proprie doti amatorie che attraversa le pagine di Beneath the Underdog. Etimologicamente discendente dal mulo, il mulatto è di per sé sinonimo di impotenza, di insufficienza virile: Mingus ribalta recisamente questo stato di cose, in cui coglie l'ennesimo tentativo (del bianco) di svilire e mortificare la sua dignità di coloured. Non è tuttavia questa l'unica ottica in cui porsi: analizzando più dappresso alcune sue vicissitudini esistenziali, per ovvi motivi soprattutto infantili, ci accorgeremo di quanto la panoramica possa essere in effetti ampliata.
Prima, tuttavia, sarà il caso di fare brevemente il punto della situazione, inserendo nel nostro discorso la testimonianza diretta raccolta dalla voce di Buddy Collette, amico di Mingus fin dall'infanzia (i due sono separati da appena otto mesi: agosto 1921 per Collette, aprile '22 per Mingus), ripetutamente citato in Beneath the Underdog.
"Charlie aveva una fervida immaginazione," afferma per cominciare Collette. "Quanto si racconta nell'autobiografia è vero solo in parte. Essendo cosciente che un libro vuol essere letto, Charlie amplificava la realtà, la esasperava. Ciò a cui mirava anzitutto, in senso generale, era scioccare. Si possono fare cento note, oppure mille. Lui magari ne faceva cento, però raccontava di averne fatte mille, perché questo voleva la gente. Una volta, verso i sedici anni, si era rapato la testa lasciandosi solo una striscia di capelli al centro, tipo ultimo dei Mohicani, una cosa in fondo non troppo dissimile da quanto avrebbero fatto poi i punk. Solo che lui l'ha fatto quarant'anni prima! In ogni caso, se avesse saputo di ottenere maggiori attenzioni tagliandosi le vene, sono convinto che l'avrebbe fatto" [Nota 8].
Sia come sia, uno dei primi ricordi di Mingus, con tutta probabilità il più sofferto, riguarda le cruente punizioni corporali inflittegli dal padre quando bagnava il letto. Aveva quattro anni e soffriva di enuresi notturna. La cosa andò avanti per mesi, finché una mattina Charles "aprì gli occhi e vide suo padre che gli ficcava una bottiglia sotto il naso: Meno male che non hai pisciato ragazzo! La vedi questa bottiglia di acido? La prossima volta la prendo e te lo brucio tutto! Queste parole gli riempirono il cuore di un gelido orrore e continuarono a echeggiare negli anni ogni volta che si alzava all'alba per fare un viaggio supplementare al gabinetto e liberare i reni malaticci che non erano stati curati nella sua infanzia" [Nota 9].
Leggiamo ora cosa scrive Freud al riguardo: "La maggior parte delle cosiddette sofferenze della vescica in quest'epoca sono disturbi sessuali; l'enuresi notturna corrisponde, salvo che non rappresenti un attacco epilettico, a una polluzione" [Nota 10]. E altrove: "La causa più probabile di questo genere di incontinenza è a mio avviso la masturbazione, a cui finora si è dato troppo poco posto nell'etiologia dell'enuresi" [Nota 11]. Scatta a questo punto da parte dell'adulto la minaccia dell'evirazione, e "ciò di fronte a cui l'incredulità del bambino è costretta a capitolare è l'osservazione del genitale femminile" [Nota 12]. Ora: Mingus non ci dice quale intimità mantenesse all'epoca col proprio pene, ma sappiamo che proprio a quel momento risale la prima constatazione dell'assenza dello stesso nelle sue sorelle (osservate mentre si lavano), per cui la conclusione è fin troppo ovvia: le due bimbe, più grandi di lui, hanno già subito l'orrenda mutilazione.
Le prime tessere iniziano quindi a inserirsi spedite nel puzzle, e tuttavia la panoramica va ulteriormente allargata. Le sensazioni primarie connesse all'enuresi sono due: il bagnato e il tepore. Di entrambe ravvisiamo, nella vita cosciente del piccolo Charles, precise tracce. Per iniziare, rievocando le punizioni corporali inflittegli dal padre, Mingus collega regolarmente [Nota 13] il bagnarsi nel sonno col bagnarsi da sveglio, nei giorni di pioggia. In entrambi i casi afferma di aver fatto la massima attenzione, ma senza successo. La simbologia è chiaramente quella della polluzione, mai intenzionale e/o conscia. Sul secondo elemento - il tepore - ecco un'altra rievocazione sorprendentemente pertinente: "Mentre giocava nella sabbia [teniamo sempre presente l'uso della terza persona per parlare di se stesso, N.d.A.] aveva cominciato a versarsi la rena calda nei calzoncini perché gli faceva piacere. Una maestra [d'asilo: il fatto si svolge sempre attorno ai quattro anni, N.d.A.] lo strappò via dalla sabbia. Pervertito!, gli disse" [Nota 14].
Allarghiamo ancora il cerchio. La psicoanalisi c'illumina circa la visione che il bambino ha della minzione e della defecazione come surrogati dell'atto sessuale. E' lo stesso adulto, del resto, dipingendo tali pratiche - allo stesso titolo della manipolazione infantile dei genitali - come sconvenienti, a innescare l'analogia. Allo stadio dell'erotismo anale risale oltre tutto la nostalgia per la nutrizione intesa come atto altamente gratificante e rassicurante (la suzione dal capezzolo o dal biberon) che spesso permane, con identica funzione, nell'adulto dai grandi appetiti. E sappiamo quanto Mingus fosse uomo di grandi appetiti, sessuali e culinari (ma pure musicali, se è per questo). L'analogia è anche qui agevole: entrambi gli atti nascono da una ricerca, da un'esigenza, di gratificazione erotica. Il seno materno è infatti notoriamente il nostro primo appagatore sessuale. Dietro alle varie tappe della digestione, che inizia con un'assunzione di cibo e termina con la relativa evacuazione, si cela d'altronde per molti bambini l'arcano della riproduzione. Effetto, non a caso, dell'atto sessuale dell'adulto.
Aggiungiamo, prima di trarre le logiche conclusioni, un ultimo tassello, tornando al complesso di evirazione. La psicoanalisi - Freud e Ferenczi in testa - ci ha insegnato a stabilire una stretta correlazione fra la moltiplicazione degli emblemi fallici e il ribaltamento di tale complesso nel simbolo della Medusa, nel momento in cui la testa decapitata sta per evirazione, quell'evirazione a cui ci si ribella moltiplicando appunto l'evocazione del pene attraverso la sostituzione dei comuni capelli della Medusa con una massa di serpenti. Il quadro appare completo: inibito nelle sue manifestazioni erotiche (o pan-erotiche, come potremmo definirle) infantili mediante la minaccia di evirazione, Mingus si ribella rifugiandosi in un esasperato esibizionismo sessuale, un'esaltazione ossessiva - per ipersviluppo, iperattività e iperperizia - del proprio fallo, oltre che in appetiti complessivi, come dicevamo, a loro volta ipernormali.
Ancora Buddy Collette nota che "non c'era sfera migliore, per l'esibizionismo di Mingus, di quella sessuale. Nell'occasione del celebre amplesso multiplo a Tijuana [Nota 15], per esempio, ci fu certo una notte di fuoco, ma Charlie non ebbe di sicuro più di venti rapporti come racconta. Voleva che la gente lo ritenesse capace di imprese superumane". Se quindi, come Freud c'insegna, "una preistoria di questo tipo può dar luogo all'epoca della maturità a due diversi comportamenti nei confronti delle esigenze erotiche: un abbandono completo e incontrastato alla sessualità, prossimo alla perversione, ovvero una reazione di ripudio della sessualità nel quadro di una nevrosi" [Nota 16], non si può che concludere che Mingus rientra a piè pari nel primo caso. Nella sua risposta reattiva, "il mostrare il pene - e tutti i suoi surrogati - vuol dire: non ho paura di te [che hai minacciato di evirarmi, N.d.A.], ti sfido, ho un pene" [Nota 17].
Il padre, il bianco, Dio
Contro chi muove, Mingus, tale sfida? Contro suo padre, anzitutto, autore della tremenda minaccia per cui "è subentrata in lui una paura così intensa e durevole (...) che ha dovuto far sfoggio di tutta la sua mascolinità per dominarla e sovracompensarla" [Nota 18]. Che in Mingus lo scontro col padre si consumi prioritariamente sul terreno sessuale, è provato da svariati elementi. Il rapporto fra i due, prima teso e poi via via sempre più distaccato [Nota 19], si ricomporrà attorno ai vent'anni. In un'epoca, comunque, in cui certi meccanismi psichici sono già pienamente formati e operanti. Anche dopo tale riavvicinamento, Mingus se ne uscirà tuttavia con considerazioni di questo tono: "Non posso continuare per sempre a far ricadere la colpa su mio padre e a cercarmi scuse [raro momento di ripensamento, con Mingus che parla in prima persona, N.d.A.]. Mi pare di stare diventando un riflesso di lui. Non è facile scongiurare la sua impronta dormiente nel mio inconscio (...) i miei genitori-con-la-cinghia-facile mi hanno dato un'infanzia senza amicizia, senza padre." Poco oltre passa al tu: "Tu ti odi perché sei grasso e ti aiuti per accavallare le gambe, come (tuo padre) - ti fa ricordare le sue continue scappatelle, e le tue. Tu sei grasso e avido. Questa era anche l'evasione di tuo padre - il cibo lo aiutava a dimenticare per un po' l'infelicità che creava. Ti ha suggerito uno schema di vita da seguire..." [Nota 20].
Ecco i temi ricorrenti: il sesso e il cibo, come abbiamo visto elemento a sua volta sessuale. Ma c'è dell'altro: quando, verso i sedici anni, avverte il desiderio di un sostituto dell'originaria figura paterna, Mingus lo trova in Pop Collette, padre di Buddy. E gli argomenti con cui questi lo conquista sono appunto di natura erotica: è lui a iniziarlo ai rozzi postulati di un'ars amatoria di cui Charile farà poi tesoro.
Che dietro l'ambire al possesso della donna (di molte donne) si celi un'implicita sfida al padre è del resto cosa di per sé risaputa. Al di là della rivalsa contro la pregressa minaccia di evirazione, e della conseguente ostentazione del pene come prova di scampato pericolo e, nel contempo, simbolo di potere (l'equazione pene = scettro è nota), un riflesso inconscio infantile è usualmente l'attribuire al padre il possesso di tutte le donne, per cui ogni donna conquistata dal figlio è di fatto sottratta al genitore-rivale (ancestralmente relativamente alla madre, non è neppure il caso di sottolinearlo). Chi temerà in eccesso tale confronto, in età matura si rifugerà non di rado nell'omosessualità. Altri - ed è il caso di Mingus - amplificheranno per contro numero e rilievo delle loro conquiste come eloquente gesto di sfregio nei confronti dell'ormai tramontata sovranità paterna.
Un altro caposaldo su cui si fonda l'avversione infantile e adolescenziale di Mingus verso il padre è la mimetizzazione che questi gli ha sempre venduto come sicuro elemento d'integrazione in un mondo dominato dai bianchi. "Grigio come il caucasico più pallido dagli occhi nocciola e i capelli color sabbia" [Nota 21], vissuto fino a quattordici anni come "un gentiluomo bianco del sud" [Nota 22], poi scacciato di casa nel momento in cui il marito della madre lo scopre figlio dello schiavo nero, Charles Mingus senior si considera evidentemente un quasi bianco, e come tale ingiunge al figlio di non farsi vedere in giro "con quei piccoli sporchi negri scuri" [Nota 23].
Fin dagli otto anni, il futuro contrabbassita si accorge invece con raccapriccio che "se fra i tuoi antenati c'è anche un solo negro, sarai sempre un negro" [Nota 24]. Il trauma è forte, e si cristallizza ulteriormente man mano che si fa strada la consapevolezza che neppure i neri-neri lo accetteranno mai [Nota 25]. Attorno ai quindici anni sa di essere in tutto e per tutto un bastardo, uno sradicato, "più chiaro di alcuni, ma non abbastanza chiaro da appartenere alla élite dei quasi-bianchi, e non abbastanza scuro da far parte dei bellissimi neri eleganti (...) Perciò prima iniziò a bruciarsi i capelli con il ferro elettrico di sua madre per lisciarli, poi passò a bagnarli per farli arricciare e ottenere il magnifico, naturale, dignitoso aspetto crespo e lanoso. Nessuno lo accettava, riccio o no (...) Ogni volta che si guardava allo specchio e si domandava: Chi sono io? Gli sembrava di vedere un'infinità di discendenze: indiana, messicana, africana, asiatica, con una certa quantità di bianco (...) Voleva essere una cosa o l'altra e invece era un po' di tutto, senza essere nulla di completo, senza razza, paese, bandiera, amici. (...) Tutto quello che voleva era essere accettato da qualche parte, e non succedeva, e allora affanculo! Diventò qualcosa di diverso. Si innamorò di se stesso" [Nota 26].
Sulla portata e gli effetti di tale status intimo ovviamente torneremo. Constatato questo legittimo risentimento razziale che porta Mingus a ripiegarsi su di sé, vale però ora la pena di riprendere le scoperte fatte poc'anzi. L'ostilità verso il padre gli deriva dunque da un insieme di fattori, il principale dei quali è la minaccia di evirazione. Ma è ancora il padre che gli propina la teoria della mimetizzazione con i bianchi. Bene: a otto anni, per la prima volta, una banda di ragazzi bianchi fa ripiombare su di lui l'orrenda minaccia: "Fatti trovare vicino a una ragazza bianca, e ti tagliamo il pirulicchio!" [Nota 27]. E il polo unico diventa un bipolarismo: il padre-quasi-bianco e i ragazzi-bianchi-del-tutto hanno sventolato contro di lui il medesimo spettro. A entrambi sarà rivolta la sfida del Mingus adulto: possedere le loro donne.
Il bipolarismo è in realtà un tripolarismo. Il terzo polo è Dio, un dio padre e un dio bianco. E' sintomatico come fin dai quattro anni, l'età delle ansie notturne dovute all'enuresi, Charles inizi a sottendere una linea retta fra Dio e suo padre, colui che la mattina, con aria truce, entra nella sua stanza "come la vendetta divina," colui che, d'altro canto, "veniva dopo Dio" [Nota 28]. Altrettanto sintomatico è che il bambino cerchi a questo punto protezione contro il temuto Dio-padre nel Gesù-figlio, proprio a iniziare dai problemi connessi all'enuresi. E' così che a un certo punto "le battute del mattino cessarono e Charles si convinse che Gesù aveva sentito la sua invocazione di aiuto. Da allora si rivolse a Gesù per qualsiasi cosa" [Nota 29].
Non passa troppo tempo che il dio-padre e il dio-bianco, primo custode di una società dominata appunto dall'uomo bianco, si sovrappongono. Già a tredici anni Charles inizia ad avvertire del resto di possedere un certo potere mistico: è sempre il potere del Gesù-figlio, con cui ormai s'identifica ("Forse ho cominciato a credere che Lui è me e io sono Lui"; [Nota 30].
Sul personalissimo senso religioso del Mingus maturo, ha rivelato la sua ultima moglie Susan Graham: "Mingus era un uomo molto spirituale, una cosa, questa, che forse molti non hanno capito abbastanza. Lui sentiva che la musica veniva da un'altra parte, che era una sorta di dono divino (...) Lui stesso era una chiesa vivente. Quella grande figura di Mingus, era un vero tempio, una cattedrale. Ritenendo di avere una linea diretta con Dio non riteneva necessario andare in chiesa (...) aveva una grande simpatia per l'induismo perché quella religione abbracciava tutte le altre (...) Se uno gli chiedeva di religione, rispondeva in un soffio Cristo, Mosè, Budda (...) lui era l'occhio di Dio, nel senso che tutto quello che sentiva e trasmetteva agli altri arrivava da Dio" [Nota 31].
La madre, la coscienza, l'energia vitale
Dopo aver scandagliato la figura paterna e relativi surrogati, varrà la pena di soffermarsi brevemente sul polo opposto, quello materno. Charles Mingus perde la sua vera madre a soli tre mesi. La sostituisce una matrigna, la cui dedizione alla famiglia d'acquisizione verrà peraltro riconosciuta dal padre di Charlie anche una volta che i due si saranno separati. "E' difficile trovare una brava donna - dirà Charles senior al figlio - che si prenda i figli di un'altra e li ami come i propri (...) è l'unica madre che hai avuto" [Nota 32]. Gli esperti di psicologia infantile sono pressoché concordi nell'affermare che "la madre biologica del bambino può essere sostituita, senza alcun danno per quest'ultimo, da una persona che abbia la possibilità di stabilire con il piccolo una continuità relazionale, fornendogli l'affetto e le cure che gli sono necessarie" [Nota 33]. Tuttavia è ovvio che la madre mai conosciuta (e quindi mai posseduta) sopravviva nell'individuo a livello intestino, oltre che come eredità genetica. Charles Mingus senior, non a caso, dirà al figlio nell'occasione appena citata: "Pensi e parli proprio come tua madre Harriet. Mi fai credere che in qualche modo lei non ti abbia mai lasciato, anche se è morta quando eri un bambino. Guarda, mi fa un po' paura pensarci: che tu sei lei in spirito..." [Nota 34].
L'impronta della madre morta c'induce ad affrontare un altro importante nodo propostoci da Beneath the Underdog: quello connesso all'Io narrante che, se si esclude il discorso diretto e qualche altro caso sporadico, ripercorre la vita di Mingus citandolo in terza persona (come faceva un certo Lester Young...) e chiamandolo il mio ragazzo. In quest'Io narrante, Giuseppe Barazzetta ha colto appunto "la personificazione della madre, mai veramente conosciuta e solo così obiettivata" [Nota 35]. Un'ipotesi condivisibile solo in senso lato, ma suggestiva. Sarà utile notare come l'origine di questa Coscienza/Anima/Linfa Vitale-Autoaffermativa sia fatta coincidere da Mingus col primo ricordo infantile (Freud c'insegna che "in ogni elaborazione psicoanalitica di regola proprio il ricordo che l'analizzato antepone agli altri, quello che cita per primo e col quale dà inizio alla confessione biografica, si dimostra il più importante, quello che cela la chiave d'accesso ai comparti segreti della sua vita psichica," [Nota 36], quando a due anni si ritrova in fin di vita per aver battuto la testa contro lo spigolo di un comodino: "Per la prima volta da quando era nato mi ritrovai all'esterno del suo corpo" [Nota 37]. Più tardi, a quattro anni, la stessa entità afferma: "Io volevo fargli sapere che non era solo, che c'ero io con lui per tutta la vita, perciò (...) mi feci in quattro per mettermi in contatto con lui. Mi riuscì difficile, forse avevo aspettato troppo e lui aveva già sviluppato uno schema di pensiero suo proprio" [Nota 38].
Da adulto, rievocando ancora quel primo ricordo, Mingus preciserà più nel dettaglio la natura di quell'entità: "Un ragazzo giaceva a terra sanguinante. Io ero quel bambino, eppure non lo ero. Ero qualcun altro nella stessa stanza, eppure la famiglia non poteva vedermi. Ero una specie di saggio vecchio come il tempo. Dipendeva interamente da me lasciare quel ragazzo sdraiato lì e andarmene verso l'infinito, oppure soffiare di nuovo la mia vita inconscia dentro di lui" [Nota 39]. Quell'entità è dunque la vita stessa, ma non secondo un'accezione singola e contingente, bensì come respiro universale e metatemporale. Anima, linfa e autocoscienza, appunto; simulacro di quella dimensione metafisica e soprasensibile tanto cara a Mingus in cui è più che probabile che confluissero, persino a livello conscio, la madre mai conosciuta, e magari lo stesso Mingus Uno, che sa tirarsi fuori dalla mischia e che "osserva e aspetta l'occasione per esprimere quello che vede agli altri due" [Nota 40].
La proiezione iperbolica di sé
Per certo Charles Mingus fu in ogni caso un uomo tutt'altro che riflessivo e posato. La sua stessa figura, imponente e umorale, lo suggeriva terreno di scontro per ogni tipo di eccesso: erotico, culinario, relazionale, verbale. Dei primi due si è detto, per cui accenniamo brevemente agli altri. Riprendendo per iniziare quanto osservato da Polillo, che come abbiamo visto definisce Mingus "disadattato ai limiti della psicosi, infantilmente vittimista ed esibizionista (...) brutalmente sincero, patologicamente incapace di controllarsi, spesso ingiusto e ingrato" [Nota 41].
Eccessi verbali, quindi, e nei rapporti con l'esterno. Delle esagerazioni verbali di Mingus, Beneath the Underdog è un autentico campionario. Avvenimenti gonfiati - o nelle proporzioni, o comunque nell'alone che li avvolge - sono quelli che toccano ovviamente la sfera sessuale, ma non solo. Innamoratosi di se stesso, come abbiamo visto, verso i quindici anni in quanto rifiutato da bianchi e neri, una decina d'anni dopo o poco più si dipinge come un uomo assolutamente irresistibile, con stuoli di donne ai suoi piedi, disposte ad accettare anche ménage sconcertanti, e tenuto in palmo di mano da tutti i maggiori jazzisti dell'epoca (emblematico in tal senso il cap. 31 dell'autobiografia, in cui si rievoca il suo trionfale arrivo a New York).
Il che è quanto meno singolare per un uomo che ben prima dei trent'anni supera il quintale, che è rissoso e cruento come pochi e che, in ambito musicale, ha ancora parecchia strada da compiere prima della definitiva consacrazione, arrivata di fatto a partire da Pithecanthropus Erectus, anno di grazia 1956.
Un atteggiamento di questo tipo ha in effetti tutti i tratti della "autorappresentazione iperbolica" che Silvia Albertazzi ha attribuito a Mingus; un Mingus che - proprio come l'Otello scespiriano - "per l'inferiorità cui è relegato (...) registrava la sua identità con amplificazioni retoriche" [Nota 42]. Non è difficile, come afferma Jung, "scoprire dietro la presunzione i tratti di un angoscioso senso di inferiorità. Anzi, vediamo chiaramente come l'esuberante sia spinto dalla sua incertezza a magnificare verità che non gli appaiono troppo sicure e a cercar proseliti che rappresentino per lui una garanzia del valore delle sue convinzioni" [Nota 43]. E' del resto Mingus stesso a illuminarci su questo punto, avanzando il dubbio : "Mi chiedo se uno dei miei problemi è il fatto di non essere mai stato il migliore in niente" [Nota 44].
Iperbolico, il Mingus che si autorappresenta, e non di rado logorroico, perso dietro a discorsi che spesso "solo lui capiva e non si preoccupava di sapere se chi lo stava ascoltando riusciva a seguirlo". E' ancora Susan Graham a rivelarcelo, e molti altri passi di questa fondamentale testimonianza ci illustrano il Mingus eccessivo, irascibile, lunatico, spesso violento: "Il problema stava nel suo modo di presentarsi (...) sempre in maniera esasperata e la tua prima sensazione era di rifiuto, non accettavi quello che diceva perché lo diceva con una energia e un'esasperazione eccessiva. (...) Mingus usava la rabbia, la carica emotiva che aveva in corpo perché aveva capito che nella società in cui viveva non poteva reagire come un uomo normale (...) lui era un nero. (...) Mingus era come un bambino, voleva tutto e subito" [Nota 45].
La Graham ci informa anche della tendenza del marito a drammatizzare ogni cosa, piccola o grande che fosse, che lo riguardasse o meno. Per una critica negativa, era capace di andare a rimbrottare il giornalista di turno direttamente a casa sua, o come minimo lo raggiungeva con una lettera di fuoco (che magari spediva per conoscenza anche al presidente degli Stati Uniti, al papa, al generale De Gaulle...). Se scorgeva una lite per strada, o un capannello di gente, vi s'infilava senza titubanze. E così via. Le sue baruffe più note e frequenti rimangono quelle con gli organizzatori di concerti e più ancora con i musicisti dei suoi gruppi. I quali ultimi, forse, più che rispettarlo lo temevano, proprio fisicamente (Mingus stesso confessò una volta ai genitori di Dolphy che Eric lo stimava come artista ma non come uomo). Celebri rimangono i knock out inflitti a Bobby Jones (salvo poi compiacersi per l'ottima musica che quella scarica di adrenalina aveva generato, [Nota 46] e soprattutto a Jimmy Knepper, che lo denunciò e ne ottenne la condanna [Nota 47]. In fase di istruttoria - come ricorda Knepper - "ogni volta Mingus raccontava una storia diversa, spergiurando se stesso, e per accattivarsi le simpatie del giudice di colore disse: Mi ha chiamato nigger" [Nota 48]. Non contento, pare sia arrivato a minacciare Knepper e famiglia, addirittura a spedirgli dell'eroina, avvertendo poi anonimamente la polizia.
Capitava anche - è ovvio - che si pentisse delle sue turbolenze, che facesse ammenda, salvo riesplodere alla minima scintilla. Tutto ciò ad eccezione degli ultimi anni di vita, durante i quali sembrò raggiungere un faticoso equilibrio, spesso lasciando così in chi lo avvicinava un'impressione di profonda umanità. La sua cieca intolleranza gli era stata del resto già perfettamente diagnosticata dalla prima moglie Lee-Marie ai tempi della convivenza à trois con un'altra donna: "Tu giudichi la gente e la butti all'inferno per una leggera deviazione, rispetto ai peccati che commetti tu" [Nota 49].
La verità è che Mingus era spesso succube di una visione distorta della realtà circostante. Poteva sentirsi vittima di complotti inesistenti, oppure - lui, così lontano da ogni conformismo - interpretare un'affabilità di circostanza come il segno della stima più incondizionata. Resta emblematico in tal senso un episodio tardo, relativo alla commissione della colonna sonora del film Todo Modo di Elio Petri, poi di fatto inutilizzata. Rimandando per una cronaca più dettagliata alle pagine 98/102 della citata biografia di Mario Luzzi, ripercorriamo per sommi capi l'accaduto. Mingus ebbe un primo incontro a Roma con Petri, che gli fece ascoltare Catalogue d'oiseaux di Messiaen, chiedendogli qualcosa di analogo. Mingus riscontrò marcate parentele fra questo pezzo e una sua composizione degli anni Cinquanta, "Revelations" (che in realtà nessuno conosceva) e ritenne la cosa fattibilissima. Si mise così al lavoro e tornò a Roma per incidere il tutto. Il che avvenne regolarmente, però fra crescenti perplessità di Petri, che giudicava il commento inidoneo al suo film. Mingus, in realtà, non si avvide di nulla, al punto che, rientrato in patria, rilasciò un'intervista in cui affermava: "Erano entusiasti della mia musica; erano risaliti a me grazie a un vecchio brano, "Revelations," che li aveva convinti che facevo al caso loro" [Nota 50].
Altri due episodi, concertistici, riferiti da Polillo confermano la visione particolarissima che il contrabbassista maturava circa ciò che gli accadeva. A un'esibizione milanese del 1964, arrivò in grande ritardo a causa di una notte insonne passata a suonare in jam session ("del tutto volontariamente," puntualizza Polillo). Al dissenso del pubblico per un prolungato dialogo fra lui e Dolphy, Mingus apostrofò gli incauti contestatori con queste parole: "Né io né i miei musicisti abbiamo chiuso occhio questa notte (...) e finché gli impresari ci tratteranno in questa maniera questa è la musica che voi potrete avere."
Il secondo episodio si riferisce a un altro concerto milanese di qualche anno dopo. Polillo: "Mingus non si attenne alle nostre istruzioni, secondo cui avrebbe dovuto tenere il contrabbasso a brevissima distanza dal microfono: così che si percepì a fatica, perse la pazienza per le proteste del pubblico, e disinnestò il microfono in modo che non si sentì più del tutto. A concerto finito chiese a me se non fosse possibile fargli avere in America un impianto di amplificazione come quello: l'aveva trovato eccellente" [Nota 51]. Dal tono di Polillo non si direbbe che si sia trattato di una battuta ironica.
Encore
Questo, anche questo, era Charles Mingus, artista carismatico e geniale quanto uomo bizzoso e controverso, che ha temuto forse più di ogni altra cosa la mediocrità e il silenzio. "Mingus potevi amarlo o odiarlo - chiosava sempre Susan Graham - ma non potevi rimanere indifferente a lui, questo è il succo del discorso" [Nota 52].
Queste pagine, che hanno inteso sondare l'uomo e le sue complesse molle comportamentali ma mai demonizzarlo, non possono che esserne la riprova più palpabile.
______________________________________
Note
1) La traduzione italiana dell'autobiografia di Mingus è stata pubblicata una prima volta dal Formichiere nel 1979, mentre l'edizione più recente è uscita da Baldini Castoldi Dalai nel 2005. In questo saggio ci riferiamo sempre all'edizione del '79.
2) LUZZI, Mario, Charlie Mingus, Roma, Lato Side, 1983, p. 29.
3) Mingus stesso ci informa peraltro che fin dai quattordici anni aveva letto il suo primo libro "su un certo Sigmund Freud" (Peggio di un bastardo, Milano, Il Formichiere, 1979, p. 14).
4) Op. cit., p.9.
5) POLILLO, Arrigo, Il jazz, Milano, Mondadori, 1976, p. 688.
6) Nelle vene di entrambi scorre in effetti anche sangue bianco: per Malcolm X è il nonno materno, mentre per Mingus il processo è inverso, avendo il nonno, nero, sedotto la padrona bianca, a sua detta addirittura cugina di Abramo Lincoln (vedi p. 94 dell'autobiografia). Per entrambi, sia quel che sia, tale presenza è come un tarlo, un'onta: è, in un senso come nell'altro, l'eredità dello stupratore bianco, una provocazione mai sopita a cui, giunti in età sessualmente attiva, entrambi risponderanno ambendo, per motivazioni magari anche più complesse, al possesso della donna bianca.
7) In particolare il sesto e il settimo, in Autobiografia di Malcolm X, Torino, Einaudi, 1967, pp. 90/133.
8) Questa come le successive osservazioni di Buddy Collette si riferiscono a una conversazione avuta con lui a Bolzano nel 1989.
9) Peggio di un bastardo, cit., p. 16.
10) FREUD, Sigmund, Tre saggi sulla teoria sessuale, in Opere, Torino, Boringhieri, vol. 4, 1970, p. 499.
11) FREUD, S., Frammento di un'analisi d'isteria, idem, p. 362.
12) FREUD, S., Il tramonto del complesso edipico, in Opere, cit., vol. 10, 1978, p. 30.
13) Per esempio alle pp. 15/16 e 83.
14) Peggio di un bastardo, cit., p. 15.
15) Sull'episodio è centrato il capitolo 19 dell'autobiografia, ma innumerevoli sono, lungo tutto il volume, i riferimenti di Mingus alla propria iperpotenza amatoria. Tanto per estrarne dal mucchio solo un paio, vediamo per esempio come a fianco di Cindy, non a caso la sua prima donna bianca, Mingus "si convinse di essere il più grande amante (...) mai esistito, e di avere il pirolo più lungo e grosso del mondo (p. 109). E a proposito di Donna, ancora una bianca, con cui condusse un singolare ménage à trois attorno al 1950, si legge a p. 171: "Donna e io quando facciamo l'amore riusciamo a venire insieme in sessanta maniere diverse." Salvo poi udire dalla viva voce di Susan, la sua quarta e ultima moglie (oltre che custode della sua memoria), che Mingus era passionale, sì, ma "per quanto mi riguarda (...) un amante come tanti altri" (in LUZZI, M., op. cit., p. 139).
16) FREUD, S., Frammento di un'analisi d'isteria, cit., p. 373.
17) FREUD, S., La testa di Medusa, in Opere, cit., vol. 9, 1977, p. 416.
18) FREUD, S., La scissione dell'Io nel processo di difesa, in Opere, cit., vol. 11, 1979, p. 560.
19) Vedi al proposito il primo capoverso del cap. 10 dell'autobiografia (p. 56).
20) Peggio di un bastardo, cit., pp. 103/4.
21) Ibidem, p. 27.
22) Ibidem, p. 94.
23) Ibidem, p. 25.
24) Ibidem, p. 27.
25) Tale posizione, per la verità, si stempererà col passar degli anni. E' sui diciassette quando, in una delle ormai frequenti avventure erotiche, "per la prima volta Charles si sentì totalmente accettato da un negro nero" (Peggio di un bastardo, cit., p. 70).
26) Ibidem, p. 52.
27) Ibidem, p. 26.
28) Ibidem, p. 16 e p. 14.
29) Ibidem, p. 17.
30) Ibidem, p. 103.
31) Cit. in LUZZI, M., Charlie Mingus, cit., pp. 116/19.
32) Peggio di un bastardo, cit., p. 93.
33) BALDARO VERDE, Jole, La psicologia nel momento educativo, Genova, Tilgher, 1974, p. 40.
34) Peggio di un bastardo, cit., p. 96.
35) BARAZZETTA, Giuseppe, in Libri nuovi, "Musica Jazz," febbraio 1980.
36) FREUD, S., Un ricordo d'infanzia da "Poesia e verità" di Goethe, in Opere, vol. 9, cit., p. 7.
37) Peggio di un bastardo, cit., p. 12.
38) Ibidem, p. 15.
39) Ibidem, p. 203.
40) Ibidem, p. 9.
41) Vedi nota 5.
42) ALBERTAZZI, Silvia, Per una 'lettura' di Charles Mingus, "Musica Jazz," agosto/settembre 1978.
43) JUNG, Carl Gustav, L'Io e l'inconscio, Torino, Einaudi, 1947, p. 35.
44) Peggio di un bastardo, cit., p. 88.
45) Cit. in LUZZI, M., Charlie Mingus, cit., pp. 128/30.
46) Vedi al proposito LUZZI, M., idem, p. 141.
47) Il grande trombonista ha dichiarato a chi scrive: "Quando penso a Mingus non so se guardare in su o in giù." Verso il cielo o verso gli inferi, insomma.
48) JESKE, Lee, Jimmy Knepper, "Down Beat," agosto 1981.
49) Peggio di un bastardo, cit., p. 215.
50) SMITH, A. J., Developmental Changes, "Down Beat," 12.01.78.
51) POLILLO, A., Mingus, in Stasera jazz, Milano, Mondadori, 1978, pp. 126/30.
52) Cit. in LUZZI, M., Charlie Mingus, cit., p. 131.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.