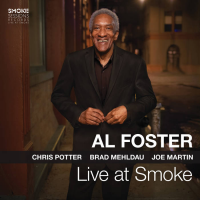Home » Articoli » Interview » Marco Cappelli: sulle corde dell'improvvisazione
Marco Cappelli: sulle corde dell'improvvisazione
Quando l'improvvisazione è "protetta" da un ambito stilistico solido, come avviene nel jazz, può essere di difficile esecuzione, ma non fa paura dal punto di vista concettuale. Quando invece la si affronta in campo aperto, stilisticamente parlando, allora
Abbandonata l'Italia, negli anni (e crediamo con fatica) Cappelli si è costruito una solida fama nella scena underground newyorkese, tracciando un percorso originale che poggia le sue basi (e la sua sostanza!) su moltissime "reazioni a catena" avute con gli "inesauribili" musicisti transitanti e sostanti a New York, di ogni latitudine, appartenenza, genere e sensibilità musicale. Indubbiamente la scelta di trasferirsi definitivamente in questa città ha ulteriormente favorito l'onnivoro desiderio di collaborazioni che proprio qui hanno trovato lo scenario giusto per realizzarsi.
I progetti che meglio rispecchiano questa atmosfera sono EGP (Extreme Guitar Project: 10 brani originali a lui dedicati da compositori della scena Downtown di New York), la partecipazione al quintetto di Jim Pugliese "Phase 3," la Go: Organic Orchestra diretta da Adam Rudolph e la band IDR - Italian Doc Remix.
Nel suo bagaglio, oltre ad un nutrito set di splendide chitarre, Marco Cappelli annovera un gran numero di collaborazioni con jazzisti e improvvisatori di varia estrazione (ad es. Anthony Coleman, Michel Godard, Butch Morris, Franco Piersanti, Jim Pugliese, Enrico Rava, Marc Ribot, Ellio Sharp, Giovanni Sollima, Markus Stockhausen, Cristina Zavalloni, Francesco Cusa), diversi ensemble (è chitarrista dell'Ensemble Dissonanzen ed è socio fondatore dell'associazione Dissonanzen) e orchestre (di recente ha partecipato alla Nublu Orchestra diretta da Butch Morris), nonchè numerosi festival.
Ha attualmente al suo attivo tre CD per chitarra sola: Fantasia per Ensemble, su musiche di Leo Brouwer e Yun Mu, EGP (Extreme Guitar Project: Music from Downtown New York), Los Angeles Tapes (Ictus Records, con Andrea Centazzo e Kato Hideki). Nel 2006 ha debuttato su Tzadik in duo con Jim Pugliese in Pushy Blueness di Anthony Coleman. Mode Records ha, inoltre, pubblicato due CD dell'Ensemble Dissonanzen, che vedono Cappelli coinvolto nell'esecuzione della musica da camera di Petrassi ed Henze. Infine, nel 2008, ha registrato per l'etichetta Itinera il CD IDR, dell'omonima band di cui è leader, con ospiti Marc Ribot e DJ Logic.
A voler ben vedere, una sua personale bussola questo versatile ed esuberante chitarrista ce l'ha ed è la curiosità. Curiosità, che nelle stesse parole di Cappelli si traduce nell'ascolto... recuperando così la lezione "classica" del maestro Oscar Ghiglia...
Indice Formazione Ensemble New York Progetti Strumenti
FORMAZIONE All About Jazz: Hai studiato al Conservatorio di S. Cecilia di Roma e successivamente, grazie ad una borsa di studio, ti sei diplomato alla Musik Akademie di Basilea, studiando, tra gli altri, anche con Oscar Ghiglia. In una intervista di AAJI fatta in passato ad alcuni chitarristi che hanno inciso per la Stradivarius (nella Guitar Collection) - Elena Casoli, Massimo Lonardi, Matteo Mela, Lorenzo Micheli, Antonio Rugolo - il nome di Oscar Ghiglia è ricorso varie volte. Mi piacerebbe sapere che maestro è stato per te Ghiglia e che importanza hanno avuto gli studi in Svizzera.
Marco Cappelli: Tra i vari maestri che ho avuto durante i miei studi di chitarra classica, Ghiglia è quello che mi ha lasciato l'eredità più profonda: senza alcun dubbio quello da cui ho imparato ciò che davvero ha fatto la differenza nella mia crescita musicale. Oggi la mia attività musicale quotidiana si esercita in un campo molto diverso da quello della chitarra classica tradizionale di cui Ghiglia è il re, essendo depositario di una delle tradizioni più nobili dello strumento: quella che fa capo alla lezione di Andres Segovia. Eppure, paradossalmente, il suo insegnamento mi guida ancora oggi nell'esplorazione di qualsiasi universo sonoro con il quale vengo a contatto. In altre parole, la chiave della sua lezione è stata giustappunto l'ascolto, nel senso più profondo che questo termine può avere in musica. Sembra scontato, ma ti assicuro che con un pò di attenzione e di umiltà ci si accorge che la capacità di ascoltare, qualità che non si finisce mai di perfezionare, fa difetto a tanti musicisti, e non solo... dal che si evince che tale lezione si può estendere alla vita in generale.
AAJ: Nel tuo percorso formativo mi sembra che l'interesse e l'entusiasmo verso il repertorio classico siano sempre andati di pari passo e senza conflitti d'interessi a quelli provati verso il repertorio contemporaneo (a prescindere dal genere). Nel costruire la tua sensibilità di chitarrista quali sono state le tappe davvero fondamentali e su cosa hai lavorato maggiormente?
M.C.: Il mio incontro-scontro con la chitarra classica è stato frutto inizialmente del caso e successivamente dell'ostinazione: per questo motivo ho impiegato diversi anni a trovare un terreno nel quale sentirmi me stesso, senza la forzatura di dover dimostrare qualcosa a qualcuno che ti deve rilasciare una patente. Purtroppo il mondo della chitarra classica - non per colpa dello strumento ma più verosimilmete per colpa del mondo accademico che se ne è impadronito - è, a mio giudizio, ricoperto da una patina di muffa che non lascia risplendere la bellezza delle pagine del repertorio.
Per questo motivo, credo, da ragazzino non mi sono mai sentito vicino a quel filone "romantico e malinconico" che ancora oggi è tanto celebrato, mentre la mia sensibilità mi portava a prediligere quelle pagine che non indulgevano al "bel suono" segoviano, ma piuttosto cercavano un'identità chitarristica aggressiva, irriverente, iconoclasta e, se vuoi, sgraziata: questa mi sembrava riflettere in modo più appropriato la mia percezione generale della realtà. Dunque la musica contemporanea che mi attraeva era quella più estrema: nell'aspetto concettuale, nella scrittura ed anche nella sonorità. Tuttavia, per arrivare a suonarla dovevo necessariamente passare per una serie di pietre miliari cosiddette "classiche," e dunque l'ho fatto, non sempre di buon grado e non sempre con brillanti risultati. Oggi però ne vado orgoglioso, e credo che quanto accumulato in quegli anni costituisca un'inesauribile riserva di riferimenti che non smetto di scoprire e che mi aiuta molto ad esempio nell'individuare una "mia voce" di improvvisatore. Per questo cerco di studiare Bach quotidianamente e torno molto più volentieri su un brano di Tarrega...
Ritorna all'indice
ENSEMBLE
AAJ: Una dimensione costante e di grande interesse nella tua storia musicale sono gli Ensemble. Inizialmente hai suonato con l'Ensemble S e l'Ensemble Opera Nova di Zurigo, l'IGNM e l'Ensemble dell'Elektronisches Studio di Basilea arrivando fino alla fondazione e al tuo vitale contributo per l'Ensemble Dissonanzen. Approfondiamo questo aspetto.
M.C.: Come chitarrista classico ho sempre vissuto come un punto d'onore quello di fare musica da camera, essendo la cosa nient'affatto scontata perchè la chitarra è uno strumento marginale nel grande repertorio cameristico. A parte pochi casi isolati in ambito classico, come i quintetti di Boccherini, è nel repertorio contemporaneo che la chitarra è stata usata con maggior pertinenza in ambito cameristico, poichè i compositori ne hanno via via inteso sempre meglio le caratteristiche idiomatiche, ed invece di usarla per imitare altro l'hanno utilizzata in virtù delle sue specifiche caratteristiche.
Nel lavoro di Ensemble mi hanno sempre attratto sia le pagine di repertorio consacrate (Le Marteau sans Maitre di Boulez, TKRDG di Scelsi, Seconda Serenata Trio di Petrassi...) che le prime esecuzioni di compositori con i quali collaborare: in questa seconda categoria, anche se non ci si imbatte sempre in capolavori, lo strumentista trova una palestra fondamentale per lo sviluppo tanto della tecnica quanto dei propri orizzonti estetici. A ciò si aggiunge, con l'Ensemble Dissonanzen, il lavoro sull'improvvisazione, nato forse per caso dalla necessità di trovare repertorio da suonare per la curiosa composizione del nucleo originario (sax, flauto, pianoforte e chitarra) ma con il tempo diventato un asse portante dell'attività di questo straordinario gruppo napoletano.
AAJ: Qual è stato il tuo contributo specifico nelle due registrazioni di musica da camera di Hans Werner Henze e Dalla Piccola e Petrassi che l'Ensemble Dissonanzen ha effettuato per Mode?
M.C.: Di Henze ho suonato, a parte i Drei tentos per chitarra sola, il trio per arpa, mandolino e chitarra intitolato Carillon, Recitatif und Masque e lo staordinario e poco eseguito Neue Volkslieder und Hirtengesänge per fagotto, chitarra e trio d'archi. Di Petrassi invece ho registrato la succitata Seconda Serenata Trio e la Sestina d'Autunno, pezzo davvero immortale. Dalla piccola purtroppo non ha scritto per chitarra, peccato...
AAJ: Hai voglia di raccontarci come è nata la tua collaborazione con l'Ensemble del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo per la registrazione di Fantasia per Ensemble e degli Estudios Sencillos di Leo Brouwer.
M.C.: Il primo anno che ho insegnato a Palermo decisi di tentare un corso di improvvisazione, inizialmente basato su ascolti guidati di dischi: all'epoca ritenevo che servisse senz'altro agli allievi, ma forse ancora di più a me. Il risultato fu che alla fine del corso i ragazzi erano entusiasti e vollero sperimentare nella pratica ciò di cui avevamo tanto parlato. Così pensai di partire da un materiale che conoscevano bene, gli Estudios Sencillos di Leo Brower, che smontammo letteralmente per ricomporli nella Fantasia per Ensemble aprendo larghe sezioni improvvisate. Cominciammo a fare concerti con l'Ensemble, attirando l'attenzione del Conservatorio, di qualche festival, dell'etichetta discografica Teatro del Sole (diretta a Palermo dal mitico Francesco Giunta) e della rivista Guitart che allegò il CD ad un suo numero: a quest'alchimia si deve una discreta diffusione dell'operazione. Al fine di avere un riferimento che giustificasse il lavoro mi sembrò opportuno registrare nel CD anche l'originale per chitarra sola e Brower, che ascoltò il lavoro a cose fatte, rimase entusiasta dell'operazione. Io dieci anni dopo penso ancora che si tratti di una bellissima esperienza didattica: tuttora mi capita ogni tanto di condurre un workshop nel quale rimetto su la Fantasia con un gruppo di studenti "freschi"... e c'è sempre tanto da imparare.
AAJ: Che ruolo deve avere per te l'improvvisazione all'interno di un progetto d'ensemble? In base alla tua esperienza esistono "metodi" e "regole" oppure l'improvvisazione è una dimensione, contatto o una modalità d'esecuzione che di volta in volta, di progetto in progetto, o di ensemble in ensemble, si va creando?
M.C.: Naturalmente dipende dal linguaggio. Quando l'improvvisazione è "protetta" da un ambito stilistico solido, come avviene nel jazz, può essere di difficile esecuzione, ma non fa paura dal punto di vista concettuale. Quando invece la si affronta in campo aperto, stilisticamente parlando, allora può talvolta prendere una sorta di horror vacui, che personalmente mi attrae molto dal punto di vista musicale, nel senso che pone dei problemi affascinanti la cui soluzione non è mai univoca. Quanto ai metodi di lavoro ce ne sono molti, ma la regola fondamentale è, ancora una volta, saper ascoltare.
Ritorna all'indice
NEW YORK
AAJ: New York: questa città rappresenta una vera e propria chiave di volta nella tua vita e nel tuo percorso musicale. Per prima cosa ti chiederei di raccontarci come l'hai vissuta i primi anni e se ancora oggi provi il medesimo entusiasmo.
M.C.: New York è una città incredibile, con un fascino planetario dovuto alla sua continua celebrazione in ambiti di comunicazione di massa, come ad esempio il cinema: in altre parole andandoci per la prima volta uno ha l'impressione di esserci già stato, e per questo è molto facile sentirla come casa propria. Grazie alla sua mancanza di identità - che la rende unica e paradossalmente ne restituisce un profilo dall'identità fortissima - appartiene a tutti e, difatti, il suo fascino sta nel fatto che vi si trova di tutto e il contrario di tutto.
All'inizio può essere repellente o sembrarti l'unico posto del mondo dove valga la pena di vivere: oggi riconosco che questi due approcci diametralmente opposti sono entrambi sbagliati, ma quando ci sono arrivato ne sono rimasto folgorato al punto da scegliere di viverci. Negli anni successivi allo sprint iniziale (quando cominci a capire che, sotto lo splendore che appare al turista, è anche una città molto dura) sono arrivato anche a detestare quello che definisco "il frullatore della vita quotidiana newyorkese". Oggi ritengo di aver trovato un equilibrio: ho imparato a viverci, riesco a gestire il perenne up and down, ho una famiglia e degli amici carissimi che mi fanno sentire davvero a casa mia. In una parola io adoro New York, ed è vero che le esperienze musicali che ho vissuto e vivo qui sono esattamente quello che stavo inconsapevolmente cercando da molti anni: in questo senso mi ritengo molto fortunato.
AAJ: Musicalmente New York rappresenta (o è?!) il cuore della musica creativa e d'avanguardia. Chiaramente e di conseguenza è stata teatro di un certo numero di incontri fondamentali nella tua vita, da Anthony Coleman a Butch Morris, Marc Ribot, Elliott Sharp, tanto per fare alcuni nomi. Quanto è stato importante poter suonare con loro dal vivo nei vari locali newyorchesi, Tonic incluso?
M.C.: New York è un playground per musicisti e per artisti in genere. Anche se è molto cambiata dagli anni d'oro dell'avanguardia, continua ad essere alimentata da un'energia starordinaria, che forse logora un po,' ma che ti fa crescere moltissimo perchè finisci per essere a contatto con un'infinità di persone in continuo movimento creativo. Anche troppo: a volte, infatti, sento la necessità di staccare e ritirarmi in qualche luogo isolato a studiare ed elaborare la quantità di stimoli accumulati.
La caratteristica musicale più affascinante è questa rete di luoghi underground dove si fa musica spesso di altissimo livello, con un pubblico che, grande o piccolo che sia, è sempre molto attento: questo conferisce un'aura di importanza anche all'ultimo dei concerti in una cantina. Fare parte di questo "giro," peraltro povero, è molto importante perchè proprio dalla frequentazione di questo articolato "laboratorio permanente" può scaturire un incontro musicalmente importante, un ingaggio o semplicemente un'esperienza fondamentale.
Il Tonic era il cuore pulsante della cosiddetta scena Downtown, ma purtroppo ha chiuso i battenti per sfratto diversi anni fa, seguendo la sorte di molti luoghi storici della musica: penso al CBGB, all'Amato Opera... una vergogna, poichè da allora lo spazio è inutilizzato e giace in stato di totale abbandono. Ma la scena musicale si reinventa continuamente e oggi, anche se più sparpagliata (per esempio a Brooklyn) è sempre molto viva e attiva in decine di altri locali.
Per quanto riguarda i nomi che hai citato, è vero che sono stati per me incontri fondamentali, così com'è vera la semplicità dei rapporti con musicisti di tale calibro e fama: quest'atmosfera molto "welcoming" è per l'appunto una delle caratteristiche più belle di questa città. Mentre scrivo, ho ancora nelle orecchie il suono "inconcepibile" dei due set della Nublu Orchestra diretta da Bucth Morris a cui ho partecipato stasera, nella quale suonavano tra gli altri Doug Wieselman, Graham Haynes, Kenny Wollesen e (udite udite!) Mauro Pagani...
AAJ: New York ospita tra i più importanti chitarristi della scena impro contemporanea. C'è qualche progetto, a parte l'Extreme Guitar Project di cui parleremo, che vorresti fosse realizzato a New York/con musicisti di New York?
M.C.: Di progetti me ne vengono in mente molti di più di quanti non ne riesca a realizzare, e del resto è ovvio venendo a contatto con così tanti artisti interessanti: sia americani, sia persone dalle origini più diverse che come me hanno deciso di stabilirsi qui o finanche gente di passaggio (tutti prima o poi passano per New York...). Una cosa che davvero mi piacerebbe fare, se me ne venisse offerta l'occasione, sarebbe curare la direzione artistica di un festival di chitarra: credo che sarei in grado di offrire una panoramica molto "speciale" sullo stato attuale dell'arte di suonare questo strumento.
AAJ: Negli ultimi anni hai inciso con Marc Ribot diverse cose. È imprescindibile che ti chieda di raccontarci della vostra collaborazione.
M.C.: Marc Ribot è prima di tutto un amico carissimo, e in secondo luogo un musicista geniale da cui ho imparato molto sia dal punto di vista strettamente tecnico che da quello concettuale. Inoltre, alla sua generosità devo gran parte della facilità con la quale mi sono inserito nella scena musicale newyorkese. Il tramite che ci ha fatto conoscere è stato la musica di John Zorn: in paricolare la raccolta The Book of Heads di cui Marc ha registrato l'integrale e dalla quale io ho scelto 10 brani che ho registrato nel mio primo CD per chitarra sola, Yun Mu.
Da quando vivo a New York abbiamo suonato molto in duo in maniera più o meno informale, e nel 2006/2007 abbiamo realizzato un progetto su Giacinto Scelsi con l'Ensemble Dissonanzen, che ha debuttato nientedimeno che al festival di Salisburgo. La prossima settimana cominciamo le prove di Caged Funked un'idea particolarissima che è venuta a lui mentre studiavamo una trascrizione per due chitarre della Sonata for Two Voices di John Cage. Cito testualmente, dalla sua presentazione:
In rehearsing for a performance of John Cage's "Sonata for Two Voices" (1933) at Issue Project Room last winter, guitarist Marco Cappelli and Marc Ribot made a strange discovery... by "looping" and repeating each difficult passage until it became easier, they became aware of a strange fact about John Cage's music that would have probably surprised (and possibly dismayed) the composer himself: John Cage was one funky dude!
Io mi sento lusingato dal fatto che Marc mi abbia voluto nella band accanto a mastri del funk, come Bernie Worrell, JT Lewis e DJ Logic... in un progetto che debutterà l'8 Luglio al festival di Ludwigsburg in Germania, e che si annucia come una vera bomba...
AAJ: Ma a questo punto, mi piacerebbe avere anche un tuo spassionato parere su John Zorn, padre (forse?!) della scena downtown, e della sua etichetta Tzadik.
John Zorn è un genio, sia detto senza giri di parole e al di là dei distinguo a cui la sua sterminata produzione artistica può dar luogo. Non è il padre della scena downtown, molto articolata a ben guardare da vicino, ma è uno grazie alla cui opera di produttore discografico - oltre che musicista - la suddetta scena è stata conosciuta nel mondo. Io, ad sempio, mi sono avvicinato alla realtà musicale newyorkese proprio ascoltando i dischi della Tzadik. Poi, una volta qui, ho scoperto tante altre cose...
Ritorna all'indice
PROGETTI
AAJ: Sicuramente il progetto più rappresentativo di/su New York per te è l'EGP ("Extreme Guitar Project: Music: Marco Cappelli plays music from Downtown New York"). Quanti anni hai lavorato per arrivare a costruire il percorso musicale sulla scena Downtown che hai regitrato? Ti sembra che possa dirsi rappresentativo della scena attuale o è piuttosto frutto del tuo percorso personale e dei tuoi gusti?
M.C.: EGP è nato per caso dalla mia voglia di mantenere un contatto con i musicisti che avevo conosciuto nel mio primo mese newyorkese nel 2002. Non avrei mai immaginato che da quell'idea sarebbe derivato il programma di concerto che ho suonato tanto, il CD per Mode Records e addirittura la serie di pubblicazioni che curo per Peters Edition.
A volerlo rifare credo che mi spaventerei, ed infatti la "seconda puntata" che ho in mente da tempo, tarda a vedere la luce. Invece allora tutto filò liscio come avviene spesso a causa della felice ingenuità del neofita. Mi sembra che a tutt'oggi sia un'efficace "fotografia musicale" della scena newyokese in quel determinato momento storico. Ovviamente oggi avrebbe bisogno di un aggiornamento, ed è appunto quello a cui sto lavorando...
AAJ: In Italian Doc Remix hai registrato un pezzo intitolato "In morte di Tony Soprano" che ha tutta l'aria di una marcia burlesca e beffarda, più che di un vero e proprio requiem... Hai voglia di raccontare come nato il pezzo e l'intero progetto registrato per l'etichetta Itinera di Pomigliano?
M.C.: "In morte di Tony Soprano" è una sorta di marcia funebre che ho scritto pensando a un funerale italo-americano nel quale mi sono imbattutto una volta nel Queens, dove una banda suonava seguendo il corteo con le donne vestite di nero disperate in prima fila. Con il massimo rispetto del dolore di quelle persone, pensai a quella tradizione tipica del paese di mio padre (Casalbuono, in provincia di Salerno) dove ci sono delle professioniste che vengono contrattate per "piangere professionalmente" ai funerali.
IDR (Italian Doc Remix) è un'idea mia e del percussionista Jim Pugliese, con il quale condivido la passione per la versione newyorkese delle feste popolari del sud Italia: nelle varie little Italy di Brooklyn, Manhattan e Bronx si può infatti assistere, nelle festività corrispondenti, alla festa dei Gigli di Nola, alla festa della Madonna dell'Arco e così via. Jim è nato in New Jersey, ma la sua famiglia è originaria di un paese dell'avellinese, e così una volta che eravamo in Italia insieme lo portai al Carnevale di Montemarano. In questi contesti ci capitò di osservere come nella musica popolare del sud ci sia un tipo di "improvvisazione rituale" che fa pensare al free jazz di personaggi come Albert Ayler.
Dalla ricerca della matrice comune a questi due mondi è nato il progetto, in cui suonano alcuni dei migliori improvvisatori della scena newyorkese (Josè Davila al trombone e tuba, Ken Filiano al basso e Doug Wieselman ai clarinetti), che non hanno mai ascoltato gli originali, ma ai quali è stato richiesto di improvvisare come "sentivano". Si scopre così che le origini portoricane del trombonista, quelle italiane del bassista e quelle ebreo-californiane del clarinettista portano ognuna con sè la memoria di una tradizione fecondamente distorta dal melting pot newyorkese. Questo è IDR, che ha appena concluso il suo primo felicissimo tour europeo tra Italia e Slovenia, convincendoci che è un progetto bellissimo da portare avanti: speriamo che si possa ascoltare presto in giro per i festival.
AAJ: Passando alla sponda opposta degli Stati Uniti, uno dei lavori tuoi che trovo in assoluto più stimolanti è Los Angeles Tapes con Hideki Kato e Andrea Centazzo, due monumenti della composizione/improvvisazione. Come avete lavorato assieme?
M.C.: Con Kato ho suonato molto nei primi anni che ero qui a New York, imparando come un musicista senza particolari doti virtuosistiche possa essere estremamente interessante sul piano concettuale, producendo musica davvero starordinaria. Una volta invitammo Andrea Centazzo come ospite a un nostro concerto a Los Angeles, dove Andrea risiede: si presentò con un set di percussioni stratosferico, uno studio mobile per registrare e della musica da farci leggere, trasformando noi in ospiti di un suo concerto. Pero' a dispetto del nostro turbamento, il risultato è molto bello come hai potuto ascoltare anche tu!
AAJ: Com'è nato il tuo coinvolgimento in "Pushy Blueness" di Anthony Coleman?
M.C.: Anthony l'ho conosciuto come tastierista di Los Cubanos Postizos, una delle band di maggior successo di Ribot, per scoprire successivamente che si tratta di uno straordinario compositore dalla sconfinata cultura, musicale e non solo, perfettamente informato sull'opera omnia di Ligeti come sul gossip hollywoodiano dell'ultima ora. È autore di uno dei brani dell'Extreme Guitar Project, il visionario "The Buzzing in My Head". Successivamente ho suonato con lui in un fortunato duo di improvvisazione, ed ho lavorato in ensemble ad altri suoi brani scritti, come "Mise en Abîme". "Township Jive" per chitarra classica e batteria, l'ho registrato con Jim Pugliese per il CD Tzadik Pushy Blueness. È un pezzo incredibile, dove la chitarra è trattata come una percussione armonica, intrecciandosi in un complesso contrappunto ritmico con la batteria, che non lascia respiro: un'opera assolutamente unica nel repertorio della chitarra.
AAJ: Jim Pugliese, oltre che percussionista straordinario, è anche fine compositore. Come lo inquadri nel panorama contemporaneo? Che spazio occupa "Phase III" su cui c'è anche un tuo contributo nel suo repertorio.
M.C.: Io e Jim abbiamo una felice alchimia musicale, alimentata da una profonda amicizia. Credo che l'innesco sia stato dovuto al fatto che tutti e due proveniamo dalla pratica della musica scritta, delle prime esecuzioni, dal lavoro diretto con i compositori. Jim ha un background impressionante, che va dalle collaborazioni con Cage, Glass e l'Harry Partch Ensemble, alla sua presenza costante in una gran quantità di dischi Tzadik: per me è stato ed è un punto di riferimento assoluto. Tra l'altro il suo progetto "Phase III" è stato il primo gruppo dove sono stato chiamato a suonare qui a New York, avendo finalmente occasione di esplorare con l'elettrica una dimensione di suono aggressiva, distorta e molto ritmica.
Mi fa piacere che tu dica che si sente la mia presenza come un contributo: quello che è certo è che io ho imparato moltissimo dall'esperienza di Phase III.
Ritorna all'indice
STRUMENTI
AAJ: Mi pare opportuno chiudere questa intervista gettando uno sguardo anche alla tua officina sonora. Possiedi diverse chitarre e tutte loro, come vere e proprie compagne di strada e di vita, hanno una loro appassionante storia. Hai voglia di raccontare per i lettori di AAJ la storia dell'Uboingee, della Extreme Guitar, della Honer delle "signore" Busardò, Marseglia e Scandurra?
M.C.: Guarda, se mi metto a parlare dei miei strumenti con la stessa cura con cui ho cercato di rispondere alle tue domande non la finiamo più... come tu hai notato, ogni strumento ha una sua storia, legata peraltro anche in questo caso a degli incontri fatali: Mark Stewart per l'Uboingee, Renato Barone e soprattutto Alessandro Marseglia per la cosiddetta Extreme Guitar (nonchè per un'altra meraviglosa chitarra classica) ... queste storie le racconto nella sezione chitarre del mio sito: a quella rimando i lettori che volessero approfondire questo aspetto feticista!
AAJ: Nuovi amori in vista?! Stai progettando altre chitarre?
La voce "chitarre" è la principale uscita nel mio bilancio economico (per altro spesso totalmente squilibrata rispetto all'entrata!), e dunque trattandosi di una sorta di addizione, è in continuo divenire, ahimè.
Attualmente aspetto con ansia dalla California una Gretsch, modello Chet Atkins, che mi è indispensabile per curare la grave infezione da Surf Music che ho preso suonando in trio con il batterista Francesco Cusa ed il bassista Luca lo Bianco nel cosiddetto Marco Cappelli Surf Trio. Vedi, navigando per questi mari il concetto di "indispensabilità" si evolve in maniera molto curiosa...
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.