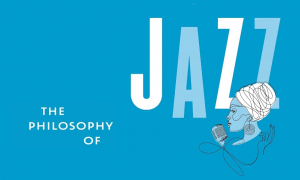Home » Articoli » Lyrics » Lee Konitz, poeta dell'ultravioletto
Lee Konitz, poeta dell'ultravioletto
Innanzitutto sgombriamo il campo da un possibile malinteso. Lee Konitz non è degno di essere celebrato perché compie ottant'anni, ma perché è una delle più straordinarie personalità che abbiano attraversato la storia del jazz. Il fatto che questa traversata sia giunta a una soglia tanto cospicua è, per dir così, accessorio; essenziale è invece che questo sassofonista continui tuttora a rappresentare, come ha fatto negli scorsi sessant'anni, uno dei grandi punti di riferimento per chiunque si interessi del linguaggio jazzistico.
Uno dei tanti luoghi comuni, duri a morire, che circondano il jazz riguarda appunto la "durata" artistica dei musicisti, che di solito viene fissata intorno ai dieci anni. Louis Armstrong fu grande negli anni Venti, poi perse ogni importanza; Fletcher Henderson guidò il linguaggio orchestrale dal 1924 all'inizio dello Swing; Lester Young nel dopoguerra - dieci anni dopo le sue prime incisioni - era l'ombra di se stesso; Charlie Parker morì giovane, ma era già appassito dalla fine degli anni Quaranta; John Coltrane è emerso assai tardi, proprio un decennio prima della morte... l'elenco potrebbe continuare a lungo.
D'accordo: i jazzisti subiscono, e soprattutto hanno subito per lungo tempo in passato, condizioni di lavoro profondamente logoranti, stretti fra le esigenze del musical business e le richieste degli standard artistici; ma questa mistica numerologica è un po' troppo sospetta. Se si osservassero le loro carriere dall'interno, senza presumerne un'artificiosa immobilità stilistica, spesso le cose cambierebbero. Armstrong, pur dando vita a incisioni più "commerciali," ha influenzato migliaia di solisti (tra i quali grandi innovatori) per tutti gli anni Trenta, e ancora alla fine degli anni Quaranta inventava nuove formule sonore; Henderson ha dato vita a impasti orchestrali di elegante originalità fino alla fine della carriera, nel 1950; le incisioni degli anni Cinquanta di Young sono di un'incomparabile intensità emotiva, e ogni volta rinnovano il linguaggio del sassofonista; fra il 1950 e il 1955 Parker esplorava frammentazioni ritmiche inedite, che già preludevano al free jazz; eccetera.
Il fatto è che fino a un certo punto, nella storia del jazz, la critica era cieca e sorda nei confronti di queste "deviazioni," così come l'occhio umano non vede l'ultravioletto. C'è voluta una sorta di rivoluzione culturale per allargare lo spettro della comprensione estetica; e questa rivoluzione è stata una delle tante "ricadute" giunte con la svolta del jazz moderno, negli anni Quaranta. Da quel momento non è più stato possibile considerare il jazz un fenomeno espressivo omogeneo, ma un'arte complessa, nella quale convivono (e si sanano) contraddizioni apparentemente insuperabili.
Fra i primi musicisti che hanno permesso questo copernicano cambio di prospettiva si conta proprio Lee Konitz. I suoi assoli d'esordio, col senno di poi, mettono già in piena evidenza tutto ciò. Al suo ingresso sulla scena newyorkese, ventenne, Konitz viene subito definito "l'unico giovane sax contralto che non suoni come Charlie Parker," affermazione avallata (e in senso fortemente elogiativo) dallo stesso Parker. Il bello è che questa fama nasce proprio dall'operato konitziano su due temi del rivoluzionario sassofonista nero, Anthropology e Yardbird Suite, arrangiati da Gil Evans per l'orchestra di Claude Thornhill.
Quei brani sono ancor oggi impressionanti. Non solo il solista s'inventa un linguaggio del tutto estraneo a quello parkeriano e lo adatta alle sottostanti strutture bop, ma ha già messo perfettamente a punto un vocabolario nel quale ogni elemento (timbro, frammentazioni ritmiche, sviluppi melodici, densità armonica) è in coerente equilibrio con tutti gli altri; e l'insieme che viene così formandosi si confronta in assoluta parità con il modello, di fresca fattura, del complicatissimo bebop (si ascolti come nel secondo brano Konitz si avventuri in tutta souplesse nei meandri di un cromatismo ai confini con l'atonalità).
Non meraviglia che, subito dopo, Konitz sia chiamato a partecipare (e da posizioni preminenti) ad alcuni dei principali esperimenti di fine decennio, in particolare con il nonetto di Miles Davis e il quintetto di Lennie Tristano. Ma realizzando celebri capolavori in questi gruppi egli non si appiattisce certo nel ruolo di grande sideman. Già nel gennaio 1949 incide a proprio nome, mostrando autonome e rilevanti ambizioni. Un brano come Retrospection non è solo una raffinata riflessione sul These Foolish Things realizzato da Lester Young tre anni prima, ma è anche la programmatica messa in gioco (senza alcun sentimento d'inferiorità) dei piani d'intersezione fra jazz "d'avanguardia" e tradizione europea.
A questo punto l'immagine di Lee Konitz si è definita. Egli non è solo l'anti-Parker, ma senza dubbio il sassofonista di punta del cool jazz. La convenzione jazzistica vorrebbe che egli sviluppasse la propria carriera lungo queste coordinate (e non si contano, ancor oggi!, le definizioni che lo incasellano esattamente in quel punto). Ma già alla metà degli anni Cinquanta si è smarcato dal pur nobile stereotipo. Rinnegando ciò che di snobistico si può intravvedere nell'altissima esperienza tristaniana, Konitz afferma, al fianco di quelle del cervello, le ragioni del cuore e delle guts, la "pancia," trovando nuove corrispondenze (ancora una volta su un piano di totale autonomia) con l'estetica del bebop più "nero".
Partendo da questi nuovi parametri, una strada porta dritta al capolavoro del 1961, Motion, in trio con il contrabbasso di Sonny Dallas e la batteria di Elvin Jones: album fortemente segnato dall'esperienza di Sonny Rollins, eppure come al solito di formidabile autonomia espressiva. Ma Konitz non si relega mai in un'unica dimensione. Negli stessi anni s'ispessisce la riflessione (notevole proprio perché legata alla rivalutazione della "pancia") sui rapporti con la tradizione europea. Amante di Bach, Bartok e Berg, all'inizio degli anni Cinquanta egli suona più volte nel Vecchio Continente e diviene il musicista di riferimento per un'intera generazione di giovani jazzisti (soprattutto nell'area che comprende Germania e Scandinavia), grazie proprio al legame organico fra le ricerche dell'improvvisazione afroamericana e le austere riflessioni dei grandi compositori di questa parte dell'Atlantico. D'altra parte, la stessa ansia di ricerca lo porta in quel decennio a collaborazioni di grande rilievo con musicisti tanto diversi quanto Charles Mingus, Stan Kenton, Gil Evans (anch'egli rinnovato), Bill Russo.
Si può dire che proprio con Konitz si affermi l'immagine del jazzista "intellettuale," opposta a quella in auge negli anni Venti e Trenta del jazzista "istintivo," senza alcuna istruzione accademica. Siamo naturalmente di fronte a due luoghi comuni uguali e contrari, ma qui c'interessano per quella parte di verità che (come tutti i luoghi comuni) rappresentano, almeno simbolicamente; ed è notevole che Konitz anticipi di almeno un quinquennio colui che poi incarnerà definitivamente la "sensibilità europeizzante" nel jazz moderno, ovvero Bill Evans. Così come è notevole la consonanza fra i due che li porterà più volte a suonare insieme, dal leggendario concerto allo Half Note del 1959 (infine pubblicato trentacinque anni dopo) almeno fino a Crosscurrents, inciso a nome del pianista nel 1977.
Ma, ancora una volta, Konitz è unico. Nel suo "intellettualismo" riconosciamo quello che possiamo chiamare il modello evansiano (basato soprattutto sull'importanza data alla componente armonica, nella quale la complessità si sposa con un'intensità emotiva di derivazione tardoromantica; ma in cui è fortissima anche la tensione ritmica, che serve proprio a "sciogliere" ogni sospetto di decadentismo); però c'è anche una tendenza molto diversa, che possiamo affiancare a un'altra grande figura di intellettuale del jazz contemporaneo: Steve Lacy.
Lacy e Konitz sono quasi due gemelli in musica, ed è un peccato che non abbiano mai veramente intrecciato i loro strumenti. Su disco sono fianco a fianco solo in alcuni lavori di Gil Evans, nei quali però Konitz non interviene mai come solista. Ed è impressionante che proprio con loro due, separatamente, Evans abbia firmato i suoi tardi lavori più intimi e "nudi," magnifici duetti piano-sassofono che meritano di essere confrontati con attenzione. Il "modello Lacy" si basa sull'essenzialità assoluta, sui concetti di avanguardia e di sperimentalità così come si sono configurati in Europa nel corso del Novecento, ma anche su un supremo sense of humour che relativizza ogni eccesso.
Questa ennesima sfaccettatura konitziana realizza il proprio manifesto con The Lee Konitz Duets, vero e proprio concept album del 1967 in cui ogni brano e ogni partner rappresenta una diversa area d'interesse: anche qui, come già abbiamo visto nel caso di Bill Evans, Konitz in effetti anticipa la tendenza incarnata soltanto negli anni Settanta da Lacy. Va notato che ventisei anni dopo Konitz ha firmato una specie di remake di quel disco con Rhapsody, in cui si confronta con le generazioni emerse nel frattempo sulla scena del jazz; ma con il quale sembra anche dichiarare, ironicamente appunto, quanto labile può essere la "storicità," l'"unicità" di queste incisioni.
Nel 1967 Konitz compie quarant'anni, ma le sue ricerche non si esauriscono affatto. Si apre anzi una fase ancora diversa, nella quale il sassofonista approfondisce la dimensione intima del duo non più, come in Duets, divaricata a coprire la più ampia area espressiva possibile, ma al contrario per concentrare il nucleo più puro dell'invenzione. Il risultato forse più impressionante di questa ricerca, sul piano concettuale, è 12 Gershwin in 12 Keys con Franco D'Andrea, del 1988, che rivisita i maggiori standard del grande compositore in tutte le tonalità, quasi a edificare un proprio personale Gershwin ben temperato. E anche qui fa capolino lo humour konitziano: un'impresa del genere è eseguita dal vivo in una sera, senza programmazione, quasi con la potenza gestuale dell'action painting.
Perché, accanto al sofisticato intellettuale, in Konitz convive il performer "spontaneo" secondo i vecchi, consunti canoni. C'è anche, diciamo, il "modello Johnny Griffin," quello del solista che passa di piazza in piazza con il proprio strumento, accompagnato da musicisti locali, felice di rivisitare i grandi classici del jazz e di sfidare la routine: un termine che spesso è stato ingiustamente utilizzato con Konitz negli ultimi trent'anni, senza analizzare appunto la quantità di rischio necessaria nel perpetuare creativamente la gloriosa tradizione del "repertorio comune" (e la scarsissima quantità di occasioni nelle quali la routine c'è stata davvero). Anche qui c'è un musicista che può essere affiancato a Konitz: il sublime Paul Bley dell'estrema maturità, che ignora ostentatamente ogni programmazione, ogni prova, per affrontare direttamente, sera dopo sera, i fantasmi della memoria e dell'inconscio. E non stupisce che il loro incontro (significativo fin dal titolo: Out of Nowhere, del 1997) abbia dato risultati altissimi.
Ripercorrendo la personalità di Konitz si è sviluppata una lunga collana di figure di riferimento che tracciano l'intera storia del jazz moderno. Altre potrebbero essere citate, per venire sempre più vicini ai giorni nostri: Ornette Coleman (con cui Konitz ha suonato in una memorabile serata di Umbria Jazz, nel 1998), Anthony Braxton (che si professa suo allievo e ha inciso con lui in uno storico disco di Dave Brubeck del 1974), John Zorn (che ne riprende l'eversiva pluralità), Brad Mehldau (che nel 1997 ha dato vita con lui e Charlie Haden a una sorprendente "super jam session," in cui ne sapeva magnificamente cogliere il più intimo afflato emotivo). Ma il risultato è ormai trasparente. Lee Konitz non ha mai cessato di crescere e di inventare. Per questo, fresco dei suoi ottant'anni, si dimostra uno dei massimi giganti di una storia musicale in continuo divenire.
Foto di Dario Villa (le prime due).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.