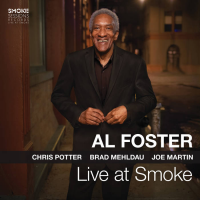Home » Articoli » Lyrics » John Cage - caso vs. improvvisazione
John Cage - caso vs. improvvisazione
John Cage: Caso vs. Improvvisazione. Un'esperienza di laboratorio d'improvvisazione musicale per (non)musicisti [Nota 1]
« Se tu vuoi un amico addomesticami! » « Che bisogna fare? » domandò il piccolo principe. « Bisogna essere molto pazienti », rispose la volpe. « In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino... » [Nota 2]
John Cage è stato un grande musico-terapeuta. Tutte le espressioni del suo pensiero musicale - siano esse strutture di suoni, progetti meta-teatrali, scritti metapoetici, dialoghi o interviste - testimoniano, con paziente fedeltà e rigore, una volontà consapevole del ruolo insostituibile che la musica ricoprirebbe nelle società contemporanee se non fossero programmaticamente eluse le sue potenziali doti maieutiche. Pochi prodotti della creatività umana hanno, incontrando le rivoluzioni epocali del secolo passato, manifestato mutazioni così sconvolgenti quanto poco percepite dalla collettività:
"Una signora mi disse: vivo nel Texas. Non abbiamo musica nel Texas. La ragione per cui non hanno musica nel Texas è perché hanno registrazioni nel Texas. Eliminate le registrazioni dal Texas e qualcuno imparerà a cantare. Chiunque ha una canzone che non è per niente una canzone: è un processo per cantare (...)"[Nota 3]
L'avvento dei mezzi di riproduzione fonica - e l'applicazione di questi ai prodotti dedicati alla visione: cinema, televisione e derivati - ha segnato ineludibilmente il destino dei linguaggi musicali, consegnandoli coattivamente, e totalizzandone il ruolo di ostaggio, all'universo degli oggetti-merce. Il cosmo-mercato ne ha colto i poteri endemici - seduzione, persistenza nella memoria di oggetti e situazioni correlate, orientamento psico-emotivo, amplificazione del messaggio promozionale - e li ha sfruttati sia nell'uso della musica applicata ad ogni tipo di oggetto-merce, sia proiettando essa stessa nella dimensione esclusiva dell'oggetto di consumo. La difficoltà, da parte di un'utenza sempre più massificata, nel seguire gli sviluppi rivoluzionari delle avanguardie musicali del '900, spesso associata ad un loro artificioso allontanarsi da aspetti considerati 'naturali' - l'armonia tonale, la regolarità ritmica, la cantabilità melodica ecc. - è altresì in gran parte da addebitarsi al processo di omologazione globale che - forzosamente - ha subito il senso dell'ascolto musicale.
Se John Cage ha posto, al centro delle sue ricerche, l'ascolto, lo ha fatto considerando lo stato patologico verso cui questa essenziale funzione umana è stata tradotta in seno alle civiltà di mercato. Occuparsi dello stato di salute dell'ascolto, del suo annichilirsi nello stereotipo dell'udire inconsapevolmente passivo ha significato per Cage, e per molti altri musicisti dei movimenti che si sono posti in dialettica col sistema, contrapporre non solo un altro, nuovo modo d'intendere la musica, ma anche - e spesso soprattutto - esprimere proprio quelle forme sonore situazionisticamente atte a costringere l'uditorio a riflettere proprio sul divenire patologico dell'esperienza dell'ascolto: Il Re è nudo.
Ma Cage resta unico nel rigore 'ecologico' con cui, da anarco-umanista seguace delle dottrine di Thoreau [Nota 4], ha interpretato il suo ruolo di musicista come taumaturgo dei suoni, sino alla fine perseguendo l'utopia che il curare l'ascolto fosse sinonimo, per via ultra-politica, del curare la società. È leggendo tutta l'opera di Cage in questa accezione che ne viene evidenziata e chiarita la sua unicità.
4'33'' [Nota 5] di silenzio per pianoforte, probabilmente la sua opera più celebre, fu a lungo letto come atto iper-provocatorio, qualcosa che declinava con gesto metateatrale e quasi-clownesco, il detto tutto sommato ancora diffuso: "la musica è morta". 4'33'' è senz'altro un gesto 'provocante,' ma la sua vera funzione è sì di attivare nel pubblico degli astanti, attraverso la tensione dell'aspettativa - disattesa - di un suono da udire, l'ascolto attivo, ma soprattutto di rivolgere questo stato dell'esperienza - sempre più raro - eccentricamente rispetto all'attrazione del palcoscenico, (ri)portarlo quindi all'habitat, all'essere sé - presenti nel rito collettivo attraverso una nuova profondità di campo nel percepire inconsuetamente i suoni a noi consueti di un pubblico che si muove, bisbiglia, tossisce, mugugna, protesta immerso nell'habitat sonoro della sala da concerto, l'impianto di condizionamento, il traffico della città attutita, la pioggia forse...
E questo solo il silenzio lo consente. Ma non un silenzio nichilista, decadente, dettato da un'estrema e sottile forma di narcisismo d'artista - come spesso è stato considerato - ma al contrario un'assenza di atti sonori da parte del pianista di servizio al vero progetto performatico, che ribaltando con un gesto di semplice astensione i ruoli di attore-attivo e spettatore-passivo canonici al nostra cultura, consente un'esperienza estranea agli eventi spettacolari delle società occidentali, più vicina - se si vuole - al teatro rituale proprio ad altre culture (in special modo quello legato ai riti animistici africani [Nota 6]), ove proprio il confondersi delle funzioni di attore e di spettatore veicola il potenziale catartico, quindi terapeutico, del rito conchiuso nel cosmodromo del villaggio, della piazza, del luogo deputato all'azione collettiva. Se il silenzio consente la possibilità di (ri)appropriazione della funzione dell'ascolto attivo, funzione perduta nel mare magnum delle fono-stimolazioni ripetitive e alienanti generate dal corollario di apparecchiature fono-riproducenti che riempiono sino alla saturazione la nostra vita, è vero che Cage non suggerì mai l'estraniazione dall'universo dei suoni mondani, anzi propose numerosissime pratiche di osservazione critica del paesaggio sonoro, sostenendo che nessun suono (ad eccezione di quelli associati agli strumenti di guerra e di morte) fosse da discriminare, ma, bensì, da contemplare nel suo porsi in contrappunto dialettico con gli altri e, se mai, egli ci stimolò a procedere - attraverso la presa d'atto di coscienza - verso paesaggi sonori più congeniali, selettivi alle proprie esigenze psico-auditive. In questo senso si colloca il grande interesse che Cage rivolse ai procedimenti casuali utilizzabili per produrre strutture sonore.
Contrapponendo il caso alla volontà creativa Cage accredita alla dimensione dell'ascolto il ruolo centrale nella produzione di senso che si sviluppa nell'esperienza della percezione dei suoni, e in tal modo garantisce, a tale esperienza, la purezza sperimentale di una fruizione strutturalmente lontana da pigrizie determinate dall'abitudine a porre attenzione ad un campo limitato di elementi al cospetto dei quali ci sentiamo di spendere la parola musica. In realtà Cage riflette assai sul ruolo cruciale che gli ascendenti culturali giocano nell'attuarsi di tale processo interpretativo, e il fil rouge del suo operare taumaturgico s'identifica con un continuo scoprire il nervo dei condizionamenti che tendenzialmente atrofizzano la curiosità verso il nuovo, cristallizzando l'ascolto nella dimensione ninnolante della (auto)gratificazione narcisica a perdersi nel già udito. Nell'alterno e dubbioso interesse di John Cage nei confronti dell'improvvisazione si esplicita con evidenza palese questa insofferenza a tali condizionamenti [Nota 7].
Al centro di movimenti artistici che molto avevano puntato sui processi creativi irriflessi nella credenza che il sorgivo emergere dell'improvvisa-azione potesse emancipare - nell'utopia di un possibile ritorno alla libertà - la ricerca del nuovo, egli ha ripetuto sino alla noia che improvvisare senza un progetto, una linea direttiva, una struttura di contenimento - meglio se configurata da leggi casualistiche - fatalmente espone al pericolo della pratica di strade abusate, alla reiterazione - peggio se inconsapevole - dei percorsi abitudinari.
È proprio a partire da questi assunti che sembra irrinunciabile un excursus all'interno del Cage-pensiero nel lavoro di formazione musico-terapistica, ove l'approccio alle pratiche musicali legate all'improvvisazione va indirizzato nel senso dello sviluppo di un particolare strumento relazionale - ove il linguaggio verbale sia precluso o fortemente condizionato - e non già a sviluppare forme musicali tese a perseguire scopi estetico-virtuosistici, come avviene nelle musiche come il jazz e le musiche di tradizione europea ed extraeuropea che fanno uso strutturale dell'improvvisazione. Chi si pone davanti ad un altro individuo - o a un collettivo di individui - nel tentativo di accedere ad una via comunicativa fortemente compromessa, e lo fa usando come strumento l'articolazione dei suoni in strutture musicali (in senso lato), dovrebbe, in linea di principio deontologico, saper partire da una sorta di grado zero del linguaggio musicale, deprivandosi delle proprie predilezioni e competenze musicali per disporsi all'ascolto silenzioso e attivo, e, d'altra parte, approntarsi alla improvvisa (re)azione al minimo segno di articolazione sonora proposta; sapersi, quindi, aprire all'altro da sé, alle forme comunicative che gli sono più congeniali, e soprattutto al nuovo che sorge dall'incontro di differenti sensibilità, senza pregiudiziali estetiche.
Ecco un campo in cui l'improvvisazione si attua come atto esclusivamente sperimentale, al quale è quindi richiesto un procedere programmaticamente esplorativo, anche se criticamente attento ad incoraggiare gli aspetti realmente progressivi nello sviluppo della relazione sonora: una sperimentazione libera, da un lato quanto, d'altra parte, eticamente super-controllata. Sembra importante, quindi, attivare durante la formazione musico-terapistica un processo di critica all'improvvisazione come strumento di lavoro che consenta via via di affrancarla quanto possibile dagli abiti mentali che fisiologicamente la condizionano, e in questo senso l'opera di Cage ci fornisce davvero un vasto territorio di riflessione e di pratica.
Un'opera in particolare, il Concert for Piano and Orchestra [Nota 8], può essere utile strumento di laboratorio per esemplificare, e concentrare in sé, tutti i punti sin qui argomentati. Vale la pena di descriverne i tratti salienti. Una vera e propria partitura orchestrale non esiste. Cage ha predisposto una collezione di spartiti che ha intitolato Solo for... seguito dal nome dello strumento a cui è dedicata la parte individuale. Le pagine degli spartiti contengono tutte un sistema di cinque pentagrammi e, senza indicazioni di tempo o segni di battuta, si risolvono in una sequenza di suoni - nella rappresentazione grafica di semplici 'pallini' - disposti in modo tale da lasciare tra loro spazi bianchi - s'intuisce silenziosi - di varia misura. Le note scritte fanno riferimento alla chiave tradizionalmente usata dallo strumento in questione e il 'pallino' che indica la nota si articola in tre 'taglie': piccola, media e grande. Le taglie possono indicare sia valori di durata che valori di intensità, a piacer dell'esecutore, e nella legenda che correda ogni parte è specificatamente chiarito che l'esecutore può scegliere di eseguire i suoni che vuole all'interno di ogni pagina , sottintendendo gli altri; può scegliere le pagine che vuole, nel numero e nell'ordine che vuole, anche (clamorosamente!) nessuna. Prima di comprendere come questo impianto venga poi messo in moto dall'esecuzione collettiva dell'opera, può essere utile soffermarsi un momento su questi primi aspetti. Se facciamo mente locale alla modalità di produzione musicale propria alle compagini orchestrali della musica colta occidentale, balza subito agli occhi quanto questo approccio sia sottilmente provocante.
Lo strumentista d'orchestra è abituato all'irreggimentazione dell'azione musicale imposta dalle caratteristiche proprie alla nostra notazione musicale: unità di tempo e di battuta, fedeltà alla parte scritta, poche o nulle agibilità alla scelta interpretativa personale, se non, raramente, in qualche a solo per il quale il compositore abbia presupposto un fraseggio liberamente solistico. Il Concert sovverte tutto ciò chiamando il singolo orchestrale, invece, ad uno smembramento e ricomponimento della parte a proprio piacimento, sin all'estrema conseguenza dell'astensione totale; anche l'effettiva esecuzione delle suoni notati può subire clamorose mutazioni determinate da differenti interpretazioni delle dimensioni delle note scritte e, al limite, prevedere per ogni esecuzione data dallo stesso organico possibilità di scelte molteplici con di fatto molteplici esiti possibili.
Ancora, come si vede, l'improvvisazione non entra in campo: lo strumentista pre-dispone le sue scelte e, all'atto esecutivo, non dovrebbe venir meno alla fedeltà al testo da lui ricomposto. Il problema del coordinamento temporale di tutte le parti d'orchestra è risolto sì dalla presenza di un direttore, ma che invero non ha possibilità di controllo diretto sui singoli atti musicali, come doverosamente avviene nello svolgersi di una esecuzione orchestrale tradizionalmente intesa. I singoli strumentisti sono chiamati, una volta scelti i suoni da agire, ad indicare sulla loro parte un tempo preciso di attacco di ogni singolo evento sonoro basandosi sulle proporzioni degli spazi tra i segni grafici, e inquadrando tale scelta all'interno di una durata totale dell'esecuzione dichiarata in anticipo dal direttore (che Cage consiglia essere tra i 20 e i 30 minuti) e A questo punto basterebbe usare un cronometro visibile da tutti e, di fatto, il direttore mima il movimento di un contasecondi ruotando le braccia - uno alla volta - in senso orario [Nota 9]. Ma il tempo di scorrimento del braccio-lancetta-dei-secondi non segue regolarmente l'effettivo tempo cronometrico. La 'partitura' del direttore è, in effetti, una tabella che a varie porzioni del tempo assoluto associa misure di tempo relativo assai cangianti: a volte più veloci, a volte più lente, a volte corrispondenti.
Il direttore stesso può scegliere preventivamente un percorso 'personalizzato' all'interno della tabella che, quindi, può effettivamente cambiare ad ogni esecuzione all'insaputa degli strumentisti mutando, a sua volta, le sorti del prodotto sonoro. Tutto l'insieme delle scelte prefissate da strumentisti e direttore concorrono a generare, quindi, una struttura di suoni che nel suo insieme resta, però, criptata a tutti sino al momento dell'esecuzione; essa quindi ha valore di unicum, e per ciò di primo ascolto anche per gli stessi interpreti, oltre che ovviamente per il pubblico.
L'unico personaggio che possiede l'abilitazione al libero arbitrio estemporaneo - quindi ad un'azione per certi aspetti improvvisata - è il pianista. Anch'egli attinge da una collezione di pagine a lui dedicate intitolate Solo for Piano, e anche lui può scegliere quali pagine o porzioni di esse - anche nessuna - utilizzare; solo che la sua azione temporale, e la libertà concessagli nell'uso dei suoni all'interno delle pagine stesse, differentemente da tutti gli altri performer, è libera di reagire a ciò che ascolta, cercando, pur nel percorso parzialmente preordinato, di intavolare un dialogo sonoro con l'espressione delle molteplicità individuali cristallizzate nell'ordinamento precostituito. Se ci pensiamo il pianista del Concert recupera, con un singolare salto mortale, il ruolo eroico che gli compete nella letteratura romantica dei concerti per pianoforte e orchestra così interessati - e idonei - a rappresentare il mito dello scontro prometeico del solo (individuo) contro il tutti (massa-natura). Lo fa, nel nostro caso, nel manifestarsi come incarnazione dell'ascolto attivo ideale, esempio offerto a pubblico e performer di come tale dimensione sia un attentissimo e continuo interagire interiore con il percepito, ben al di là di una didascalica manifestazione di partecipazione sonora, o fisica. Diremmo invece che è un'attitudine, un orientamento psicodinamico che rappresenta la fatica - e la fragilità -della relazione colta nel suo atto di nascita, quindi intesa come atto puramente sperimentale.
È il Concert for Piano and Orchestra, un ordigno poliedrico che sembra progettato per mettere in crisi, e quindi accendere in riflessione dialettica, numerose categorie della nostra tradizione musicale colta; e lo fa, come si dice, dall'interno del sistema: l'orchestrale chiamato ad un lavoro ricompositivo ma squisitamente dedicato al suo strumento, il direttore chiamato ad un lavoro di puro piacere del servizio ma che comunque si esprime in un rapporto gestuale - anche se per certi aspetti impotente - con la compagine orchestrale, il pianista solo in proscenio a tentare un dialogo con una struttura inamovibile quanto sconosciuta, ma nondimeno in possesso di un canovaccio dal quale attingere argomenti. E' messa in discussione anche la categoria del tempo come inteso nella musica occidentale; la misura ritmica regolare disattesa sia dalla stesura delle parti musicali, sia dal gesto teatrale del direttore, che contrae e dilata relativisticamente il tessuto temporale. Così come il senso collettivo dell'orchestra, scompaginato nella frammentazione in individualità solistiche.
Tutto sembra simbolicamente mettere in scena un copione iper-beckettiano, dove solo la totale dissoluzione del linguaggio celata dal silenzio delle pause anche sterminate, quando il tempo del cronometro umano rallenta a dismisura, può suggerire, ma non pronunziare, una nuova parola.
Ma al di là dell'indubbio interesse artistico e intellettuale dell'operazione cageana, una forma semplificata di tale progetto performativo può essere utile esperienza di lavoro per avviare una seria critica alle forme improvvisate anche da parte di 'non-musicisti.' In luogo degli strumenti musicali si possono usare oggetti sonori comuni che si hanno appresso, o la voce e i suoni del corpo, si può lavorare su pagine con sequenze di segni-suono di varie dimensioni collocate in campo libero [Nota 10], assente il pentagramma, un po' come in molti progetti di notazione per l'infanzia, nei quali spesso una rappresentazione grafica dei suoni più intuitiva, analogica, serve propedeuticamente al futuro approccio alla notazione tradizionale.
Tutta la struttura operativa della partitura cageana può essere mantenuta fedelmente passando, quindi, attraverso la fase ricompositiva e personalizzata della parte di ciascun partecipante all''orchestra,' con successiva sperimentazione sonora della stessa. Questo, tra l'altro, occasiona un breve ma interessante percorso di apprendimento della prassi su uno strumento atipico - fogli di carta, chiavi, cerniere, penne ecc., oltre a un utilizzo non verbale della voce - e suggerisce l'importanza di possedere una buona manualità articolativa nel far scaturire suono dagli oggetti [Nota 11]; cosa particolarmente interessante in campo musicoterapistico essendo proprio l'efficacia nell'articolazione degli elementi sonori ad accendere un circuito relazionale e quindi a far nascere, e a tenere vivo, il dialogo. Si veda ad es. Cage e la sedia nel video scuole di Torino).
Una volta organizzata la stesura orchestrale del lavoro è interessante far ricoprire a turno il ruolo del solista a tutti i partecipanti all'esperienza, con la consegna di 'dimenticare' la parte, e l'abilitazione a utilizzare in campo liberamente improvvisativo lo 'strumento' del quale ci si è minimamente impratichiti nella fase precedente. I partecipanti all'esperienza hanno così l'opportunità, uno dopo l'altro, di sperimentare la transizione tra modalità esecutiva di un progetto preordinato, modalità propria alla musica che utilizza la notazione come medium per la sua memorizzazione e realizzazione, e ciò che chiameremmo, più opportunamente, composizione estemporanea.
La 'conquista' del libero arbitrio, collocata nel quadro di un progetto collettivo che per altro fissa incorruttibilmente le regole di salvaguardia dell'individualità in seno alla collettività - vale a dire approdare all'improvvisazione dopo un percorso iniziatico, se pur limitato nel tempo, che chiede cura del dettaglio, attenzione esecutiva e, soprattutto, rispetto del gioco collettivo - produce nel solista una sorta di crisi della libertà che di norma si manifesta con una forte attivazione delle facoltà d'ascolto e, d'altra parte, con un mettere in fase d'attesa il dinamismo produttivo di suono generalmente sovradimensionato nelle prime esperienze di pratica dell'improvvisazione. È poi assai singolare, in questo specifico caso, l'esercizio a cui è chiamato il solista-improvvisatore in relazione con il prodotto sonoro del collettivo-orchestra. D'abitudine chi improvvisa, sia su forme libere che su strutture preordinate, è istintivamente portato ad aspettarsi dagli altri partecipanti al set reazioni più o meno accentuate conseguenti alle proprie azioni sonore (soprattutto se egli ricopre visibilmente un ruolo di primato solistico), cosa che ovviamente parte dal presupposto che si stia agendo all'interno di schemi convenzionali condivisi dai componenti del gruppo, come avviene in una conversazione estemporanea tra persone che si suppongono appartenenti allo stesso ceppo linguistico.
Nel caso del Concert, sia nella sua forma originaria che nella nostra versione per 'non-musicisti,' il solista si trova invece ad operare, e lo sa, al cospetto di una struttura sonora che procede seguendo le proprie regole autonome, assolutamente non reagente ai suoi impulsi (un po' come 'improvvisare' suoni reali o immaginari 'dialogando' con i fenomeni naturali: rumore di onde, vento tra le fronde, pioggia ecc.; esercizio per altro suggerito dallo stesso Cage); quindi è, per certi aspetti, costretto a imparare durante la performance mentre essa si attua; ed essendo chiamato ad un processo di adeguamento e di adattamento a norme continuamente variabili, nessun evento è in sostanza per lui prevedibile, né estrapolando per deduzione dal precedentemente accaduto, né tanto meno procedendo induttivamente alla ricerca di strutture regolari, o ricorrenti.
Questo forzare il musicista in progetti che, nel mentre lo abilitano alla pratica dell'improvvisazione, di fatto lo costringono al totale abbandono delle proprie abitudini e predilezioni, rendendo inutili - più che iconoclasticamente distruggendo - gli abiti precedentemente contratti, significa, per Cage, ricondurlo per mano alla forma infantile; e non certo nel senso regressivo del termine, ma come condizione assolutamente da trattenere in vita nelle forme adulte proprio per il suo connaturato impulso verso la sperimentazione del nuovo, e per la sua inesauribile e vorace curiosità verso il dissimile. Per certi aspetti il percorso dell'esercitazione sul Concert cagano si configura, infatti, come un progressivo tracciare una strada che consenta all'ascolto - e quindi all'improvvisazione - di ritrovare la condizione virginale, sorgivamente fanciulla, ma, nondimeno, offre a tale condizione una struttura di contenimento e di protezione che ne garantisce la sopravvivenza e la fioritura al riparo sia dalle tentazioni di eccessi egoici (tipici dell'età evolutiva), sia dalla pratica di protocolli appresi per condizionamento, e più o meno consapevolmente applicati (caratteristica saliente delle età mature). Questo ci pare lo spirito ideale - se vogliamo utopico - nell'affrontare pratica del dialogo sonoro improvvisato; un esercizio di tenuta su due livelli: quello in virtù del quale si deve poter agire liberi da strutture pregiudiziali per disporsi alla totale apertura nell'accogliere le istanze dell'altro e ad esse reagire, e l'altro, co-esistente e interattivo, in grado di osservare e osservarsi nel processo comunicativo, sviluppare progettualità e proporre sperimentalmente strutture da praticare. Se poi tali sperimentazioni diano esiti progressivi o meno, è interrogativo che va sottoposto con paziente costanza al vaglio di un giudizio critico che nessuna scuola, se non l'esperienza pratica, potrà mai orientare. John Cage era solito ripetere con curioso - ma efficace - ossimoro: "Mi considero un esperto di ciò che non si conosce".
Immagini tratte dalla preparazione dei suoni per l'esercitazione sul "Concert" di John Cage. Laboratorio di improvvisazione guidato da Claudio Lugo Corsi di Musicoterapia dell'APIM, Genova marzo 2012.
NOTE:
1. Il 'non' del titolo designa una opportunità di partecipazione all'esperienza anche da parte di chi non possiede una formazione musicale specifica, ma anche un suggerimento ad accantonarla - per quanto possibile - rivolto a chi eventualmente l'avesse (al musicista viene infatti suggerito di lasciare'a casa' il proprio strumento).
2. Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe, cap. XXI.
3. John Cage, "Conferenza su niente," in: Silenzio, Milano, Feltrinelli 1980.
4. Henry David Thoreau nacque a Concord, nel Massachusetts, nel 1817. Laureatosi ad Harvard, seguace di R. W. Emerson, fu una delle figure di spicco del movimento trascendentalista. Nel 1845, determinato a mettere in pratica i propri ideali, andò a vivere in una capanna sul lago Walden e vi soggiornò per ben due anni deciso a dimostrare come l'uomo moderno potesse vivere con i propri mezzi a contatto con la natura. Una simile esperienza gli ispirò la scrittura del Walden, ovvero La vita nei boschi (1854), un'opera a metà strada tra il saggio filosofico e il diario che oggi viene unanimemente considerata tra i classici della letteratura americana. Malgrado una vita trascorsa per larga parte in solitudine, Thoreau fu un attento osservatore e critico acuto della società americana a lui contemporanea, dedicando scritti e perorazioni soprattutto al problema della schiavitù. Insieme al Walden, il suo scritto più famoso e influente è sicuramente Disobbedienza civile, un opuscolo pubblicato nel 1849 nel quale Thoreau teorizzava l'idea dell'opposizione non violenta che tanto seguito avrebbe avuto nel secolo successivo.
5. 4'33" tacet (1952), in realtà dedicato a qualsiasi strumento o combinazione di strumenti, è famoso nella versione pianistica di David Tudor.
6. Una straordinaria trattazione delle fondamentali differenze tra il cosiddetto teatro rituale africano e il teatro come lo intendiamo noi 'occidentali' si trova in Wole Soynka, Mito e Letteratura nell'orizzonte culturale africano, Milano, Jaca Book 1995.
7. Cfr. Claudio Lugo, "Le spine del cactus," in: Musica e Terapia.
8. Concert for Piano and Orchestra (1957-58) per 1-15 esecutori in qualsiasi combinazione; il pianista suona il Solo for Piano (stessi anni) costituito da 63 fogli mobili eseguibili, tutti o in parte, in qualsiasi sequenza.
9. In virtù del carattere puramente gestuale dell'azione del direttore del Concert, per la prima assoluta dell'opera quel ruolo fu assegnato a Merce Cunningaham, il coreografo con il quale Cage realizzò numerosi progetti.
10. Si potrebbe sostituire il pentagramma con un monogramma normalmente in uso per strumenti a percussione, che rappresenta l'altezza dei suoni in tre unici campi; acuto (nota appoggiata sopra la linea), medio (nota centrata sulla linea), grave (nota posta sotto la linea).
11. In un video Cage e la sedia che testimonia la realizzazione di un progetto di John Cage con le scuole elementari di Torino nel 1984 lo si vede mentre in una palestra, di fronte a bambini e insegnanti incantati, fa scaturire sequenze di suoni davvero inaspettati e interessantissimi dal semplice gesto di trascinare - ad arte - una sedia appoggiata su di una gamba sola sul linoleum del pavimento.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.