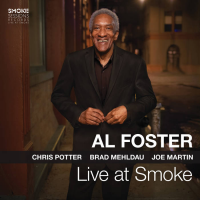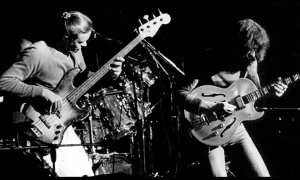Home » Articoli » Lyrics » Jazz e narrativa 3: "Il lupo della steppa" di Hermann Hesse
Jazz e narrativa 3: "Il lupo della steppa" di Hermann Hesse
L'obiettivo di "Déjà lu," la nuova rubrica di All About Jazz Italia, è appunto quello di recuperare dall'oblio testi già pubblicati in passato per riproporli ai jazzofili di oggi che leggono AAJ. Per il reperimento del materiale, oltre agli abituali collaboratori di AAJ, ci siamo rivolti a note firme nazionali e internazionali, ottenendo la loro convinta adesione. I testi a volte vengono ampliati e riveduti col senno di poi, oppure, se funzionano, lasciati nella versione integrale; in una nota viene comunque citata la fonte originaria.
Il jazz, forse più di altre espressioni artistiche, si è continuamente evoluto, evitando di rinchiudersi all'interno di forme codificate ed astratte e cercando anzi un continuo coinvolgimento con il contesto sociale, economico e culturale. Esso ha inoltre stabilito relazioni di diversa natura con le altre arti, influenzandole o venendo da esse influenzato. Mi pare opportuno pertanto, per non favorire un settarismo miope e nocivo, affrontare delle analisi che considerino il jazz all'interno di un panorama più vasto, individuandone i momenti di interdisciplinarità.
Sul tema jazz e letteratura, per esempio, molto rimane ancora da approfondire. Si tenga presente a tale proposito l'importanza che questa musica ha avuto nella produzione di molti romanzieri e poeti nero-americani, nonché la interrelazione sviluppatasi negli anni Cinquanta fra jazz e Beat Generation oppure, poco prima, quella fra jazz ed esistenzialismo francese, preceduta a sua volta dall'analogia metodologica fra l'automatismo surrealista e l'improvvisazione jazzistica. Tutti questi movimenti, ribadendo l'unitarietà dei fenomeni estetici, si estendevano anche all'ambito del pensiero filosofico, del teatro, delle arti visive...
Questo mio saggio, che per la sua brevità deve essere considerato più una segnalazione che un'approfondita analisi critica, vuole ricordare uno dei primi romanzi europei in cui il jazz assume un ruolo tutt'altro che marginale: Il lupo della steppa di Hermann Hesse, una delle opere più controverse del secolo scorso, che ha visto contrapposte schiere di entusiasti sostenitori (fra i quali il sottoscritto) e schiere di accaniti denigratori. Pubblicato a Berlino nel 1927, Der Steppenwolf tratta delle traversìe di Harry Haller, un intellettuale nevrotico, intimamente antiborghese; sempre in conflitto fra stimoli contrapposti, egli riconosce nella propria personalità mille anime latenti, delle quali cerca di facilitare il riemergere nel tentativo di scongiurare il suicidio. In questo senso il libro contiene molti spunti autobiografici: Hesse, soggetto a crisi depressive, aveva infatti sostenuto nel 1921 un ciclo di sedute psicoanalitiche sotto la guida di Carl Gustav Jung.
Il leitmotiv evidente è quello dell'eterno conflitto fra vita e pensiero, fra sensualità terrena e trascendenza spirituale, della dualità fra equilibrio classico ed affanni moderni, dell'inconciliabile contrapposizione fra ordine borghese ed anticonformismo intellettuale. Argomenti per altro ricorrenti in quasi tutte le opere dell'autore tedesco, ma, mentre in Siddharta, Narciso e Boccadoro ed Il gioco delle perle di vetro essi vengono trattati con olimpico distacco, con una narrazione più concatenata e distesa, anche se in una dimensione quasi atemporale e favolistica, ne Il lupo della steppa, dallo stile meno elegante e rifinito, concitato e scarno, prevale, come in Demian o L'ultima notte di Klingsor, una dimensione più surreale ed allucinata, fortemente coinvolgente.
In questo contesto il jazz interviene quale simbolo della mondanità massificata e volgare, come esigenza di evasione collettiva; inizialmente esso viene visto come uno dei sintomi inevitabili dell'evoluzione dei tempi e della distruzione della cultura europea. L'atteggiamento di Hesse è in questa fase simile a quello di Joseph Roth, che nel contemporaneo romanzo La cripta dei cappuccini vede nella moltiplicazione seriale dell'arte applicata una degenerazione estetica rispetto alle qualità formali della produzione artigianale dell'anteguerra.
Mi sembra indispensabile riportare il brano in cui il protagonista Haller descrive il suo occasionale impatto con il jazz: "Mentre passavo davanti a un locale di danze, fui investito da una violenta musica di jazz, rozza e calda come un vapore di carne messa a bollire. Mi fermai un istante: quella specie di musica, per quanto mi fosse abominevole, aveva sempre per me una segreta attrattiva. Il jazz mi era antipatico, ma lo preferivo di molto all'odierna musica accademica, e con la sua gaia rusticità colpiva anche i miei istinti, alitando un'ingenua e sincera sensualità.
Stetti un istante annusando quella musica sbraitante e sanguinosa, fiutando l'atmosfera cattiva e libidinosa di quelle sale. Metà di quella musica, la metà lirica, era burrosa, troppo zuccherata e grondante sentimentalismo, l'altra metà era selvaggia, capricciosa e robusta, eppure le due parti si accordavano ingenuamente e pacificamente formando un intero. Era una musica di decadenza... quella musica aveva il pregio di una grande sincerità, il pregio di essere un'amabile e non mentita musica di negri, un capriccio lieto e infantile. Aveva un po' del negro e un po' dell'americano che a noi europei sembra così puerilmente fresco e ingenuo nella sua forza. Diventerà così anche l'Europa?".
La visione del jazz espressa da Hesse può sembrare oggi limitata e denigratoria, anche se mi pare molto sincera e rispondente ad una determinata realtà storica. Bisogna tener presente infatti da un lato le origini socio-culturali dello scrittore, nato nel Württenberg nel 1877 da una famiglia molto colta e religiosa, dall'altro le caratteristiche del jazz intorno al 1926, anno in cui egli concepì il suo romanzo. In quegli anni infatti questo nuovo genere musicale in Europa era proposto e percepito come un'esotica curiosità, un'ubriacante forma di evasione.
Ma la parabola narrativa e concettuale del romanzo, e di conseguenza i suoi riferimenti al jazz, non si esauriscono qui. Nel suo tormentoso peregrinare il protagonista si lascia coinvolgere da un ambiente umano e culturale a lui originariamente estraneo. Incontra persone che diventano per lui guida di vita, dandogli la possibilità di vincere le sue inibizioni e di penetrare in mondi nuovi e magici: la bella ed accondiscendente Maria, la misteriosa Erminia, una figura femminile tanto improbabile quanto affascinante, che riesce a conciliare inconsapevolmente ingenuità e profondità di pensiero, purezza ed adescante malizia; infine il disinvolto ed acclamato sassofonista Pablo, che si realizza nel jazz e con esso dà appagamento a chi lo circonda.
Quest'ultimo, in un colloquio con Haller, pur non contestando la superiorità della musica classica, dichiara di non preoccuparsi del futuro della sua musica effimera, ma anzi, animato da uno spirito quasi missionario, a suo modo mistico e fatalistico, di dedicarsi interamente ad essa, cercando di esprimersi nella maniera più sincera e comunicativa possibile. "Io sono un musicante, non sono un erudito - egli afferma - nella musica non si tratta di aver ragione, di aver buon gusto e cultura e che so io... Si tratta di far della musica, signor Haller, di suonare, possibilmente bene e molto e intensamente. Ecco qua, signore. Se ho in mente tutte le opere di Bach e Haydn e ne so dire le cose più intelligenti, non ho fatto ancora nulla per nessuno. Ma se piglio il mio saxofono e suono uno shimmy insinuante, lo shimmy potrà essere buono o cattivo, ma certo piacerà alla gente, entrerà loro nelle gambe e nel sangue. Questo conta... noi musicanti dobbiamo fare la parte nostra, dobbiamo compiere il nostro dovere: noi dobbiamo suonare ciò che la gente desidera di volta in volta e dobbiamo cercar di suonare possibilmente bene e con sentimento."
Haller si fa progressivamente trascinare dal fascino di Erminia e dall'immediatezza del jazz di Pablo; grazie all'influenza della loro natura eminentemente disinteressata e spontanea, egli riesce ad infrangere le convenzioni sociali che lo attanagliavano e si rende sempre più conto della relatività delle scelte umane: in queste verità forse egli troverà la forza per sopravvivere, superando la sua crisi.
La trattazione esplicita o velata di motivi scabrosi (lo sconforto, la droga, l'amore libero...) poteva, in relazione ai tempi in cui uscì, far accusare quest'opera di amoralità o d'immoralità, ma in realtà l'autore risolve l'ambiguità di fondo in un proprio tentativo di apertura e di ricerca, in una sorta di conciliazione degli opposti, che a parer mio diviene il suo messaggio etico, a tratti perfino moralistico. Mi sembra assai pertinente ed acuto, a tale proposito, il giudizio di Ervino Pocar, che, nell'introduzione all'edizione Oscar Mondadori, 1979, afferma: "Non pago di rappresentare, Hesse vuol additare nel disordine moderno la presenza redentrice dell'antico; incapace - ad esempio - di sentire la poesia del jazz, Hesse la nobilita con benevola condiscendenza quale riverbero del sacro e del passato accessibile agli spiriti ridotti e superficiali, ancorché sinceri dell'età moderna. E il suo romanzo, avvincente cronaca di una nevrosi e suggestivo viaggio nell'irrazionale, viene appesantito da un intento pedagogico e sentenzioso, da una scoperta volontà di restaurazione".
Ispirato a questo romanzo è l'omonimo film girato negli Stati Uniti nel 1976 dal regista Fred Haines, il quale, sia nello svolgimento che nei contenuti, si è mantenuto sostanzialmente aderente al testo di Hesse, eccedendo però negli aspetti scenici e visivi permessi dal linguaggio cinematografico. Dopo un inizio sobrio e di grande suggestione, prende il sopravvento l'atmosfera surreale ed allucinata, che viene resa con espedienti troppo artificiosamente spettacolari. Per rendere un intimo conflitto psicologico non era indispensabile ricorrere ad un surrealismo alla Dalì, aggiornandolo con ridondanti effetti psichedelici ed optical; forse sarebbe stato preferibile l'uso di mezzi più essenziali che, oltre ad esaltare la dimensione privata del dramma, sarebbero stati più conformi all'austerità stilistica dello scrittore.
Nella versione cinematografica il personaggio di Harry Haller è interpretato dal grande Max von Sydow con la sua solita perizia ed espressività, il ruolo di Erminia è affidato al volto enigmatico di Dominique Sanda, mentre il sassofonista Pablo è impersonato da un Pierre Clementi forse troppo manierato. La colonna sonora, opera dello svizzero George Gruntz, concilia con abilità testuali riferimenti alla musica da ballo degli anni Venti e brani hard bop, momenti di lirico intimismo e squarci di musica elettronica. Questa scelta per sottolineare nella maniera più opportuna le varie fasi della narrazione e le diverse situazioni psicologiche del personaggio, evitando di rimanere vincolati all'ambientazione storica del romanzo, replicando i caratteri del jazz delle origini.
Questo breve saggio, per l'occasione riveduto e corretto, vide la sua prima pubblicazione su Musica Jazz del marzo 1985 col titolo «Un sassofono liberatorio nella nevrosi di Hermann Hesse».
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.