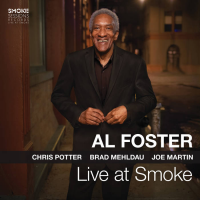Home » Articoli » Interview » Intervista ad Andrea Massaria
Intervista ad Andrea Massaria
All About Jazz Italia: Oggi sei un musicista impegnato quasi esclusivamente sul versante della pura improvvisazione, ma il tuo percorso è iniziato da altre tradizioni. Puoi raccontarci il tuo percorso artistico?
Andrea Massaria: Sì, in realtà io ho cominciato dal conservatorio, quindi studiando musica classica. E stavo già facendo concerti di classica quando, nel 1990, mi è capitato di sentire, quasi per caso, un concerto di Barney Kessel. Allora il jazz non sapevo neppure bene cosa fosse, avevo ascoltato qualcosa ma senza averne mai approfondito la conoscenza. Il concerto fu invece una rivelazione: quello che Kessel era capace di fare con la chitarra - cose che io, che pure studiavo con profitto, non ero in grado di fare - mi colpi così tanto che il giorno dopo andai dal mio insegnante del conservatorio, lo ringraziai molto per quegli anni di studio e gli dissi che, però, da quel momento mi sarei messo a studiare jazz...
Ho iniziato quindi molto tardi - avevo già venticinque anni - e per farlo fui costretto a recarmi fuori Trieste, perché qui non c'era quel che cercavo, ma in quel modo feci numerosi corsi e seminari, quasi tutti di genere bebop e mainstream, che allora apprezzavo molto. Poi, pian piano, mi resi conto della necessità di andare oltre anche quelle griglie e iniziai ad evolvere verso uno stile personale. Verso, soprattutto, quello che io considero lo spirito del jazz: l'improvvisazione.
AAJ: Qual è la tua concezione del jazz?
A.M.: Oggi sotto l'etichetta "jazz" finisce di tutto, da Armstrong a Šostakovic, da Ornette a Piero Pelù... Il rischio è che, alla fine, il termine non voglia dire più niente... Per questo credo che sia importante tenere al centro l'improvvisazione, come tratto determinante del jazz. In particolare, io amo l'improvvisazione: libera ma non "casuale," anzi, possibilmente con quello che chiamo "caso guidato"..
AAJ: Spiegati meglio.
A.M.: Voglio dire che chi improvvisa si assume dei rischi molto alti, ma porta sempre con sé la propria tecnica, i suoi studi, il proprio bagaglio personale; l'attenzione a questo background permette di "guidare" l'aleatorietà della scelta in una direzione più "ordinata". Lo definirei un salto nel buio con il paracadute.
AAJ: Certo, è quel che accade in ogni forma di interazione "non progettata," ad esempio nelle relazioni linguistiche di una conversazione: due persone, come noi adesso, interagiscono tra loro su un tema, mettendo nello scambio ciascuna le proprie competenze e cercando di produrre assieme qualcosa di concatenato, armonico, sensato. Ma "cosa" è questo "paracadute" di cui parli?
A.M.: Tutto il mio vissuto! Che non è solo quello musicale, ma che si riversa comunque nella musica - perché la musica è un mezzo espressivo come la parola, anche se ha criteri diversi. Quando io improvviso ci metto dentro tutto quello che ho vissuto, tutto quello che ho imparato, tutte le mie letture, le mie passeggiate, i miei filosofi preferiti... così come il bebop, il jazz, la classica... sono tutti appigli che mi vengono in aiuto quando mi lascio andare nel flusso improvvisativo, quando cioè non penso più alle dita che schiacciano il tasto o all'accordo che devo mettere, ma lascio la mente libera e suono "a caso". Ecco, è qui che il mio bagaglio personale viene fuori e "guida" le mie mani senza che io ci pensi.
AAJ: Dunque tu ritieni che a guidarti non sia solo il bagaglio strettamente musicale, ma anche qualcosa che ha a che fare con la tua più generale esperienza personale. Puoi farmi un esempio?
A.M.: Potrebbe essere l'ultimo libro che sto leggendo. Ultimamente, ad esempio, sto leggendo Jean Paul Sartre, di cui sono appassionato. Mettiamo che abbia letto una frase che rimanda al fatto che l'uomo è causa e responsabile delle proprie azioni, e che io ne sia colpito: questo pensiero entra a far parte di me, lo assimilo, lo vivo. Così, mentre suono, la mano va sulla tastiera mentre la mente segue il pensiero di Sartre e io, con tutto me stesso, cerco di tradurre questo nella musica. Così (scusa l'esempio un po' banale) invece che facendo i soliti pattern per fare il "piacione," provo a usare un modo di suonare meno tecnicamente "pensato," facendomi suonare da un pensiero non "musicale," ma "umano".
AAJ: Tu credi che questa interazione tra suggestioni "culturali" e ambito strettamente musicale sia in qualche modo descrivibile, ricostruibile, oppure che avvenga solo nell'interiorità dell'autore?
A.M.: Può essere anche descrivibile, nel momento in cui ci si interroga sui propri processi creativi - cosa che io faccio spesso. Se vado ad analizzare quel che mi sta succedendo in un processo creativo, posso arrivare a scoprire perché lo faccio. Ad esempio, certe volte ti rendi conto che fai quel che fai semplicemente perché piace al pubblico; certe altre, invece, scopri che lo fai perché credi - per formazione, per luogo comune, per tuo limite - che quello è l'unico modo in cui si suona, o l'unico "giusto"; ma se riesci a capire questi "perché lo fai," puoi svincolarti e anche comprendere perché certe volte suoni in modo del tutto diverso, seguendo tutt'altre serie di pensiero.
AAJ: Hai detto di esserti trovato più volte a riconoscere di essere vincolato da un "modo giusto" di suonare - che prima era quello classico, poi quello del bebop e del mainstream. Pensi che per svincolarsi da questi "modi giusti" sia necessario fare anche uno sforzo di "liberazione"?
A.M.: Sì, credo assolutamente di sì. Io sono stato un anno e mezzo della mia vita senza suonare, perché non mi piaceva più come suonavo e - bombardato com'ero e come siamo tutti da mille giudizi e pregiudizi - non capivo neppure più in che direzione volessi andare. Perciò credo che ci sia un grossissimo lavoro da fare sulla propria persona per scoprire quello che si vuole e definire quale sia il proprio modo "giusto". Che poi, tra l'altro, non è neppure un'acquisizione definitiva, perché è sempre auspicabile che ciascuno evolva e cambi nel corso degli anni e che perciò modifichi anche il proprio "modo giusto" di suonare.
AAJ: Questo è interessante, perché ci dice un'altra cosa non così scontata (per quanto, spero sia almeno un po' diffusa tra i musicisti jazz): che la forma d'espressività artistica non è qualcosa di definitivo, raggiungibile una volta per tutte. Tu ritieni che questo sia una caratteristica essenziale della musica jazz?
A.M.: Assolutamente sì. Lo spirito primitivo del jazz - l'improvvisazione - è ciò che conferisce movimento a questa musica. E ciò che è movimento è vita. Ma al tempo stesso ciò che è movimento non è mai definitivo, non si può "catturare". Fin dalle origini il jazz ha rifiutato il prodotto perfetto, almeno fino a quando ha continuato ad essere musica improvvisata e non mero esercizio di stile.
AAJ: Ma, come sai, fin dagli albori del pensiero occidentale - con Platone - si è cercato di ipostatizzare il Bello (così come il Vero) ponendolo "fuori del mondo," quale essenza "stabile" delle sue mutevoli (e perciò spurie, corrotte e fallibili) manifestazioni mondane. In questo modello estetico, quando trovi la "cosa giusta" devi solo ripeterla all'infinito, senza neppure pensare di modificarla. È il modello poi assunto dalla musica classica, che ha nello "stabile e definitivo" manoscritto l'originale a cui le esecuzioni possono solo cercare di avvicinarsi. Rispetto a questo modello, infatti, il jazz è stato definito (da Ted Gioia) "arte imperfetta".
A.M.: È vero, così come lo è il fatto che il jazz è completamente diverso da quel modello. Se il jazz lo chiamiamo ancora jazz è perché pur riferendosi ancora ad alcuni elementi della sua tradizione, il blues per esempio, conserva nondimeno la sua imprevedibilità e la sua libertà di approccio ed espressione: lo ridefinirei quindi piuttosto come "l'arte dell'imperfezione"...
AAJ: E allora ti faccio un'altra domanda che, vista la tua storia di jazzista partito dal mainstream e arrivato all'improvvisazione radicale, mi sembra interessante. Il jazz ha una sorta di "doppia identità," perché da un lato è musica improvvisata, dall'altro conserva le (talvolta ancora enfatizzate) "radici afroamericane". Ma tale doppia identità va incontro a una stridente contraddizione, perché se l'improvvisazione "spinge" verso il superamento di ogni modello di riferimento, dall'altra l'esistenza di "radici" obbliga a un rispetto di un ben determinato modello e dei pre-giudizi che ad esso sono inevitabilmente connessi. Tu come ti poni di fronte a questa contraddizione che caratterizza il jazz?
A.M.: Certo, in me oggi le radici afroamericane, sempre che ci siano ancora, non sono preponderanti. Personalmente la contraddizione l'ho sempre affrontata avendo in mente la simbologia di Giano, la figura mitologica con due teste, una che guarda al passato e l'altra che guarda al futuro, alla quale ho dedicato il mio omonimo CD (clicca qui per leggerne la recensione). Gli studi che io svolgo sono infatti sempre mirati a guidare la mia improvvisazione, facendo sì che le mie "radici" siano presenti in quello che faccio, ma che siano anche costantemente sviluppate. Radici che, poi, certo non sono afroamericane, visto che non sono nato a New York o a Chicago e non sono nero. Anche se poi bisognerebbe vedere fino a che punto le mie radici siano "mie": io sono nato in una terra di frontiera, nella quale si intrecciano molteplici culture; inoltre, per quanto sia nato qui, a Trieste, in realtà la mia "essenza" non è "essere di Trieste". Non so neppure quale sia la mia "essenza": la mia ricerca, non solo musicale, è proprio quella di identificare quale sia questa "essenza". Passa sicuramente attraverso lo studio e la scoperta delle mie "radici," proprio per scoprire se queste fanno realmente parte della mia "essenza" o meno. Quindi, se mi fermassi a suonare quelle che, a un certo stadio della mia ricerca, mi sembrassero le mie vere radici, interromperei anche la mia ricerca e cambierei decisamente il mio modo di relazionarmi alla musica - e anche alla mia vita.
AAJ: Quindi il dilemma è tra fermarsi al fin-qui-noto, e perciò rassicurante ma non innovativo, e spingersi verso l'ignoto, rischiando però di negare troppo e diventare incomprensibile e inascoltabile...
A.M.: Forse il segreto è quello di sovvertire e distruggere regole e radici solo dopo averle ben conosciute. Quando la regola la conosco, me la posso giocare, posso superarla, cambiarla; se invece non la conosco, posso solo fare un'opera di distruzione che non propone nulla di personale, né di veramente nuovo.
AAJ: Come sono solito dire, è difficile che un autore possa essere riconosciuto (dal pubblico o dalla critica) se non si rende comprensibile; e ciò è molto difficile che possa avvenire nel caso di un sovvertimento improvviso o radicale (al massimo può esserlo nel caso di atti fortemente "politici," di rottura esplicita): per essere riconoscibile devi lasciar capire cosa innovi, cosa sovverti, e per farlo devi comunque far parte di una comunità, conoscerne e padroneggiarne il linguaggio, condividere con essa una serie di valori. E quindi anche di "radici".
A.M.: Sono d'accordo, anche perché questa è per l'appunto la cosa più difficile per un musicista: creare qualcosa di nuovo, partendo da basi note, superandole e mantenendosi comprensibile. Il passaggio dal vecchio al nuovo è il momento più difficile e, appunto, richiede una profonda conoscenza di ciò che stai superando. Appropiarsi di alcuni valori per poi negarli, una specie di "nichilismo musicale" insomma...
AAJ: E tu questo processo come lo metti in opera? Com'è che pian piano ti sei allontanato dal mainstream?
A.M.: Perché mi sono accorto che stavo ricominciando a suonare come un musicista classico!
AAJ: Appunto il paradosso di Marsalis...
A.M.: Esatto. Via via che nel jazz capisci determinate regole - cosa certo estremamente difficile perché, diversamente dalla musica classica, non è già "tutto scritto" - ti trovi, grazie ad alcuni accorgimenti, a sapere già cosa dire quando improvvisi. Ciò vale soprattutto per la musica di un certo periodo, quello del bebop degli anni '50, che è ben codificata e nella quale su certi accordi suoni certe scale e progressioni, fai certi attacchi e usi i cromatismi in un certo modo, così che alla fine sai come fare quel che devi fare. Ecco: qui a un certo punto mi sono sentito a disagio e ho cominciato a cercare una strada diversa. Pur tenendo ben a mente la tradizione, ma appunto per sovvertirla. Personalmente non credo alle "rivoluzioni" - anche perché il termine deriva dal moto dei pianeti, che alla fine però tornano sempre al punto di partenza...
AAJ: Già. Infatti, storicamente, a una rivoluzione segue regolarmente una controrivoluzione...
A.M.: E si abbatte un "capo" per instaurarne un altro, e magari per incensarlo come non si sarebbe mai voluto incensare il precedente. Ciò può valere anche nella musica: superare un modello solo per ossequiarne uno diverso significa solo cambiare genere, ma non ancora cambiare atteggiamento nei confronti della musica.
AAJ: Per tornare alla tua evoluzione, quando hai fatto il primo CD a tuo nome, Titapana, eri già uscito dal mainstream?
A.M.: Stavo cominciando a uscirne, perché rispetto ai miei lavori successivi è senz'altro più vicino al mainstream.
AAJ: In effetti, c'è non solo una presenza forte di standard, ma anche un certo modo di approcciarli. Nel secondo, Giano, ci sono ancora gli standard, ma il rapporto che hai con essi è più libero.
A.M.: Sì, l'ancoramento agli standard è un po' una coda che m'era rimasta del mainstream. Allora la mia idea era quella di portare libertà espressiva anche negli standard - una cosa che cerco ancora, ma con meno centralità. Però è anche vero che ampliare gli spazi di libertà all'interno degli standard è una grande palestra: ti insegna a non avere paura della libertà espressiva. Perché comunque stare nella libertà significa prendersi la responsabilità di una posizione personale, ti obbliga ad esporti ai giudizi e alle critiche di coloro ai quali tu eri legato prima di spingerti liberamente oltre i limiti imposti dallo stile... Però, allo stesso tempo ti permette di rafforzare la tua personalità, il tuo "modo giusto" di suonare.
AAJ: È appunto la dinamica del riconoscimento di cui parlavamo prima. Riconoscimento non solo professionale e di successo, ma anche affettivo e identitario. Insomma, il riconoscimento, da parte di altri, del fatto che il tuo lavoro abbia o meno un senso e un valore. E, se tu fai qualcosa di innovativo e creativo, ciò passa attraverso un distanziamento che richiede una progressione e, magari, una forma di paracadute - per riprendere un tuo termine. L'ancoraggio agli standard può essere un buon paracadute.
A.M.: Da Giano in poi ho cercato di praticare forme di espressività più forti, a partire da pezzi che avevo cominciato a comporre, più liberi, senza forma e con pochi accordi, ma basati su un fortissimo interplay - che era ciò che maggiormente mi interessava. Dopo averli un suonati per un po,' l'esigenza di sviluppare un'espressività diversa s'è fatta via via più marcata, cosicché ho proseguito nella sua messa in luce. Oggi credo di padroneggiarla abbastanza bene: dico abbastanza perché non c'è mai una fine! È una cosa incredibile, non si finisce mai di scoprire e perfezionarsi. Comunque, oggi anche allo standard riesco ad avvicinarmi in modo molto libero, soprattutto cercando di mantenere inalterato il mio stile. In altre parole, il mio obiettivo adesso è quello di avere uno stile e un sound personali, in modo da far sì che - come avviene per i grandi musicisti, ad esempio per un Ornette - quando si ascolta un pezzo in cui suono, di qualunque cosa si tratti, si possa riconoscere che sono io. Cerco cioè di suonare con chiunque senza perdere la mia identità, il mio stile - per quanto essi siano in evoluzione.
Questo mio sviluppo ha fatto sì che, diversamente da quanto mi è accaduto in passato, oggi mi senta assolutamente pronto e tranquillo a suonare con chiunque, a prescindere dal suo valore e dalla sua notorietà. Com'è accaduto quest'estate, per esempio, quando ho suonato con Butch Morris.
AAJ: Come ti sei trovato?
A.M.: Era a S. Anna Arresi, a fine agosto. E mi sono trovato molto, molto bene, perché sono riuscito a inserirmi nel suo "gruppo" con la mia personalità. So che posso dire certe cose in un dato momento con sicurezza, e questa mia consapevolezza viene recepita dai partner. Butch sapeva che io potevo dare qualcosa a lui e che lui poteva chiedermelo, così che io ho dovuto pensare solo a suonare, senza preoccuparmi di cercare il suono o la nota giuste, tutte cose che ti castrano. Ma, ripeto, il bello è che chi suona con te questa consapevolezza la sente, e ciò permette che - fatte salve le differenze di gusto e di stili - le collaborazioni funzionino nel migliore dei modi.
AAJ: In questo tuo sviluppo, hai seguito dei modelli tra i grandi interpreti del tuo strumento?
A.M.: No, direi proprio di no. Ovviamente, sono un attento ascoltatore dei maestri della chitarra jazz, e ne apprezzo molti, da Jim Hall a John Abercrombie, da Wes Montgomery a Kurt Rosenwinkel. Però, un po' paradossalmente, non mi ispiro a nessuno di loro. Se devo dire di avere dei modelli, ebbene, essi suonano altri strumenti! Su tutti, citerei Paul Bley, Ornette Coleman e Glenn Gould. Direi che mi interessano più le ispirazioni di un certo modo di affrontare la musica, piuttosto che di un certo modo di affrontare la chitarra.
AAJ: Tornando al tuo percorso, che passaggio ritieni di aver fatto da Giano alle tue produzioni più recenti?
A.M.: Direi soprattutto mentale, perché tecnicamente il progresso è costante e regolare, ma mentalmente c'è stato un salto di qualità: come convinzione, come sicurezza. Poi ovviamente sono intervenute le differenze mediate dai partner: ogni musicista ha il proprio stile, i propri gusti, il proprio bagaglio personale e musicale; quando suoni con compagni che hanno una cifra stilistica a loro ben chiara, le differenze scompaiono e si fondono in un tessuto musicale che cresce, proprio grazie alle differenze, in modo coerente e unitario. Questo invece non riesce quando i musicisti coinvolti mancano di chiarezza e sicurezza.
È lo stesso fenomeno che avviene nella conversazione, che citavi prima come esempio: devi sapere bene cosa vuoi dire, se vuoi che l'altro, a prescindere dalle sue proprie opinioni in materia, capisca quel che dici e interagisca criticamente e produttivamente con te. Se nessuno dei parlanti sa bene di cosa parla, non ne può certo venir fuori un bel discorso compiuto!
AAJ: Certo, potremmo al massimo limitarci a "parlare del tempo"...
A.M.: Esatto. Invece, se i parlanti sanno di cosa stanno parlando, anche le loro differenze vanno a completare, correggere, rafforzare le reciproche opinioni e finiscono per costituire un discorso condiviso rigoroso e ricco di sfaccettature.
AAJ: Come descriveresti quello che fai oggi, e come lo distingueresti da quel che facevi in passato?
A.M.: Attualmente la mia musica si sta evolvendo soprattutto dal punto di vista compositivo: ho infatti ripreso a scrivere, dopo un po' di tempo in cui mi ero preso una pausa. Ciò dipende dal bisogno di mettere alla prova la cifra stilistica che ho messo a fuoco. Ne vien fuori una scrittura che in qualche modo è vicina alla classica contemporanea, perché è quanto più si adatta allo sviluppo dell'improvvisazione basata sull'interplay, che come dicevo è quel che più mi interessa in questo momento. Quindi, un certo uso di intervalli, consonanze e dissonanze che non è strettamente o propriamente jazzistico.
AAJ: Stai cioè cercando di ampliare le possibilità tecniche attingendo ad un universo più ampio di quello della tradizione jazz.
A.M.: Sì, però il tutto sempre usando gran parte del linguaggio del jazz, o comunque comprensibile ai jazzisti. Per fare un esempio, pensare un accordo nei termini tradizionali, cioè per costruzione di intervalli di terza, oppure pensarlo come un rapporto tra consonanze e dissonanze è molto diverso e apre alla mente tutt'altri orizzonti, tutt'altri modi di interpretare la musica che stai suonando. Anche tecnicamente ti permette di sviluppare modi di suonare inusuali per lo strumento che usi ma estremamente creativi e stimolanti: per esempio l'uso di clusters o politonalità e polimodalità. Ecco, questo è quello a cui sto tendendo, tanto nel Chladni Experiment Trio, con Alessandro Fedrigo al contrabbasso e Carlo Alberto Canevali alla batteria, quanto nel duo con Arrigo Cappelletti. Il pensiero è sempre lo stesso, ma nei due gruppi viene sviluppato in modo diverso, di nuovo, perché diversi sono i compagni: quando ti basi molto sull'interplay, la differenza la fa appunto la personalità di chi suona con te.
AAJ: Lo stesso vale per il trio con Cappelletti e Rabbia, con il quale dovresti registrare a breve?
A.M.: Ovviamente sì. Lì c'è l'apporto di Michele, che è molto creativo e ha una grande fantasia. Di nuovo, una personalità - musicale e non solo - diversa, che porta nuovi stimoli e nuovo materiale da costruzione, che viene valorizzato nell'interazione e nella creazione istantanea dell'improvvisazione.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.