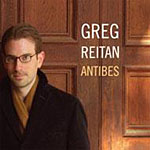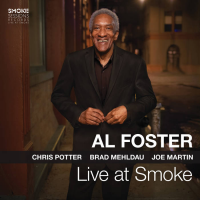Home » Articoli » Interview » Intervista a Paolino Dalla Porta
Intervista a Paolino Dalla Porta
Affrontando il jazz da europeo, non mi sono mai posto un problema di appartenenza, di schieramento. Se lo facessi, dovrei tagliare una parte del mio essere, che ha radici profonde nell'Europa, nel Mediterraneo.
All About Jazz: Il tuo primo strumento è la chitarra. Poi, a ventun' anni, il contrabbasso. Come mai questo cambio di strumento?
Paolino Dalla Porta: Ho iniziato a suonare la chitarra a dieci anni, nel 1966, nel pieno dei Beatles e dei Rolling Stones. Ho avuto un percorso di studi di chitarra classica, che mi piaceva molto, finché non ho incontrato persone che mi hanno fatto sentire qualche disco, portato a suonare in certi contesti, fatto ascoltare qualche concerto. Così mi è entrato il famoso "tarlo" del jazz, e a poco a poco mi sono avvicinato a questa musica.
Avendo studiato chitarra classica, trovavo che il rapporto dell'esecutore con del materiale musicale già fissato, materiale peraltro meraviglioso... mi stava un po' stretto. E quindi sono entrato in crisi, una crisi che ha coinvolto anche la chitarra.
Un giorno, mentre le nostre sperimentazioni andavano sempre più verso il jazz, si è presentato qualcuno con un contrabbasso in carne ed ossa. Sentirlo nella stanza, per me è stata una grandissima impressione. Nei dischi il contrabbasso è sempre, non dico in secondo piano, ma comunque in un ruolo di sostegno, un po' defilato. Averne esperienza diretta, è stata una specie di amore a prima vista.
Sono andato a cercarne uno, inizialmente con l'idea di continuare anche con la chitarra. In realtà i due strumenti non sono molto compatibili. La chitarra classica ha bisogno di unghie sulla mano destra, l'impostazione è diversa... Allora ho deciso di optare per il contrabbasso.
AAJ: Nel mio immaginario, la chitarra ed il contrabbasso corrispondono anche a due differenti profili psicologici, se mi passi il termine. Più protagonista la chitarra. Più mediatore, più equilibrato, il contrabbasso. Cosa ne pensi?
P. D.P.: Sono d'accordo. Anche da chitarrista mi piaceva accompagnare. E sicuramente nel contrabbasso ho portato un approccio che mi derivava dalla frequentazione della chitarra. Un approccio melodico, anche solistico, fin dagli inizi. Con esiti più o meno discutibili, però ci provavo. Non ho mai cercato di trattare il contrabbasso come una chitarra, però l'ho sempre suonato con l'idea di ritagliarmi degli spazi, di usare lo strumento non solo come accompagnatore, ma anche solisticamente, oppure per esporre temi.
Questa è una cosa che uso molto nella didattica. Studiare temi di jazz, di be-bop, per apprendere un linguaggio ma anche per sviluppare quello che sarà un approccio solistico.
AAJ: A proposito di strumenti e profili psicologici dei musicisti, hai letto "Il Contrabbasso" di Süsskind?
P. D.P.: Certo, e l'ho trovato meraviglioso! Beh, il protagonista è un musicista di musica classica, con tutte le frustrazioni del contrabbassista di fila in orchestra. Però effettivamente, in tutto il rapporto maniacale con lo strumento, mi ci sono visto. Il fatto del freddo, di portarlo in camera d'albergo e metterlo sul letto perché non c'è spazio...
Mi sono ritrovato meno nella parte in cui definisce il contrabbasso come lo strumento meno musicale che ci sia. O meglio, non mi ci ritrovo, ma capisco tutta la letteratura sull'argomento. Ne ho la riprova ogni volta che giro per aeroporti con il mio flight case. Nonostante abbia la sagoma del contrabbasso, sento commenti di ogni tipo. Gente che pensa sia un trombone, un violoncello (e qui già ci avviciniamo), un chitarrone (strumento mitologico che non esiste), un clavicembalo...
AAJ: Sul contrabbasso sei autodidatta. Cosa vuol dire studiare uno strumento in questo modo?
P. D.P.: Sono autodidatta nel senso che non ho frequentato scuole o maestri. Però ho comunque avuto, tramite la chitarra, l'approccio allo studio classico, inteso come metodologia.
Facevo domande. Ad amici contrabbassisti, ai musicisti ai concerti... Ricordo che alla fine di un concerto di Dave Holland mi presentai. Lui fu molto gentile e mi mostrò un esercizio. Chi più chi meno, molti musicisti mi hanno aiutato in questo modo. Nei concerti c'è un approccio visivo, che è una grande scuola. Ricordiamoci che stiamo parlando di jazz, e dunque di una musica che ha ancora una trasmissione essenzialmente orale.
Il metodo di studio che ho adottato è comunque quello classico, perché ti dà l'impostazione, l'intonazione. Con l'arco, l'impostazione è fondamentale: la nota è piena di armonici, se stoni si avverte di più.
Dal punto di vista armonico poi, la chitarra mi è stata utilissima, quanto meno a livello di conoscenza teorica (l'armonia funzionale), e di conoscenza nelle orecchie. Sentire una progressione di accordi sulla chitarra è diverso...
AAJ: Avevi dei modelli, dei musicisti di riferimento?
P. D.P.: I modelli iniziali sono stati tanti, a cominciare da Jimmy Garrison, Scott La Faro, Mingus ... Charlie Haden con Ornette, con il trio di Jarrett...
Poi, tramite Bill Evans ho scoperto Eddie Gomez, Gary Peacock... C'è un unico disco di Peacock con Bill Evans, bellissimo, Trio 64... Gary Peacock con Albert Ayler, con Don Cherry...
Ho avuto un processo inverso di conoscenza del jazz. Sono partito con dischi che rappresentavano la contemporaneità, per poi andare indietro verso i grandi nomi della storia del jazz. A Love Supreme è stato il disco che mi ha sconvolto, pur non capendo niente di quello che succedeva. Sentivo questa immensa energia, questa macchina ritmica... E' stata un'autentica tranvata, come si dice a Milano.
AAJ: Peraltro, questo processo inverso è abbastanza tipico della nostra generazione....
P. D.P.: Chiaramente c'è stata un'intersecazione: il jazz-rock. Che per quelli della mia generazione è servito da ponte, da chiave per aprire l'immenso mondo del jazz.
Stiamo parlando degli anni '70. Molti festival (Siena, Bergamo, i concerti alla Statale di Milano), erano legati alla musica improvvisata. Quindi, contemporaneamente al jazz-rock mi si è aperto il mondo del free. E contemporaneamente, dato che sono un tipo curioso, mi si è aperto anche il mondo della musica etnica, e quello della musica contemporanea (Stockhausen, Ligeti, Varèse...)
AAJ: E i tuoi modelli oggi?
P. D.P.: Non ho mai cercato di focalizzarmi troppo su certi nomi. E' inutile fare il verso ai grandi musicisti. Come approccio allo studio, può essere utile rifare una linea di Ron Carter o Paul Chambers. Poi però devi riuscire a tirare fuori farina del tuo sacco. Il mio percorso è fatto di tutti questi ascolti, di tutte queste frequentazioni.
AAJ: Oltre che musicista, sei anche insegnante. Cosa vuol dire passare dall'essere autodidatti all'insegnare in una struttura codificata, per molti versi in modo abbastanza rigido, come il Conservatorio?
P. D.P.: Prima di arrivare al Conservatorio ho fatto tantissimi anni ai seminari di Siena, e ho dato lezioni private. Quindi ho sviluppato un mio approccio alla didattica. Comunque ogni tanto ci penso e mi viene da sorridere, perché in una struttura come il Conservatorio, sono un po' un outsider.
AAJ: Cosa cerchi di trasmettere ai tuoi studenti?
P. D.P.: Se parliamo di seminari di qualche giorno, cerco di focalizzare i punti critici su cui lavorare, cerco di dargli qualche dritta per il futuro. Se invece parliamo di un rapporto più regolare, allora c'è un percorso tecnico-strumentale da sviluppare.
Cerco di mettere gli studenti in grado di lavorare in autonomia. Di mettere l'accento su come usare il materiale tecnico in materia creativa. Se sto facendo un esercizio su una linea di walking bass, su accordi dati, ho comunque una serie di opzioni, che mi pongono in un'ottica di instant composer. Ormai si trovano quintali di metodi. Però rimane questo divario, fondamentale nel jazz, tra come si scrive e come si suona. L'esempio del maestro può essere utile per accorciare i tempi di apprendimento.
AAJ: Oltre che musicista e compositore in senso stretto, ti occupi anche di musiche per film e teatro. Ovvero di musica che deve rispondere a certi requisiti, che possono essere sia puramente artistici (atmosfere, sollecitazioni emotive) che assai più pratici e concreti (durata dei brani, scadenze di completamento e consegna del materiale). Immagino che a questo corrisponda anche un modo di lavorare particolare, specifico.
P. D.P.: In realtà la mia esperienza in questo ramo è piuttosto limitata. Ho fatto le musiche per "Domenica" di Wilma Labate, le musiche per "Magia d'Africa," un documentario televisivo di Achille Mauri, ed ora sto scrivendo le musiche per un documentario su Inge Feltrinelli. Non stai parlando con Ennio Morricone... C'è però una premessa da fare. Chi mi ha chiamato per fare queste cose, lo ha sempre fatto conoscendo già la mia attività di jazzista. Quindi mi veniva richiesto di muovermi sul mio terreno. E' chiaro che devo confrontarmi con certi vincoli. Ad esempio la durata delle scene. Però queste sono cose che puoi gestire con "taglia e cuci" in fase di montaggio. In genere nelle musiche per film, si individuano due-tre temi, che vengono riproposti in varie versioni, riarrangiati in diverse configurazioni strumentali (duo, quintetto..).
Per me si tratta di una sfida interessante, perché trattandosi di materiale su commissione, sei spinto a scrivere, hai una finalizzazione che trovo molto divertente e stimolante.
AAJ: Componi sulla chitarra?
P. D.P.: A volte sulla chitarra, a volte sul contrabbasso. Uso anche il pianoforte, il computer. Per il montaggio dei pezzi, il computer è fantastico. Posso tagliare una parte, spostarla, ed ascoltare subito il risultato.
AAJ: Una domanda che ti pongo in quanto musicista milanese, direi anche solidamente radicato nel territorio, Dopo gli splendidi anni '80, jazzisticamente parlando la città ha vissuto quindici anni di vuoto. Negli ultimi due-tre anni la situazione mi sembra invece in netto miglioramento. Il tuo punto di vista?
P. D.P.: C'è stata una serie di tagli impressionanti. Mi ricordo i concerti in piazzetta San Fedele, Jazzman all'Arco della Pace... Queste manifestazioni avevano budget relativamente modesti, ma avevano il pregio di mettere in contatto con il jazz persone che non lo avevano mai ascoltato prima. Ad un certo punto, tutto quello che aveva a che fare con il jazz è stato segato.
Effettivamente negli ultimi tempi sono venuti fuori un po' di locali in cui i ragazzi possono fare jam session, ed alcuni luoghi istituzionali... C'è un piccolo trend positivo, ma per Milano mi sembra ancora poco. Manca un jazz-club come lo era stato il Capolinea, e per qualche anno anche il Tangram. Un luogo che funzioni come punto di riferimento, che garantisca una certa continuità. Tutto è nelle mani di poche persone, appassionate, che ci mettono il sangue, ma senza aiuti istituzionali.
Poi magari tra un mese esce un film su Monk, e il grosso pubblico riscopre il jazz. E' già successo in passato con film come "Bird" o "'Round Midnight," non è detto che non succeda di nuovo.
AAJ: Veniamo a Urban Raga, il tuo ultimo CD. Innanzitutto un'osservazione. Trent'anni di attività musicale, ed una produzione discografica molto limitata, almeno come leader.
P. D.P.: Pubblicare un disco ogni due anni dà una grossa visibilità e credibilità come band-leader. Per me, riuscirci sarebbe un successo. Sicuramente non sono molto prolifico, però c'è anche una certa difficoltà a trovare dei produttori, e non sempre riesci a fare tutto da solo. Nel caso di Urban Raga, ad esempio, inizialmente ho prodotto tutto io.
Nel jazz c'è un'oggettiva gerarchia tra gli strumenti. Una gerarchia diffusa sia tra gli addetti ai lavori, che nel pubblico. Prima c'è la tromba, poi i sassofoni, i fiati, il pianoforte, la chitarra... Poi arrivano il contrabbasso e la batteria. Per un trombettista, fare dischi è molto più facile che per un contrabbassista. Lo vedo anche con i miei colleghi, sia italiani che a livello internazionale. A parte Mingus, Dave Holland e Miroslav Vitous, i contrabbassisti hanno sempre fatto fatica.
E' anche vero che se un trombettista propone delle cose, le propone forte della sua capacità di dirigere la musica in tempo reale. Da contrabbassista questo diventa più complesso, perché non sei mai il solista principale.
AAJ: Le note di copertina dell'album sono costituite dalla poesia Mutation di Shelley. Ci vuoi dire qualcosa in più?
P. D.P.: Mi piace l'idea del cambiamento. Un concetto filosofico, che è anche un concetto musicale. Dolphy diceva "When you hear music, it's gone, in the air, and you can never capture it again.". Di tutte le arti, la musica è la più astratta e immateriale. Quello che fruisci, è. Dopo ti rimangono solo delle sensazioni, dei colori. Nient'altro. Secondo me è bellissimo.
AAJ: I raga. Come mai questo interesse per la musica indiana?
P. D.P.: Ho sempre ascoltato la musica indiana. Sono molto amico di Federico Sanesi, con cui nel 2004-2005 ho lavorato ad uno spettacolo che si chiamava "Crossing," un incontro tra India e Occidente. Durante quel periodo sono nati alcuni temi, che ho poi sviluppato per Urban Raga.
Non volevo fare né una cosa filologica, né una semplice coloritura etnica. Ho voluto piuttosto riflettere sul fatto che la musica modale indiana ha molti punti di contatto con il jazz. Ad esempio, per come viene trattato il materiale melodico. Un raga è una scala di cinque-sette note, con il ritorno. Nel ritorno a volte ci sono piccole alterazioni, che sono l'equivalente di un modo. Da questo materiale minimo, un solista indiano riesce a sviluppare un raga in tre tempi, paragonabile a una nostra sonata. Nella proliferazione di queste cinque-sette note, c'è tutta l'idea dell'improvvisazione jazzistica.
Ritmicamente si usano linguaggi differenti. Nella musica indiana non c'è il concetto di swing. C'è piuttosto il concetto di "battere," con sviluppi incredibili per quanto riguarda la composizione metrica. Però, trovo grande contatto tra lo sviluppo di un raga e l'improvvisazione jazzistica sui modi.
AAJ: L'album in realtà suona molto poco indiano, a parte la traccia che dà il titolo al disco. Direi anzi che c'è una prima parte piuttosto contemporanea e metropolitana, mentre la seconda parte tende ad avvicinarsi ad un linguaggio più squisitamente jazzistico. Sei d'accordo?
P. D.P.: Sì, mi ci ritrovo
AAJ: La traccia "Blu" è una melodia deliziosa, che per certi versi mi ha fatto venire in mente un'altra tua composizione molto delicata e cantabile, "Il Piccolo Principe". La cantabilità della melodia: un elemento irrinunciabile?
P. D.P.: Una melodia in fondo è una successione di note. Queste note possono essere consonanti, dissonanti... Io mi trovo sempre in bilico tra un approccio astratto e la natura latina che fa parte del mio DNA, che è atavica. Con questi due aspetti del mio carattere devo in qualche modo convivere. Il mio problema è quello di riuscire a mediare queste due componenti.
AAJ: Di questo elemento mediterraneo, culturale, irrinunciabile, mi aveva parlato anche Louis Sclavis...
P. D.P.: Per noi europei, il jazz è un approccio mentale. E' chiaro che entrare intellettualmente in contatto con questo linguaggio, richiede uno sforzo. Se nasci a Chicago, sei circondato dal blues, dal jazz. Quello è il tuo contesto musicale, la musica che ascolti quando sali su un taxi, in ascensore.
Per noi c'è la tradizione popolare, quella classica, quella dialettale (meravigliosa). Allargando l'area al bacino del mediterraneo, ci sono la cultura araba, jewish, spagnola, balcanica. Sono aree più vicine a noi rispetto al jazz.
Quindi, affrontando il jazz da europeo, non mi sono mai posto un problema di appartenenza, di schieramento. Questa cosa sì, quest'altra no. Se lo facessi, dovrei tagliare una parte del mio essere, che ha radici profonde nell'Europa, nel Mediterraneo.
AAJ: A cosa stai lavorando in questo momento?
P. D.P.: Come ti dicevo, sto scrivendo le musiche per un documentario su Inge Feltrinelli. Inoltre sto registrando un disco con Gianluca Petrella e Fabrizio Sferra.
Ho un trio con Roberto Cecchetto e Giovanni Falzone, con cui vorrei registrare.
E poi, siccome non ho mai fatto album in solo (anche per i motivi di cui sopra)... Penso che mi piacerebbe!
Foto di Roberto Cifarelli.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.