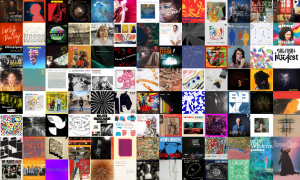Home » Articoli » Interview » Intervista a Greg Burk
Intervista a Greg Burk
Sinceramente mi annoio a suonare solo sugli accordi per un set intero, o solo free... la varietà è una cosa che mi stimola sia quando suono in concerto che su disco
Allievo di Paul Bley, Greg ha inciso pregevoli lavori per etichette statunitensi e la Soul Note, e dopo cinque anni d'insegnamento alla Berklee School di Boston, dal 2004 s'è trasferito a Roma.
All About Jazz: I tuoi dischi Carpe Momentum in quartetto con Jerry Bergonzi e Nothing, Knowing con Steve Swallow e Bob Moses hanno raccolto lusinghieri giudizi e molti critici ti giudicano tra i migliori pianisti della tua generazione. Mi sembra un buon momento per te. Cosa ne pensi?
Greg Burk: Credo che tante idee che ho iniziato a elaborare sei o sette anni fa sono maturate e i dischi che hai citato rappresentano, in modi diversi, il frutto di questa maturazione. Carpe Momentum lo è per quanto riguarda la composizione e la varietà degli approcci che partono da punti di vista diversi ma si integrano l'uno con l'altro. Nothing, Knowing si caratterizza, dal mio punto di vista, per la ricerca di un linguaggio personale.
AAJ: Parliamo del disco con Moses e Swallow. Moses lo conosci da tempo visto che è stato anche tuo insegnante, ma come nasce la collaborazione con Swallow?
G.B.: Steve Swallow è uno dei miei bassisti preferiti anche per i progetti che ha elaborato con Jimmy Giuffre e Paul Bley ed è un modello artistico che mi ispira molto. Dal punto di vista strumentale ammiro l'equilibrio che riesce a creare tra la funzione tradizionale del basso e la melodia. Così gli ho spedito una copia del mio primo disco Checking In. A lui è piaciuto molto, siamo rimasti in contatto e quando gli ho proposto d'incidere ha accettato. E' stato molto contento di suonare di nuovo con Bob.
AAJ: Rimaniamo a parlare di Checking In, disco che hai registrato nel 2002 con Jonathan Robinson e Bob Moses. La formula del piano trio continua a interessarti molto. Non la ritieni rischiosa con tutti gli organici magistrali che ci sono stati in passato?
G.B.: Eh certo, c'è una storia così ampia nel piano trio che sembra impossibile dire qualcosa di nuovo... però la strada che ho preso mi sembra non sia stata esplorata così tanto ed è appunto quella di fondere vari stili... io sinceramente mi annoio suonare solo sugli accordi per un set intero, oppure suonando solo free... la varietà è una cosa che mi stimola sia quando suono in concerto che nel progetto di un disco. Con il trio cerco di vedere in quanti diversi modi ci si può mettere in gioco...
AAJ: Restando al piano trio, ti relazioni preferibilmente con il bassista o con il batterista?
G.B.: Oddio, questa è una domanda difficile... sono due stimoli diversi. L'energia fisica viene più dalla batteria mentre gli aspetti legati alla forma e alla melodia vengono dal basso. Io per fortuna mantengo questo rapporto con John Robinson da 18 anni, abbiamo lavorato in molti progetti e con lui c'è un'empatia particolare, ci intendiamo all'istante. Ci siamo conosciuti nel corso di Archie Shepp all'università del Massachusetts, in un corso che si chiamava Revolutionary Concepts in Afro-American Music. Praticamente ci incontravamo con Archie per due ore a suonare pezzi di Charlie Parker...
AAJ: Il quartetto che hai presentato in giugno al festival di Bolzano, comprendente Robinson e il batterista John Arnold e Gaetano Partipilo ai sassofoni, è destinato a durare?
G.B.: Io spero che possa durare nel tempo perché mi piace e credo che funzioni bene. Mi piace molto Gaetano con il suo approccio aperto e tra noi tutti s'è stabilita una bella relazione. John Arnold, con cui ho cominciato subito a suonare quando sono arrivato a Roma, è un batterista di rara esperienza e musicalità.
AAJ: Hai scritto di aver trovato nel concetto taoista Wu-wei (azione senza sforzo) la descrizione più vicina al tuo ideale di improvvisatore. Ci puoi spiegare?
G.B.: Invece di prestare attenzione al contenuto il Wu-wei guarda l'azione. Questa si sviluppa in modo molto integro, dove non è vissuto un momento di pensiero quanto uno di movimento fluido. Questo favorisce un atteggiamento di consapevolezza in cui si è molto presenti ma allo stesso tempo rilassati.
AAJ: Come hai scoperto il jazz? Quali sono state le tue prime influenze?
G.B.: Alle superiori, quando ero ancora in Michigan, c'era una big band, il cui programma era inserito nell'orario regolare delle lezioni. Ogni mattina alle 10, nei cinque giorni di scuola potevi scegliere di fare big band. Io studiavo già da tempo il piano classico con grande frustrazione. Avevo voglia di far musica ma volevo fare cose diverse e in quella big band ho capito che sia l'improvvisazione che la composizione erano cose che mi coinvolgevano. Quindi ho cominciato a studiare con un insegnante d'università che mi prestò una cassetta contenente da un lato Portrait in Jazz di Bill Evans e dall'altro Now He Sings, Now He Sobs di Chick Corea. Io l'ascoltavo tutte le notti prima d'andare a dormire: quando c'era Evans facevo sogni belli mentre se c'era Corea ero sempre un po' impaurito... Da lì è iniziato tutto...
AAJ: Vuoi riassumere le tue principali tappe formative?
G.B.: Le mie prime esperienze importanti sono state a Detroit. Quando ho vissuto in quella città spesso ero l'unico bianco sul palco e sempre il musicista più giovane e inesperto. Mi hanno fatto un gran favore i musicisti facendomi suonare con loro.
AAJ: Suonavi con jazzmen afro-americani?
G.B.: Si. Ho vissuto due anni a Detroit suonando con musicisti della generazione degli anni cinquanta e sessanta: Larry Smith, George Goldsmith, Marcus Belgrave. Tutto è iniziato dopo la laurea in lettere. Io volevo fare il pianista jazz ed ho saputo che a Detroit c'erano musicisti fantastici e si poteva affittare un appartamento con 200 dollari al mese... Quindi sono andato a vivere lì suonando nei locali, insegnando pianoforte e facendo esperienza. Una cosa che a New York o Boston era impossibile. Alcuni musicisti che ho conosciuto a Detroit vivevano lì dagli anni cinquanta quando erano attivi Tommy Flanagan e Barry Harris: tutti nomi sconosciuti nel mondo del jazz ma boppers straordinari. Io ero lì con una decina di altri giovani che facevano apprendistato sul campo, gente come Gerald Cleaver, Rodney Whittaker, Jaribu Shahid, Ali Jackson, James Carter, Dwight Adams e altri.
AAJ: Com'era il rapporto con loro?
G.B.: Erano molto generosi. Io non sono cresciuto ascoltando jazz, come tanti musicisti di Detroit, e stavo ancora imparando il linguaggio ma non me lo facevano pesare. Vedevano che stavo cercando di imparare e mi accoglievano con benevolenza. Poi, quando mi sono trasferito a Boston, c'è stata l'esperienza con la Either/Orchestra con cui sono stato varie volte in tour, in Europa e in Africa. Lì si respirava un bel clima di ricerca e una forte identità di gruppo. L'orchestra aveva una ritmica fantastica, con un batterista del Suriname e un percussionista di Santo Domingo che avevano una grande profondità ritmica, per me sconosciuta. L'ultima cosa che vorrei ricordare è stata l'esperienza di studio con Paul Bley e Bob Moses. Io allora ero molto nel modello del mainstream, volevo suonare come Herbie Hancock. Bley mi ha aiutato a capire che la cosa più importante è la scoperta della propria identità. Moses, in particolare, mi ha insegnato l'importanza dell' intento del musicista quando suona, di dare se stesso. Questa è stata l'ultima fase della mia esperienza formativa.
AAJ: Hai trovato stimoli in altre forme di espressione (musicali e non) oltre il jazz?
G.B.: Negli anni in cui vivevo a Detroit dipingevo, infatti nel mio prossimo disco in uscita per la Soul Note, la copertina rappresenta un mio quadro di allora. Per restare nel campo musicale sono stato anche molto attratto dalle musiche etniche, in particolare dal canto dei pigmei.
AAJ: Da quanto tempo vivi in Italia? Ti trovi bene?
G.B.: Si, mi trovo molto bene. Quello che mi piace dell'Italia in relazione al mio mestiere di musicista è che c'è curiosità, appetito per la musica dal vivo. Si dà valore all'atto di chi crea musica creativa per il pubblico.
AAJ: Negli Stati Uniti non è cosi?
G.B.: Per quanto riguarda la mia esperienza, direi di no. A Detroit era un po' diverso ma a New York o Boston il pubblico per cui suonavo era composto in gran parte da musicisti o da "vecchi" appassionati. Pochissimi giovani o persone che venivano ad ascoltare per curiosità. Sono stato ad ascoltare Marylin Crispell a Boston ed eravamo trenta persone, una volta è venuto Paul Bley e ce n'erano trentacinque. In Italia se suono in una piazza vedo le famiglie con i bambini. Ci sono molti giovani che si espongono alla musica dal vivo... è molto bello.
AAJ: Tra i pianisti della tua generazione, ad esempio Mehldau, Shipp, Moran, Svensson, Gustavsen, chi preferisci?
G.B.: Direi Jason Moran, anche se tutti quelli che hai nominato hanno raggiunto la meta più alta per un musicista, un'identità spiccata che si riconosce dopo pochi istanti. Io aggiungerei pure Stefano Bollani e Stefano Battaglia sempre restando dentro la mia generazione. Gia' prima di venire in Italia apprezzavo molto Enrico Pieranunzi. Ha un'attenzione al dettaglio incredibile...
AAJ: Hai detto di avere un nuovo disco in uscita?
G.B.: Ho due dischi in attesa di pubblicazione. Uno è quello per la Soul Note che si chiama Berlin Bright, inciso con quattro musicisti che vivono a Berlino. Il bassista Jonathan Robinson, il sassofonista tedesco Ignaz Dinnè e il batterista italiano Andrea Marcelli.
Poi c'è un disco in trio, IVY, che sarà pubblicato in autunno dall'etichetta di Chicago, la 482 Music. Il disco è stato inciso poco prima di trasferirmi in Italia.
AAJ: Hai un sogno nel cassetto?
G.B.: Vorrei trovare il modo di mantenere il mio interesse per il jazz e l'improvvisazione ma anche assimilare elementi un po' diversi come la voce, aspetti ricchi di groove, eccetera. Una sintesi in po' più ampia, per capirci.
Foto di Roberto Cifarelli
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.