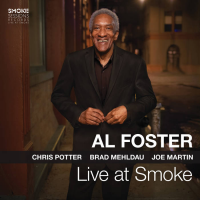Home » Articoli » Interview » Intervista a Beppe Scardino
Intervista a Beppe Scardino
All About Jazz: Beppe Scardino, oggi sei considerato, come si suol dire, un giovane musicista "emergente"... Da dove sei partito per arrivare fin qui?
Beppe Scardino: Direi da Livorno, dove sono nato, dove ho iniziato a suonare da autodidatta e dove ho incontrato il mio primo mentore, la mia prima guida: Dimitri Espinoza, che - com'è noto - ha svolto un ruolo di talent scout per diversi musicisti, come Gabrio Baldacci. Per me è stato il primo vero maestro: quando decisi di suonare il sassofono, verso diciassette anni, lo incontrai quasi subito e lui non solo mi incoraggiò moltissimo, ma assai rapidamente mi coinvolse in iniziative ed eventi. Inoltre, Dimitri mi ha trasmesso una certa serietà nel metodo di lavoro, l'onestà e la non scontatezza nel fare musica. Per cui, di sicuro per me aver incontrato Dimitri all'inizio della carriera è stato importantissimo. Direi che grazie a lui ho capito subito che la musica è un linguaggio come altri, che richiede attenzione e competenza, ma anche e soprattutto richiede che si abbia qualcosa da dire. Qualcosa che non è detto stia dentro la musica, perché questa non è tutto, non esaurisce il mondo.
Il mio apprendistato, poi, si è scandito su varie esperienze con diversi musicisti. Dopo Dimitri e i musicisti del Dinamitri ci sono stati quelli dell'area bolognese, perché nel 2001, quando decisi di dedicarmi alla musica, mi trasferii a Bologna, dove ancora risiedo. E qui i primi e più importanti incontri sono stati con alcuni musicisti dell'area Bassesfere: Calcagnile, Caliri, Marraffa, Puglisi, Borghini, Mirra, i quali - nonostante che all'epoca al sassofono fossi un autentico disastro! - sostituirono Dimitri nel sostenermi e nutrirmi di fiducia, spingendomi a migliorarmi.
Il nuovo ambiente e la conoscenza di forme di musica per me ignote, uniti alla fiducia, furono di grande stimolo. Così pian piano ho iniziato a lavorare con musicisti e dentro formazioni che erano più avanti rispetto al mio livello, come con il Dinamitri. Queste "prove" mi hanno portato a capire che potevo fare delle cose, se solo l'avessi voluto e mi fossi impegnato. Mettere a fuoco questo, avere fiducia in me stesso, sapere di poter suonar bene - che per un musicista non è facile da riconscere! - è una cosa che ho compiutamente realizzato solo abbastanza di recente, ma mi ha dato molta tranquillità.
Un altro passaggio importantissimo della mia carriera è stato l'incontro con El Gallo Rojo, avvenuto quando il collettivo stava nascendo (anche se io sono entrato a farne parte qualche tempo dopo). Danilo Gallo e Zeno De Rossi, e poi tutti gli altri musicisti del collettivo, sono stati incontri importanti, infatti la mia musica ha cominciato a prendere forma con loro: il mio ingresso nel collettivo è coinciso con l'uscita del CD di Orange Room per l'etichetta del Gallo.
AAJ: Come funziona il collettivo?
Beppe Scardino: Per un certo periodo c'è stato movimento tra i membri, perché stavamo definendo la nostra identità; adesso il gruppo è abbastanza stabile e credo che per un po' resteremo quelli che siamo. E poi non è che ci sia la fila di persone che vogliono entrare! Anche perché l'impegno è grosso e giornaliero: giri di mail, studio dell'organizzazione, cura dell'etichetta discografica, e poi c'è una periodica autotassazione...
AAJ: Vi autogestite anche il booking e la promozione dei dischi?
B.S.: Il booking ognuno lo fa per i propri gruppi, mentre per i dischi ciascuno ha un compito nell'organizzazione complessiva: chi spedisce i promo, chi segue le stampe, chi si occupa della SIAE, ecc. Tutto molto "casalingo," ma anche professionale. A condizione, però, che ognuno si faccia carico della propria responsabilità, altrimenti non funzionerebbe più niente.
AAJ: Secondo la tua impressione, siete in grado di tenere almeno in parte testa alla promozione organizzata?
B.S.: Vanno distinti due piani. Il primo è quello discografico, sul quale noi offriamo un prodotto che - aldilà della musica, che può piacere o meno - è curatissimo non solo dal punto di vista dei suoni e della registrazione, ma anche da quello della grafica, perché Massimiliano Sorrentini è, oltre che un ottimo batterista, un bravissimo grafico e ha lavorato molto per far sì che tutti noi sviluppassimo una sensibilità rispetto agli aspetti anche visivi dell'oggetto artistico discografico. Grazie a questa qualità del prodotto, nonostante l'organizzazione "casalinga" e low profile riusciamo a vendere abbastanza: ai concerti, attraverso la rete, con la vendita digitale, ecc.
Il secondo piano è invece quello concertistico, che è poi quello che "ci dà da mangiare" - perché coi dischi, si sa, soldi non se ne fanno. E qui le cose, purtroppo, sono un po' più complicate. La mia impressione è innanzitutto che in Italia ci sia una discreta esterofilia. Sia chiaro, non mi auspico un'Italia "nazionalista," però vedo che in Scandinavia, ma anche in Germania o in Francia, i direttori artistici cercano di investire nei musicisti locali, così che si sono formate delle buone scuole di sperimentazione e avanguardia artistica. In Italia, invece, a parità di condizioni si preferisce il musicista straniero. Lo dico senza polemica, come un dato, anche se ovviamente è una cosa che ci rende la vita più difficile, e aggiungendo che, fortunatamente, esiste anche una minoranza di organizzatori che invece cercano di fare diversamente.
Poi c'è il problema delle sovvenzioni e dei finanziamenti dello Stato alla cultura, che non è certo colpa dei direttori artistici, ma aggrava la situazione: io ho abitato per un anno in Danimarca e ho visto bene la differenza che c'è, per i giovani musicisti locali, rispetto al nostro paese.
Di fronte a questo quadro, ciascuno di noi promuove i propri gruppi - io, ad esempio, mi occupo della promozione di Orange Room e Pospaghemme - con enormi difficoltà, perché gestire il booking richiede un sacco di tempo che devi sottrarre alla musica... Credo che la cosa dipenda dal fatto che in Italia c'è un numero smisurato di festival e che spesso, per una serie concatenata di ragioni, la cosa più semplice anche per gli organizzatori è affidarsi alle grandi agenzie. Ciò produce quel fenomeno dei quali forse troppi si lamentano, cioè una predominanza di concerti di una rosa di musicisti. Io non mi associo a queste lamentele, per due semplici ragioni: primo, perché quegli artisti piacciono a larga parte del pubblico; secondo, perché spesso sono anche bravissimi musicisti. Non vedo pertanto perché dovrei lamentarmi della loro presenza o pretendere di avere spazio io al posto loro. Certo, m'immagino uno scenario più pluralista, con "finestre" anche su proposte diverse e artisti che, di solito, sia per genere che per pretese economiche non sono neppure in concorrenza con i "big". Questo richiederebbe probabilmente dei direttori artistici con una maggiore cultura musicale, o almeno con maggiore curiosità.
AAJ: Apprezzo molto il tuo discorso, segno peraltro di una persona che sta pensando alla propria musica prima che al proprio successo o al proprio ego. E condivido anche l'esigenza di allargare le proposte dei festival, condizione necessaria perché si allarghino anche gli orizzonti del pubblico.
B.S.: Io prendo sempre ad esempio festival come quello di Saalfelden, o ancor più quello di Bergen, in Norvegia, dove sono andato con il Dinamitri un paio d'anni fa: c'era di tutto, dagli Zu a Macy Gray, dal free al soul, e poi il mainstream, Uri Caine... Ecco, un posto dove si abbia la possibilità di ascoltare varie declinazioni del jazz, delle musiche afroamericane e d'improvvisazione. Io sono contento e mi ritengo fortunato per aver potuto fare concerti anche in autorevoli location, come quello a Metastasio Jazz di Prato, però uno scenario del genere permetterebbe di poter avere più spazi e di impazzire meno per "piazzare" i nostri gruppi.
AAJ: Ma secondo te perché questo in Italia non avviene?
B.S. : La mia opinione è che alla radice ci sia una mancanza di strumenti per decifrare la musica, perché ora come ora in Italia i musicisti sono molto più avanti rispetto agli addetti ai lavori. Non vorrei essere frainteso, come talvolta è successo, per cui mi spiego meglio. Io penso che per comprendere la musica, anche quella considerata "difficile" come la mia, non sia necessario alcun tipo di preparazione; anzi, una musica che richieda della preparazione da parte del pubblico a me non interessa proprio, perché vorrei che il messaggio fosse indipendente dalla preparazione. Però, chi svolge un'attività professionale nel settore della musica - intendo critici, giornalisti, direttori artistici, ecc. - credo dovrebbe avere una preparazione che gli permetta di capire dove si dirige la ricerca, quali cose innovative o originali stanno nascendo, per inquadrarle all'interno del panorama generale e delle programmazioni particolari. E, su questo, in Italia vedo grossi limiti.
Poi, è anche vero che in Italia ci sono tali e tanti problemi che mi fermo subito ed evito di lamentarmi troppo. Però, se vogliamo provare a fare una diagnosi, questo è il mio contributo.
AAJ: Sono perfettamente d'accordo, chi lavora nel settore dovrebbe preoccuparsi tanto della sua preparazione, quanto della ricchezza - anche in termini di "biodiversità" - del settore di cui si occupa. Anche perché, come dicevo, cosa si scrive e cosa si propone nei programmi influenza la cultura del pubblico, perché il jazz è una musica complessa e - soprattutto - così multiforme che l'ascoltatore medio non può orientarsi completamente da solo. E non è sensato lasciare che sia orientato solo dai "premi" e dalle "classifiche".
B.S.: Certo, però è anche vero che poi i premi e le classifiche non è detto che contino così tanto. Per fare un esempio, la Cosmic Band di Petrella, di cui faccio parte, quest'anno ha vinto il top jazz, ma paradossalmente ha più difficoltà degli anni scorsi a trovare concerti. Sarà perché è un gruppo ampio e perciò costoso, saranno i tagli agli enti di cultura, fatto sta che il premio stavolta non ha avuto esiti sul piano dei concerti per un gruppo che, oltretutto, è al culmine del suo potenziale.
AAJ: Veniamo ai tuoi progetti attuali, o meglio quelli che stai portando avanti da un po' di tempo, cominciando da Pospaghemme.
B.S.: Pospaghemme è un duo con Federico Scettri, nato in modo spontaneo quando ci siamo conosciuti, alcuni anni fa, e che si avvale del fatto che abbiamo provato e riprovato, suonato e risuonato assieme, dato che vivevamo entrambi a Bologna. Questa è una cosa che ad un gruppo succede di rado e la cui mancanza, in misura maggiore o minore, pesa sempre. Ciò ci ha permesso di crescere assieme e di consolidarci durante una residenza a Correggio, con musicisti della Cosmic Band. Dopo quel concerto abbiamo cominciato a crederci di più, abbiamo organizzato una serie di composizioni che potevamo sfruttare e, dopo una serie di concerti, l'anno scorso abbiamo registrato a Livorno, nello studio di un ottimo ingegnere del suono (e musicista), Antonio Castiello.
Ho ottimi ricordi della sessione di registrazione: eravamo perfettamente a nostro agio e abbiamo così potuto dare una prospettiva ampia sulla nostra musica, affrancandoci anche in modo un po' provocatorio da ciò che un ascoltatore si aspetta che "debba" esserci in un disco: una forma (che invece propriamente nel nostro disco non c'è), composizioni e pezzi in cui "succede qualcosa" (mentre nel disco ci sono brani in cui non succede quasi nulla)... Ecco, prospettive diverse, momenti nei quali, in piccoli affreschi, si sviluppano situazioni timbriche, si esaltano le dinamiche, si gioca con i suoni... In più, accanto a queste miniature, ci sono alcune composizioni più "classiche" del nostro duo baritono e batteria, nelle quali ci siamo sbizzarriti a suonare molto liberamente.
AAJ: Come si incastrano le composizioni con la libertà creativa e il superamento della forma?
B.S.: Ogni pezzo ha i suoi modi, anche perché le mie composizioni sono diverse da quelle di Federico. I suoi brani - ad esempio "Empty 2000" e "CUP 4° piano" - sono strutturati come piccoli racconti, con eventi che si succedono senza un unico tema principale; i pezzi miei hanno invece strutture più complesse anche se forse più tradizionali: ad esempio "L.O.V.E.," la title track, è un tema che si sviluppa ottavo per ottavo, simile a cose che avevo sentito fare a Braxton. Nel disco ci sono inoltre episodi totalmente improvvisati: parti nate liberamente in modo estemporaneo, dove abbiamo giocato di più con i suoni. Ad esempio, ho trovato nello studio un banjo (era di Bobo Rondelli, perché Antonio Castello è il suo fonico) e non ho resistito alla tentazione di suonarlo! E poi abbiamo usato tastierine, oggetti comprati nei negozi cinesi...
In generale, si tratta di un disco basato su giochi di note e suoni, con sovraincisioni ed esplorazione degli spazi timbrici e sonori. E' un disco pieno di divertimenti, come l'ultimo brano: "What About a River," una sorta di canzoncina priva di senso, liberamente ispirata alla musica country (di cui sia io che Fede siamo ammiratori) e a tutto il suo universo. Ci piacerebbe che il nostro prossimo disco fosse esclusivamente di canzoncine surreali come questa, vedremo...
AAJ: Si tratta di un gruppo di musica non facile. Quali risposte di pubblico avete incontrato?
B.S.: A dire il vero buone. Anche in situazioni atipiche, di fronte a un pubblico non di jazzofili, perché le situazioni che creiamo - ludiche, provocatorie, ironiche - catturano anche chi non sia avvezzo a questo genere di musica.
AAJ: Mi fa l'impressione che sia un gruppo forse più vocato per situazioni atipiche che, ad esempio, per i jazz club, nei quali un duo baritono-batteria che sperimenta suoni e dissoluzione della forma potrebbe destare non poche perplessità... Un po' come accadde a Ornette, il quale - a quanto racconta Berendt - nei primi anni '60 era rifiutato dal pubblico, ma quando fu fatto esibire di fronte a una platea di bambini, questi lo seguirono con grandissima attenzione...
B.S.: Hai chiosato perfettamente l'intento del gruppo, che è quello di rivolgersi ad ascoltatori con l'orecchio ancora vergine, infrangendo le sovrastrutture che un ascoltatore navigato si è formato nel corso degli anni.
AAJ: Quali riferimenti avevate in mente al momento di andare in studio?
B.S.: A dire il vero ben poco, anche perché io non avevo mai sentito un duo di baritono e batteria. E poi, a tavolino non avevamo deciso nulla. Ma, del resto, le vere influenze sono quelle che vengono fuori spontaneamente, inconsciamente, perché sono quelle dalle quali passano le cose che ti stanno a cuore.
AAJ: Infatti, hai parlato di sperimentazione del suono e ciò è coerente con quelli che so essere i tuoi riferimenti e le tue ispirazioni: Braxton, Roscoe Mitchell, Coltrane...
B.S.: ... Hemphill, oggi direi soprattutto Julius Hemphill. Negli ultimi due anni è il musicista che più mi ha influenzato, anche perché ho ascoltato una serie di lavori poco conosciuti per archi, per legni, perfino per big band... Si tratta di un autore inesauribile, per altro anche difficile da esaurire per l'estrema difficoltà di reperire materiali inediti. Anzi, poiché assieme a Gabrio Baldacci avremo modo di lavorare con Tim Berne, credo che in quell'occasione lo tormenterò per avere più notizie possibile, visto che è stato discepolo di Hemphill e, con Marty Ehrlich, tra coloro che hanno cercato di valorizzarlo dopo la morte. Tra l'altro sul sito della Screwgun, la sua etichetta, c'è uno scritto di Berne su Hemphill che per me è stato molto illuminante. Consiglio a tutti di andarselo a leggere.
Comunque, anche gli altri che hai citato fanno parte dei miei interessi degli ultimi anni: nel 2005 ho avuto modo di incontrare Anthony Braxton, Roscoe Mitchell e Muhal Richard Abrahams (il padre di tutti) ai seminari di S. Anna Arresi ed è stata un'esperienza fortissima. Soprattutto Braxton e Mitchell sono quelli che a mio avviso stanno facendo il lavoro più avanzato sul bilanciamento tra scrittura ed improvvisazione, che è poi la frontiera che oggi mi interessa di più. Un interesse che va ovviamente aldilà di Pospaghemme, nel quale - per la struttura che ha, il duo - vengono fuori altri miei ascolti, dai Nirvana a Robert Johnson, da Coltrane a Bob Dylan. In Pospaghemme l'improvvisazione è gioco e spontaneità...
AAJ: ... mentre in Orange Room è qualcosa di molto diverso...
B.S.: Sì, perché è un gruppo "serio," cameristico; perché siamo in sei; e perché lì c'è una mia direzione musicale e, soprattutto con i pezzi nuovi che stiamo suonando attualmente, c'è molta scrittura. Per questo, è proprio in Orange Room che anch'io sto cercando un mio bilanciamento tra improvvisazione e scrittura.
AAJ: Ti chiederei appunto un confronto tra la musica registrata sul CD ormai alcuni anni fa e quella invece che si può ascoltare adesso nei concerti.
B.S.: La musica del disco (che abbiamo smesso da un po' di tempo di presentare dal vivo) è piuttosto diversa da quella che facciamo oggi. Innanzitutto perché era da un certo punto di vista più semplice, in quanto si basava su prassi esecutive sostanzialmente consolidate. Anche lì venivano fuori tutta una serie di miei ascolti precedenti al periodo in cui ho scritto i brani (cioè il 2004-2005), come Andrew Hill, Charles Mingus o Jackie McLean. Di conseguenza, i pezzi erano unità ben delineate nelle quali si rintracciavano elementi chiari: lo swing, il giro di accordi, l'improvvisazione sul chorus, ecc., tutte cose che caratterizzano un certo modo di interpretare il jazz. In più c'è un brano, "Orange Room Simphony," che ha una forma allargata, è una successione di episodi con delle situazioni di improvvisazioni interne, e quindi si muove in una direzione diversa, anche se è ancora omogeneo al resto del repertorio.
A un certo punto, però, il gruppo ha deciso di fare tabula rasa e scrivere pezzi nuovi seguendo criteri diversi. Dico che ha deciso il gruppo perché sono sì io che dirigo e, quindi, prendo le decisioni, ma il gruppo è un collettivo nel quale tutti sono partecipi e hanno voce in capitolo. Infatti, anche dopo la svolta quel che è rimasto immutato è stata in primo luogo la dimensione collettiva della musica. La quale è così tangibile, che c'è stato chi mi ha detto: "complimenti, il disco è molto bello, ma - stranamente - tu non ne emergi". Ebbene, io questo non lo capisco: quando fai un disco non è necessario che tu sia sempre in prima fila, che tu emerga come solista. Quel disco di Orange Room è sì ancorato a una prassi jazzistica nel quale l'assolo ci può stare e ha il suo valore, però non c'è ragione di pensare che, poiché il disco è mio, gli assolo predominanti debbano essere i miei. Al contrario, sono sempre stato molto attento a far sì che gli spazi fossero distribuiti quanto possibile equamente. E questo perché mi piace che la musica abbia sempre un respiro collettivo e perché lo stare assieme come gruppo ha valore anche perché si lavora come individui al servizio del collettivo e non come attaccanti contenti di fare tre gol anche se la squadra perde.
AAJ: Capisco. E aggiungerei che, in realtà, il modello secondo il quale il leader dovrebbe essere anche l'assoluto protagonista della scena è piuttosto falso e smentito dalla storia del jazz. Ellington o Mingus facevano una musica assolutamente personale e perfettamente identificabile, però sulla scena non monopolizzavano l'attenzione. La musica era loro, ma i protagonisti erano i musicisti del gruppo.
B.S.: Esatto, proprio questo era quel che mi interessava quando ho messo in piedi Orange Room. Una logica che forse è oggi più in auge nel rock che nel jazz: io ho modo di collaborare ogni tanto con musicisti rock, per esempio con il gruppo livornese dei Virginiana Miller, e osservo sempre come siano estremamente attenti a questa dimensione, misurino con il contagocce ogni intervento... Forse bisognerebbe imparare qualcosa da quel campo.
AAJ: Aggiungerei che, oltretutto, i musicisti di Orange Room sono tutti dotati di forti personalità e che non sarebbe né facile, né giusto "sottometterli".
B.S.: No, ancor più se si considera che ciascuna di quelle forti personalità è anche il latore di idee, energie, suggestioni nate e sviluppate in altri gruppi e collettivi che ruotano attorno al nostro, e che il progetto Orange Room si nutre essenzialmente di quelle idee ed energie. Quindi è chiaro che il gruppo deve funzionare come un collettivo: io scrivo i pezzi, dirigo, ma quando siamo al momento della creazione della musica non posso essere sordo a quel che mi dicono i compagni, né posso prendermi la scena come se fossi da solo.
AAJ: Tornando alle differenze tra il disco e l'attuale Orange Room, mi sembra che ci sia stato un cambiamento nell'organizzazione della musica e, di conseguenza, dei modi in cui vengono utilizzate le potenzialità del gruppo.
B.S.: Come dicevo prima, al centro della svolta c'era la nostra ricerca originale di un bilanciamento tra scrittura e improvvisazione. Il modo in cui cerchiamo di farlo passa innanzitutto attraverso l'allargamento delle forme di ciascun pezzo, che spesso restano mutevoli e possono cambiare di esecuzione in esecuzione. In secondo luogo, utilizziamo la scrittura sia in modo classico, sia dando anche ad essa un ruolo nell'improvvisazione. Come avrai visto nel concerto di Prato, alcune parti possono essere "chiamate".
In generale, le linee guida per la "lettura" dell'attuale repertorio di Orange Room sono queste: nuovo bilanciamento del rapporto tra scrittura e improvvisazione, e abbandono delle forme jazzistiche tradizionali. Di queste ultime rimane l'armonia, però si tratta di un'armonia che si rifà più alla musica classica contemporanea che al jazz: ci sono contrappunti, polifonia e politonalità, e soprattutto una marcata ricerca timbrica. Per favorire quest'ultima, ad esempio, i tre ancisti suonano tutti più strumenti: io sax baritono e clarinetto basso, Francesco Bigoni sax tenore e clarinetto, Piero Bittolo Bon sax alto, clarinetto contralto e flauto. Questo dà alla musica un maggiore spettro timbrico, ma anche delle tinte dinamiche più estese, perché con i clarinetti e il flauto puoi suonare dei pianissimo che non puoi fare con i sassofoni.
AAJ: Le strutture "a chiamata" sono scelte o reiterate sul momento secondo l'ispirazione di chi, a turno, ha la direzione - perché ho visto che, quando tu sei impegnato allo strumento, altri ti sostituiscono - oppure sono predeterminate? E questo modo ha a che vedere, ad esempio, con la Conduction di Butch Morris?
B.S.: No, non ha molto in comune con la Conduction, che è un'improvvisazione guidata, mentre ha molto a che fare con una metodologia che ho visto usare a Braxton (e che con lui ho sperimentato). L'idea è quella di avere un database di microcomposizioni che, all'occorrenza, possono essere messe in gioco. Si tratta in fondo di una parte della più complessa ricerca musicale degli ultimi anni di Braxton. Io mi sono limitato a riprendere quest'idea, che mi era parsa particolarmente efficace, di avere a disposizione delle sottocomposizioni, richiamare le quali ha la stessa funzione dell'improvvisazione.
AAJ: Ho l'impressione che questo genere di strutture si apprezzino molto di più dal vivo, con la percezione visiva dell'interazione dei musicisti, che ascoltando la registrazione. Tu cosa ne pensi?
B.S.: Di sicuro il fine di questa musica è di essere suonata di fronte al pubblico. Lo dimostra il fatto che gran parte dei dischi di Braxton sono concerti. E questo perché ogni concerto è una composizione istantanea, in quanto ogni volta succedono cose che rendono la musica diversa da com'essa può essere in un'altra sua occorrenza. La nostra musica è diversa, meno complessa e con meno regole di quella di Braxton, e segue anche altre influenze; tuttavia, anche nel nostro caso la vocazione live è un tratto essenziale.
AAJ: Ti ho fatto la domanda anche perché questa cosa, in realtà, è un po' in contrasto con quel che dicevi all'inizio della nostra conversazione, cioè con la tua pretesa di fare una musica che non abbia bisogno di preparazione. Qui, l'ascolto del disco non "preparato" dall'aver precedentemente assistito a un concerto rende la fruizione sostanzialmente "incompleta". Per esemplificare con un esempio: una dozzina d'anni fa apprezzai molto un disco dei Rova in formazione allargata, The Secret Magritte, anche perché il libretto conteneva una scansione di quel che "avveniva" alla musica minuto per minuto. In assenza di una tale descrizione (o di un concerto precedente), probabilmente mi sarei perso nella complessità...
B.S.: Si, quello che dici è sicuramente vero. Se pensiamo alla musica senza chiederci un perché, abbiamo semplicemente una successione di suoni, un tessuto musicale, che da solo dovrebbe essere sufficiente per goderne. Dopo il concerto di Prato c'era una conferenza, nel corso della quale Stefano Zenni ha detto una cosa secondo me bellissima: "l'arte è andare in un posto dove non sei mai stato prima". Questo è in effetti ciò che cerca di fare chiunque faccia ricerca; ed è chiaro che per andare in un posto dove non sei mai stato prima non è necessario sapere come ci vai o perché ci vai. Però è anche vero che ci sono ascoltatori e ascoltatori: alcuni hanno "menti speculative" (io sono tra questi, e tu anche, mi sembra) che hanno bisogno di smontare le cose, di capire come funzionano, per goderne ancora di più. Per loro può essere utile avere delle chiavi di lettura e delle informazioni in più. Però a mio parere questo non è necessario, comunque non lo è per tutti.
AAJ: Può magari essere utile anche a chi, ascoltatore non sofisticato, sia restio ad abbandonare le sue aspettative, le sue pre-interpretazioni dell'ascolto - cose che, peraltro, ci portiamo sempre dietro, volenti o nolenti.
B.S.: Si, sono d'accordo. Posso immaginare un ascoltatore di jazz tradizionale che inorridisca di fronte a Orange Room - perché in fondo si tratta di un gruppo che potrebbe suonare in un festival di musica contemporanea - e che, con alcune indicazioni esplicative, invece potrebbe riuscire ad apprezzarci.
AAJ: Quando poi le indicazioni vengano non da una "spiegazione," ma dalla percezione visiva del concerto, la cosa assume anche un valore diverso, perché ri-unisce il suono con l'atto complessivo della sua produzione, che per molti suoi aspetti non si apprezza ascoltando, bensì guardando.
B.S.: Aggiungerei che il musicista dovrebbe essere sempre consapevole del fatto di venir anche "visto," oltre che ascoltato. Avere un linguaggio visivo all'interno della musica permette di aggiungerle qualcosa. Il fatto che io "chiami" un numero non solo ci permette di suonare la composizione richiamata da quel numero, ma il mio "gesto" ha anche una valenza scenica che influenza la performance.
AAJ: Ovviamente. Anche se questo, sebbene in forme diverse, aveva la sua importanza anche in passato. Vedere Miles dirigere il gruppo con i suoi sguardi e ammiccamenti serviva al pubblico per comprendere meglio i passaggi della sua musica e goderne in modo più completo. Questo aldilà dell'aspetto puramente scenico, perché il jazz non è una musica che si esegue e basta, ma vi ha parte il corpo, l'istante della sua creazione, ed assistervi ha la sua importanza.
B.S.: Sono perfettamente d'accordo...
AAJ: ...e però stai andando a registrare!
B.S.: Sì, dovremmo farlo nel corso della residenza veneziana al Teatro Fondamenta nuove, quindi in una situazione comunque diversa dalla mera sala di registrazione. Del resto il disco ha per me un valore di "documentazione," la fotografia di uno stato, di un livello raggiunto. Infatti, non è detto che, subito dopo la registrazione, il gruppo inizi un cammino nuovo, verso altre direzioni. Ho già un po' di idee in mente...
AAJ: ...sempre per andare in posti dove non sei mai stato!
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.