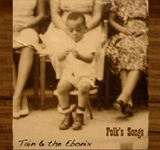Home » Articoli » Interview » Insegnare il jazz: intervista a Francesco Martinelli
Insegnare il jazz: intervista a Francesco Martinelli
Forse il jazz, più che un genere musicale, è diventato una specie di punto d’incontro, una casa comune, una sorta di forum mondiale in cui si ritrovano tutti e ciascuno riesce a sentirsi a proprio agio
All About Jazz: Inizierei con una domanda molto meno banale di quanto possa sembrare: quanto credi possa contare la conoscenza della storia del jazz nella formazione e nella crescita di un musicista?
Francesco Martinelli: Secondo me è fondamentale. È assolutamente impensabile che un musicista oggi creda di suonare jazz senza avere una conoscenza, non dico completa, ma quantomeno approfondita; senza avere proprio la passione di ascoltare le cose più importanti della storia del jazz; senza avere la passione di volersi avvicinare non soltanto a Charlie Parker e Miles Davis, ma anche a Duke Ellington, Jelly Roll Morton e Louis Armstrong.
Purtroppo siamo arrivati al paradosso che molti ragazzi vengono a Siena jazz e vogliono suonare gli standard basandosi sul fatto che hanno letto il Real Book, non perchè conoscono le incisioni originali di quegli standard. Oppure conoscono la versione di Petrucciani di “Take the A Train”, ma non hanno mai sentito l’incisione di Ellington. Potrebbe sembrare una questione marginale, ma non lo è affatto. Gli originali sono importanti e chi vuole accostarsi a questa musica deve cominciare a capire che il mondo sonoro del jazz classico, dello swing, del jazz dello origini, è un oggetto complesso, non è un qualcosa che si può ridurre facilmente a una dimensione unica, è un oggetto multidimensionale.
Un oggetto che io leggo in termini di presenza di elementi che si manifestano in modi diversi, ma che non sono diversi, nella musica di Coltrane, di Mingus, di Ellington oppure di Bechet.
AAJ: Qual’è la cultura musicale degli apprendisti improvvisatori che arrivano a Siena Jazz? Che cosa hanno ascoltato questi ragazzi prima di passare per le tue mani?
F.M.: Non c’è una risposta possibile a questa domanda. Nel senso che i percorsi sono tutti complicati, tutti individuali e tutti diversificati. Questi ragazzi arrivano a Siena per i motivi più impensabili: da quelli che si sono convinti perchè sono stati affascinati dai cantanti “crooner” della nuova generazione, tipo Harry Connick Jr., fino a quelli che sono approdati al jazz dopo aver ascoltato Zorn venendo dal metal o dall’elettronica. Un dato singolare rispetto al passato recente, è la scomparsa di quella generazione che era cresciuta musicalmente e culturalmente nelle filarmoniche di paese o nelle bande cittadine, mi viene subito in mente Minafra.
Difatti, soffriamo una carenza cronica di trombonisti, sassofonisti e trombettisti (anche se, ad essere sinceri, quest’anno è andata piuttosto bene), mentre ci sono chitarristi e batteristi in abbondanza. D’altro canto, quali sono gli strumenti musicali che un giovane oggi ascolta e vede? Chitarra elettrica, basso elettrico, batteria e tastiere.
Comunque, ritornando alla tua domanda, l’unica cosa che si può affermare con estrema certezza sulle tortuose strade che portano i ragazzi a Siena Jazz, è che ci sono una miriade di percorsi, ognuno diverso dall’altro.
AAJ: Forse anche perchè, diversamente da quanto accadeva fino a qualche anno fa, un giovane musicista ha la possibilità di ascoltare praticamente tutto, ha facilmente a disposizione l’intero universo musicale contemporaneo e non.
F.M.: Certo, ha la possibilità, ma non è detto necessariamente che lo faccia. E, soprattutto, non è detto che ascolti qualcosa avendo un’idea precisa di quello che sta ascoltando. Da questo punto di vista, la cultura dilagante del download e dell'iPod è pericolosissima, perchè priva completamente i brani musicali del loro contesto.
Il contesto è fondamentale e necessario per l’ascolto. La musica non è affatto un linguaggio universale. La musica cambia il significato a seconda dell’epoca e a seconda del posto. L’idea che la musica sia un linguaggio universale è un’idea positivista, che non ha nessuna consistenza oggi e veniva applicata soltanto alla musica classica europea, senza comprendere altre forme di espressione musicale.
AAJ: Una cosa che non manca, però, è l’entusiasmo e la disponibilità all’ascolto. Mi ha colpito, ad esempio, l’applauso spontaneo che è scattato in aula alla fine del duetto tra Earl Hines e Louis Armstrong in “Weather Bird”.
F.M.: Indubbiamente la ricettività, la voglia e anche l’entusiasmo non mancano. Ma il problema vero è che per prima cosa questi ragazzi devono essere abituati all’idea di ascoltare. Loro pensano di ascoltare la musica dedicandosi a qualche altra cosa e tenendo nel frattempo le orecchie occupate. Ma quello non significa assolutamente ascoltare musica; ascoltare musica vuol dire stare seduti e concentrarsi esclusivamente sul fatto musicale. Se si riesce ad insegnare a questi ragazzi ad ascoltare veramente per tre minuti, è chiaro che “Weather Bird” fa una certa impressione. Se “Weather Bird” invece lo riducono a colonna sonora di un qualcosa di estraneo al fatto musicale, è ovvio che viene svilito come elemento del rumore di fondo.
Quello che voglio dire è che per loro è un’esperienza del tutto nuova l’idea di stare fermi e seduti per tre minuti a sentire un pezzo di musica e a cercare di concentrarsi solo su quello. E infatti molti non ci riescono o fanno davvero molta fatica. E allora io cerco di stuzzicarli e punzecchiarli, magari costringendoli ad ascoltare dei brani piuttosto lunghi, in cui non succede un granché o non ci sono elementi che attirano particolarmente l’attenzione. Capisci, è un’esperienza imprescindibile che devono fare, è una sorta di meditazione, in un certo senso un passaggio obbligato.
AAJ: Questo interagire “malizioso” con i tuoi alunni mi suscita un’ulteriore riflessione, ossia quanto palesemente tu sia soddisfatto e divertito dall’osservare l’effetto dirompente dei tuoi insegnamenti. Basta sbirciare il tuo sorriso compiaciuto mentre per la milionesima volta ascolti il bruciante solo di Armstrong in “West End Blues”, per capire come, attraverso le loro orecchie “vergini” e le reazioni di stupore dipinte sui volti, tu riesca ad ascoltare questa musica come se fosse la prima volta.
F.M.: E' verissimo. Io mi diverto molto perché loro non se l’aspettano, in un certo qual senso riesco spesso a coglierli di sorpresa e spiazzarli. Loro pensano che Armstrong sia un simpatico “cantantone” che ride, non ne capiscono l’importanza musicale fino a quando non ci sbattono il naso. Il problema è riuscire appunto a portarli ad ascoltare questi pezzi con orecchie aperte e curiose.
AAJ: Venendo a temi più strettamente di metodo, mi ha profondamente impressionato il tuo rigore nell’affrontare la storia del jazz, il tuo continuo riferimento al problema delle fonti e delle possibilità di documentazione (soprattutto per il jazz delle origini e il blues), la tua insistenza nel tratteggiare un preciso contesto in cui collocare la musica, la predisposizione a tracciare affinità e divergenze con aspetti non musicali della cultura afroamericana, l’attenzione costante e consapevole all’aspetto commerciale. Sai, la storiografia musicale soffre spesso di una metodologia deteriore e, altrettanto di frequente, è tutta un fiorire di aneddotica sfiziosa, elzeviri colorati, esotismi e dettagli gustosi. D’altro canto, capita molte volte che i cronisti si perdano negli aspetti strettamente musicali o sterilmente “filosofici”, trascurando l’imprescindibile componente storico-sociologica di questa musica. Quanto ci tieni ad insegnare questa materia con occhio critico e con approccio storiograficamente impeccabile?
F.M.: Per me è fondamentale. Chi segue le mie lezioni deve capire che non può pensare di cogliere il significato e lo spessore di queste musiche senza situarle nel loro tempo. Il jazz vive solo ed esclusivamente a contatto col proprio tempo. Per farti un esempio significante: se dico a un ragazzo siciliano di vent’anni che suona come un nero di trentacinque nato a Kansas City negli anni venti, io non lo considero un complimento, lo considero un insulto. Se avessero proposto a Charlie Parker un paragone del genere, lui si sarebbe arrabbiato, e non poco. Perchè il jazz era questo, era una musica basata fortemente sull’individuo e sul suo tempo, una musica in cui ad un certo punto diventavi te stesso. Invece oggi il jazz mi sembra diventato per alcuni il jazz tra virgolette, sembra diventato un terreno di ripetizioni.
AAJ: Appunto, visto che sei entrato in argomento: da profondo conoscitore della storia, come giudichi l’attuale momento dell’improvvisazione, o meglio, di quella cosa che ci ostiniamo a chiamare jazz? Dove siamo arrivati e dove stiamo andando?
F.M.: Noi continuiamo a usare questa parola “Jazz”, però diventa sempre più difficile darne una definizione. In fondo il jazz è sempre stata una musica che non aveva un’esatta definizione musicologica, una musica bastarda. Se tu definisci un tango o un’opera lirica puoi sempre arrivare a degli elementi oggettivi al di fuori dei quali non esiste più quella determinata forma musicale. Nel jazz questo è impensabile; i limiti che sono stati posti nel corso della storia, successivamente, sono stati messi in discussione e superati. Nessuno escluso, dal tempo all’armonia. Quindi capisci che ci si muove su un terreno veramente insidioso e difficile.
Oggi ci sono delle musiche che forse dovrebbero essere chiamate più correttamente “musiche di derivazione jazzistica” oppure “musiche che non sarebbero esistite senza il jazz”. Ad esempio, Zorn non sarebbe mai esistito senza il jazz, ma certamente il jazz non è l’unica sua fonte di ispirazione. Quanti altri musicisti che non operano direttamente in campo jazzistico dimostrano di essere ispirati ad una concezione della libertà, dell’improvvisazione, della ricerca, tipica del jazz. Carlo Rizzo puoi definirlo un jazzista? No. Ma d’altra parte i musicisti con cui suona più facilmente e più produttivamente sono quelli cresciuti nel jazz.
Forse il jazz, più che un genere musicale, è diventato una specie di punto d’incontro, una casa comune, una sorta di forum mondiale in cui si ritrovano tutti e ciascuno riesce a sentirsi a proprio agio. Se suonano insieme un musicista giapponese di koto e un percussionista brasiliano che cosa fanno? Un concerto di Jazz. Questo è il destino del jazz e probabilmente questo è anche segno di quante cose abbia detto, di quali preziose indicazioni abbia trasmesso a generi musicali più o meno affini e quanto abbia ancora da dire e insegnare questa musica.
Il problema poi è che molte persone sono convinte che il jazz, dopo un’intensa fase di sviluppo e trasformazione, sia arrivato alla piena maturità; e quella maturità per loro deve essere, diciamo, permanente e immutabile. Naturalmente le persone, a seconda di quando sono nate e della musica che hanno ascoltato, fissano questo apogeo di raggiunta maturità in un momento storico diverso. Secondo Panassié, ad esempio, tutto ciò che era venuto dopo il 1929 non era più jazz. Lo sosteneva con piena convinzione e, paradossalmente, dal suo punto di vista aveva ragione. Come avevano ragione i critici convinti che Charlie Parker non fosse jazz.
Per la mia generazione, invece, tutta la storia del jazz si realizza e si capisce attraverso il free-jazz. È il free che da senso a tutto il resto. Senza il free non si sarebbe capito il significato della musica e la portata storica di Ellington e Armstrong. Il free ha portato a compimento la crescita del jazz e ha rivelato che tutte gli stili, le correnti e le definizioni sono state soltanto il frutto di un determinato periodo storico e della commercializzazione, ma che la natura profonda della musica non è mai cambiata. In realtà la concezione musicale di Bechet, quella di Coltrane e probabilmente anche quella di Evan Parker, sono sostanzialmente molto simili, anche se, ovviamente, si esprimono in maniera diversa a seconda del tempo diverso in cui si sono manifestate.
AAJ: E dopo il free? Come sai oggi esiste un acceso dibattito riguardante la presunta stagnazione e cristallizzazione del linguaggio free, soprattutto, ma non solo, quello americano. Musicisti come William Parker, Daniel Carter, David S. Ware, Matthew Shipp, Roy Campbell, vengono spesso liquidati come sterili emulatori di modelli espressivi strettamente legati ad un certo periodo storico. C’è addirittura chi parla di “classicismo” del free-jazz. Qual’è la tua opinione al riguardo?
F.M.: Guarda, più conosco e più ascolto questa musica e più si rafforza la certezza che il jazz sia, innanzitutto, una musica di persone. Prendi i boppers, singolarmente non può non colpirti quanto distanti fossero le loro concezioni musicali, anche se poi si sono trovati insieme per motivi sociali, storici e per alcuni interessi comuni.
Ora, ritornando alla tua domanda, alcune delle cose che suonano i musicisti che hai citato sono una forma di “energy music”, musica d’impatto, che può essere in qualche modo considerata uno stile, una forma. Però ce ne sono altri che fanno cose molto diverse e difficilmente classificabili. Per esempio, penso a una personalità come Cooper-Moore, che è un collaboratore abituale di questi personaggi, ma in realtà rappresenta un mondo espressivo a parte. Voglio dire, se li prendi uno ad uno, sono completamente diversi e spesso veramente distanti tra di loro.
Detto questo, per il mio gusto e la mia formazione, trovo che le cose più interessanti questi musicisti le fanno quando sono stimolati a interagire con un ambiente che li sfida, li spinge oltre, li costringe a muoversi lungo i confini estremi del proprio linguaggio. Per esempio, Shipp con Spring Heel Jack. Ma vado molto volentieri anche a sentire il quartetto di William Parker o Roy Campbell, anche se dal punto di vista strettamente musicale può darsi che non mi dia qualcosa in più rispetto a una cosa che potevo sentire vent’anni fa. Però, sentirlo dal vivo, con quell’impatto, con quell’energia, con quell’inventiva è sempre un’esperienza che arricchisce.
Al di là del caso specifico, fa parte dell’ordine naturale che ogni musica diventi maniera o si trasformi in un fatto sociale. Ma anche la musica “di repertorio” ha un suo significato. Se inteso nel senso giusto, nel senso flessibile, il repertorio può essere un fatto positivo, un fatto formativo. Al contrario, quando il repertorio diventa un fatto esclusivo, allora assomiglia più a una forma di tifo calcistico che a una passione musicale.
AAJ: Ritornando all’insegnamento, fino ad ora abbiamo tirato in ballo Armstrong e Bechet, Ellington e Jelly Roll Morton, Davis e Coltrane, ma che parte occupa il free nel tuo corso di storia del jazz? Fino a dove hai intenzione di spingerti con le tue lezioni?
F.M.: Quando ci riesco, faccio un’ultima lezione dedicata al jazz in Europa. Di solito faccio ascoltare ai ragazzi qualche pezzo dal vivo che riescano a digerire tutto sommato facilmente. Non so, una marcia interpretata dalla Globe Unity, oppure un brano di Breuker in cui ci sono vari elementi extrajazzistici, o ancora qualcosa della Brotherhood of Breath, che mi permette di fargli sentire come gli improvvisatori africani si sono curiosamente integrati meglio con musicisti free europei che con jazzisti mainstream. Purtroppo, con queste ore di cinquanta minuti mi riesce difficile usare i video, che invece sarebbero utili e importanti per questo tipo di musica. Pensa all’ICP, che comunque di solito inserisco sempre nel programma.
Per quanto riguarda gli americani, invece, molti degli studenti conoscono musicisti recenti, ad esempio Steve Coleman, ma nessuno conosce un personaggio come Henry Threadgill, che invece io considero fondamentale, l’ultimo anello di una catena che parte da Morton, passando per Ellington e Mingus. Oppure Lester Bowie, di cui spesso propongo un pezzo della Brass Fantasy o una cosa dell’Art Ensemble in cui si possono sentire vari moduli della musica nera. La cosa bella è che molti di loro reagiscono in maniera inaspettatamente positiva, direi addirittura entusiasta.
Ovviamente non posso fargli sentire tutto. Considera che le ore a mia disposizione per le lezioni non sono molte e spesso mi tocca fare esclusioni dolorose. Bix Beiderbecke e Frankie Trumbauer, per esempio, sono fondamentali nella storia del jazz, ma sarò costretto a saltarli; magari per questioni di tempo non citerò nemmeno Bill Evans, mentre non mancherò certamente di far ascoltare Herbie Nichols e Paul Bley, anche perchè sono sicuro che molti degli studenti non li conoscono.
E poi il mio obbiettivo non è quello di fornire a questi ragazzi una conoscenza enciclopedica della storia del jazz, ma stimolarne la curiosità, costringerli a porsi delle domande, spingerli a cercare ascolti e letture. Sai, la soddisfazione più grande è quando, dopo qualche anno, ne incontri qualcuno e magari ti confessa che una tua lezione su Threadgill o sull’Art Ensemble gli ha spalancato nuovi mondi.
AAJ: E dal punto di vista della formazione musicale, che posto occupa l’insegnamento dell’avanguardia e del free nelle lezioni tenute dai musicisti italiani a Siena Jazz?
F.M.: Non esiste uno schema fisso, dipende dalle lezioni e dagli insegnanti. Il bello di Siena Jazz è questo, che gli studenti vengono messi in contatto con tantissime declinazioni e interpretazioni diverse di questa musica, a volte addirittura all’interno della stessa lezione. Ad esempio, ci sono musicisti dal suono elegantissimo come Pietro Tonolo, che se vede uno fissato con gli standard gli chiede di suonare come Brotzmann, oppure lo fa improvvisare ferocemente per venti minuti fino a che non lo ha scioccato. D’altro canto, musicisti come Schiaffini, Battaglia, Tonolo e Raja, possiedono una visione molto ampia ed un’ottima conoscenza della storia del jazz.
E poi, ovviamente, dipende un po’ anche dai loro interessi. Quello che possiamo fare noi come scuola, e in questo Caroni è sempre stato chiarissimo, è presentargli varie interpretazioni, evitando le chiusure stilistiche, in modo che poi loro possano scegliere ciò che ritengono più appropriato.
AAJ: Questa coraggiosa apertura ai generi si riflette anche nei vari concerti che proponete in parallelo all’attività didattica. Si passa dal filologico omaggio a Ellington di Casati, alle delicate atmosfere folk del duo Ferra-Dalla Porta; dal free umorale di Succi, al mainstream elegante di Raja. Il tutto sempre concedendo la massima libertà espressiva alle varie formazioni guidate dai docenti.
F.M.: Sai, conta anche l’atmosfera particolare che c’è a Siena Jazz. Voglio dire, nella professione del jazzista, come in tutte le altre professioni, a volte bisogna scendere a compromessi, cercare di “mettere insieme il pranzo con la cena”. Magari certi musicisti quando si esibiscono alcune scelte radicali le tengono un po’ sullo sfondo, perchè non vogliono essere etichettati in un certo modo. Questo è comprensibile, è anche giusto se vuoi. Però a Siena, di fronte a 200 studenti dei seminari, possono anche permettersi di lasciarsi andare, perchè sanno che una platea così ricettiva e bendisposta difficilmente la ritroveranno in un club.
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.