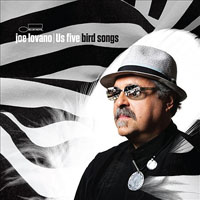Home » Articoli » Lyrics » Il filosofo e la rivoluzione del jazz
Il filosofo e la rivoluzione del jazz
La filosofia s'è occupata di musica fin dai suoi esordi - quelli della filosofia, dato che l'origine della musica si perde nella notte dei tempi. Infatti, già i Pitagorici vedevano nell'armonia musicale il modello dell'ordine divino del cosmo e, subito dopo, Platone e Aristotele impostavano le due principali letture del fenomeno musicale che, nei successivi due millenni e mezzo, saranno più volte riprese e rielaborate dai filosofi: rispettivamente, quella secondo la quale la musica è la porta d'ingresso a una realtà alla quale altrimenti l'uomo non avrebbe accesso (sia essa qualcosa di trascendente, sia essa immanente in ciascuno di noi) e quella che invece la considera una forma espressiva, con le proprie tecniche e regole.
Tuttavia, si può sostenere che proprio il predominio che, nelle loro molte varianti, queste letture hanno avuto nella storia del pensiero, abbia condotto la filosofia a semplificare troppo il fenomeno musicale, facendole perdere la possibilità di comprendere in modo più completo l'importanza che esso ha per l'uomo. In queste pagine cercherò di sostanziare tale affermazione, offrendo alcuni spunti per una possibile diversa riflessione filosofica sulla musica.
Tensione alla trascendenza ed eccesso di astrazione
La filosofia, come è noto, è l'esercizio sistematico del pensiero razionale, il quale - seguendo metodologie di volta in volta diverse - opera ripetute distinzioni logico-linguistiche per analizzare e comprendere fenomeni complessi, astraendo dalla loro concretezza gli elementi universali che li compongono concettualmente. Essendo però nata come tentativo di dare risposte nuove, autonome, scientifiche (episteme in greco significa "stare in piedi da sé") a domande aperte che fino ad allora ricevevano risposte di tipo mitico o religioso, la filosofia ha a lungo (e forse in parte ha tuttora) conservato un'aspirazione alla trascendenza che talvolta è stata di ostacolo alla fecondità del suo procedere. È il caso della riflessione filosofica sulla musica, che fin dai Pitagorici ha unito un eccesso di astrazione (sono i primi a considerare "essenza" della musica il suo contenuto "matematico," ovvero i rapporti tra l'altezza e la durata dei suoni) al suo avvicinamento a qualcosa di divino (l'armonia del cosmo). Questo tipo di lettura è poi tornato a più riprese nella storia del pensiero, sia nella sua variante mistico-religiosa, sia in quella "tecnica". E ancora pochi anni fa il Maestro Riccardo Muti, in una conversazione con il filosofo Umberto Galimberti, affermava di aver fatto affiggere nel suo studio alla Scala di Milano due terzine di Dante, dal canto XIV del Paradiso:
E come giga e arpa, in tempra tesa
Di molte corde, fa dolce tintinnio
A tal da cui la nota non è intesa
Così da' lumi che lì m'apparinno
S'accogliea per la croce una melode
Che mi rapiva, senza intender l'inno.
«Come vede», diceva Muti a Galimberti, «la "melode" rapisce al di là della comprensione dell'inno e delle parole che lo compongono. Perché la musica ha quella potenza rispetto alla parola che ci rapisce per dei sensi che stanno al di là di tutti i significati codificati dalle parole. In questo senso la musica ha un legame essenziale con la trascendenza in cui ci immette, senza tuttavia darci il testo linguistico, e quindi lasciandola nella sua inesplicabilità» [Nota 1].
È importante osservare come la riflessione dei filosofi sia stata perlopiù condotta sulla musica cosiddetta "colta" (più o meno coincidente con quella "classica"), perfino da prima del suo definirsi come tale. Ciò è in piena coerenza tanto con l'ispirazione pitagorico-platonica, quanto con quella aristotelica, perché in entrambe le letture - sebbene per ragioni diverse - era necessario astrarre dagli aspetti sociali, sensibili, emotivi e corporei della musica, per coglierne (definendoli essenziali) gli aspetti formali: le leggi matematiche, le tecniche esecutive, la scrittura. Su questi la filosofia ha lavorato per comprendere il senso della musica. E anche quando (ad esempio nell'anticipazione dell'estetica romantica in Hegel o nelle riflessioni di Nietzsche) il contenuto emozionale o il significato sociale siano stati presi in considerazione, con un certo pregiudizio intellettualistico sono sempre rimasti limitati alla musica "colta," mentre gli altri generi - cioè la quasi totalità della musica stessa - sono rimasti fuori dalla scena.
In questo modo, però, la filosofia si è pregiudicata la possibilità di comprendere il significato concreto della musica. Perché è sì vero che la musica ci comunica qualcosa che trascende il logos ed è perciò (almeno in prima approssimazione) "inesplicabile," così che - come ne concludeva Galimberti nella citata conversazione con Muti, trovando l'assenso del Maestro - può essere considerata «l'interrogazione dell'anima e del mondo» [Nota 2]; ma è altrettanto vero che è assai difficile definire in modo univoco cosa siano quella "trascendenza" e quell'"anima" che la musica interroga. Anche in considerazione dell'indiscutibile fatto che la musica non comunica nello stesso modo a tutti indistintamente: l'Inno alla gioia della Nona di Beethoven, Hey Joe di Jimi Hendrix, le pluralità di armonici di un canto tradizionale siberiano, un valzer suonato all'organetto o un'improvvisazione totale di free jazz hanno ciascuno i loro estimatori, che di solito faticano ad apprezzare gli altri brani. Quali di essi esprime la "vera" trascendenza? O, forse, ciascuno ci comunica qualcosa che - per quanto trascenda la nostra comprensione immediata - non ci trascende affatto, ma è invece immanente nella nostra identità, nella nostra storia personale, e proprio per questo mobilita i nostri sensi e i nostri affetti?
Ma se quest'ultima tesi avesse senso, una comprensione filosofica della musica non potrebbe limitarsi ad osservare i suoi caratteri formali astratti, ma dovrebbe porre in luce le sue molteplici specificità concrete, le quali, ben più che nella musica "colta," si manifestano in quella "extracolta" - quella cioè che include la musica tradizionale folklorica, quella popolare "leggera" (melodica, "pop" e rock), quella "commerciale," il blues, il jazz.
Musiche e gioco
Per cercare di sostanziare tale tesi, sarà opportuno osservare che la musica ha fondamentali caratteri in comune con il gioco, al quale in alcune lingue è significativamente avvicinata anche nell'uso verbale: l'inglese to play e il tedesco spielen indicano infatti tanto "giocare," quanto "suonare". Come il gioco (e, peraltro, come la filosofia) la musica è difficilmente riducibile alla razionalità economica, avendo in sé un carattere di "gratuità"; inoltre, essa attiva la sfera emotiva (e per questo "diverte"); infine, presuppone un'interazione intersoggettiva che ha un forte potere di "legame" tra le persone (sia tra chi la suona assieme, sia tra chi suona e chi ascolta) [Nota 3].
Il gioco è fenomeno troppo complesso perché sia possibile analizzarne più a fondo le sue analogie con la musica e i molteplici significati che ad essa trasmette [Nota 4]. Basti dire qui che i giochi hanno una loro logica, perlopiù non lineare (fatta cioè di regole flessibili, con forti connotazioni simboliche, per seguire le quali si assumono ruoli e, al tempo stesso, non li si assumono) [Nota 5], con il duplice scopo di donare il piacere di "evadere" dalla realtà ordinaria attraverso la messa in scena di una "finzione," "fingendo" però anche che sia vera, e di farci interagire "complicemente" con gli altri giocatori. Ovvero, come spiegano bene le riflessioni sui giochi sociali legati al fenomeno del "dono" [Nota 6], uno dei caratteri fondamentali del gioco è quello di contribuire alla creazione di legami sociali.
Tuttavia, il gioco - proprio perché ha delle regole che, in quanto non lineari, non sono strettamente istituzionalizzate - richiede per essere giocato un territorio culturale comune. In altre parole, per giocare non basta conoscere le regole, perché un'applicazione pedissequa non avvince e rende il gioco "falso" (paradossalmente perché preso troppo sul serio); per giocare è necessario condividere lo spirito del gioco stesso. E affinché ciò sia possibile è necessario appartenere a una tradizione culturale, fatta non solo di "regole del gioco," ma includente anche le mille sfaccettature che fanno parte della tradizione di un popolo, partecipando alla quale è possibile maturare quel "comune sentire" che permette di "stare al gioco".
Dall'astratto al concreto: la musica è una pratica
Ora, se andiamo a guardare come si tramanda la musica, possiamo osservare (semplificando un po') che le sue forme di trasmissione sono molteplici - mnemonica, per appunti, per scrittura, mista - ma che, accanto ad esse, rimane sempre presente, come sfondo ineludibile, una pratica sociale: il musicista si forma accanto ad altri musicisti [Nota 7]. Non solo: in questa formazione sociale egli non apprende solo cognizioni e competenze, ma anche complesse modalità di "saper fare" che includono capacità di interazione - con altri musicisti (come sa chi abbia intrapreso una formazione alla pratica di uno strumento) e con gli ascoltatori (come sa chi si sia trovato ad esibirsi di fronte a un pubblico) - ovvero capacità di agire sociale. Tali modalità sociali di "saper fare" sono diverse in ogni genere musicale e in ogni tradizione culturale, ma rimangono essenziali sia per la "creazione" di opere musicali, sia per la loro "esecuzione" - sempre ammesso che tra questi due aspetti del "fare musica" esista una rigida discontinuità, cosa che un'analisi delle forme di musica improvvisata tende a negare [Nota 8]. E ciò non a caso, ma proprio perché la pratica sociale è un elemento ineludibile del fenomeno musicale stesso.
Tutto questo è rimasto perlopiù celato nelle riflessioni astratte della filosofia e dell'estetica musicale, che ha relegato gli aspetti sociali tra i caratteri "impuri," psicologici e sentimentali della musica [Nota 9]. Solo in tempi recenti, con l'affermarsi di discipline di studio della musica "extracolta," come l'etnomusicologia, la sociologia e l'antropologia della musica [Nota 10], gli aspetti emozionali, sociali e culturali della musica sono finalmente entrati a far parte delle riflessioni dei filosofi.
L'esempio del jazz
In particolare, ha svolto un ruolo importante la riflessione sul jazz, un genere musicale che ha la specificità di essere nato come musica popolare, ma di essere poi cresciuto fino a lambire i territori della musica "colta," pur conservando elementi importanti della sua iniziale identità. Grazie a ciò, il jazz ha permesso di cogliere il radicamento storico-culturale, ma anche emozionale e identitario, di una musica che ha uno statuto teorico e tecnico più complesso e astratto. Esemplare in questo senso è il lavoro recentemente svolto dal filosofo italiano Davide Sparti, appassionato cultore del jazz, il quale ha cercato di scriverne fuoriuscendo dalle consolidate modalità proprie della critica musicale e dell'estetica, approdando ad alcune interessanti tesi.
Nel suo Suoni inauditi [Nota 11], Sparti tra le altre cose studia uno dei tratti caratterizzanti (sebbene non in modo esclusivo) il jazz - l'improvvisazione - definendone in modo originale le specificità, mettendone in risalto il carattere sociale dell'apprendimento [Nota 12], mostrando come essa sia «una pratica organizzata nel contesto di specifiche comunità, delle loro tradizioni e delle loro norme» [Nota 13] e come, tuttavia, richieda la trasformazione di quanto viene prodotto dalla pratica, perché proprio «la trasformazione di un corpo di testi sonori (...), ossia la loro riconnotazione o significazione o ricontestualizzazione» è il suo tratto caratteristico [Nota 14]. Ed infine osservando la sua prossimità con altre forme di pratica - in particolare, con quella del dialogo nella conversazione linguistica. Ho altrove sviluppato le tesi di Sparti, cercando di mostrare come l'improvvisazione possa essere presa a modello persino per le modalità metodologiche proprie del filosofare, inteso come forma di elaborazione concettuale critica e dialogico-collaborativa [Nota 15].
Nel suo libro Musica in nero [Nota 16], Sparti ha presentato altre tesi a partire dalla storia del jazz, evidenziando stavolta come l'improvvisazione possa essere diventata un suo tratto caratteristico non per caso, ma in virtù della biografia dei suoi protagonisti - gli afroamericani - e della tradizione culturale e sociale di cui facevano parte. Senza ripercorrere qui le vicende drammatiche delle popolazioni nere in America, basti citare alcuni brani di Sparti:
A proposito di fattori di persistenza nella cultura afro-americana, e in quella musicale e jazzistica in particolare, a me sembra che un fattore decisivo possa essere rinvenuto nell'intreccio fra deportazione, marginalità, improvvisazione e rischio. Si tratta forse di una tesi poco dimostrabile, ma certamente rivendicata dagli afroamericani. (...) La dislocazione, in fondo, corrisponde a una delle operazioni chiave di chi improvvisa: la capacità di coabitare - assimilandoli - con universi simbolici in tensione con il proprio. Lo stato di transitorietà e la negazione di un futuro su cui contare (...), la necessità di tollerare viaggi rischiosi - la cui destinazione è difficile da immaginare - e di convivere con il rischio di imprevedibilità che l'essere in una situazione mobile comporta, generano negli afro-americani il senso del "provvisorio duraturo," che verrà sublimato musicalmente nell'improvvisazione. Come spiega Ralph Ellison in uno dei saggi raccolti nel volume intitolato Going to the Territory, «gli schiavi avevano imparato [...] che per ottenere la libertà occorreva spostarsi geograficamente, e rischiare la propria vita rischiando l'ignoto» [Nota 17]. (...) Il viaggio - l'esercizio della libertà di spostamento - annuncia e conferma la fine della schiavitù. In cerca di lavoro (ma anche di sicurezza e di felicità), gli uomini iniziano a girovagare di regione in regione, non essendo vincolati, come le donne, dall'accudimento dei figli e da aspettative sociali difficili da violare [Nota 18].
Queste tesi possono essere integrate da due brevi osservazioni personali.
La prima è che, a una considerazione generale, la musica popolare sembra essere tanto più caratterizzata dall'improvvisazione e dalla commistione di generi diversi che la ibridino e l'arricchiscano creativamente, quanto più sia libera da forme di istituzionalizzazione che ne irrigidiscano lo sviluppo e le proteggano eccessivamente dall'intrusione produttiva del "diverso" [Nota 19].
La seconda, in parte connessa all'altra, è il fatto che, nell'attuale panorama jazzistico italiano, le proposte più interessanti e innovative sembrano provenire perlopiù da zone geografiche marginali, di frontiera e nelle quali sono più ridotte le possibilità di affermazione professionale e commerciale (ad esempio, il Friuli, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna), ovvero da quei luoghi e da quelle culture che, fatte le debite proporzioni, condividono maggiormente la tradizione, il destino e le difficoltà sociali, economiche - e perciò anche esistenziali - dei neri d'America [Nota 20].
Musica e filosofia, pratiche gemelle
Da tutto questo è possibile trarre alcune conclusioni, le quali - pur non potendo pretendere di avere un valore dimostrativo, vista la brevità dell'argomentazione qui proposta - sembrano avere una certa cogenza:
1. La musica, oltre ai suoi tratti "formali," tecnici e matematici da sempre evidenziati dalla filosofia, presenta essenzialmente anche un altro importante carattere: è una pratica.
2. In quanto tale, essa è intersoggettiva - è cioè una multiforme pratica sociale che contribuisce alla tessitura di legami interpersonali all'interno della realtà sociale nella quale essa, in tutte le sue manifestazioni, "accade".
3. L'intersoggettività che la caratterizza in quanto pratica viene progressivamente soffocata quanto più essa si istituzionalizza e diviene "colta," "rito" o "merce".
4. Per le stesse ragioni, la libertà che la caratterizza in quanto appartenente alla più ampia categoria del "gioco" e che ne favorisce lo sviluppo creativo viene inibita dalla sua essenzializzazione formale, che prelude alla sua istituzionalizzazione [Nota 21].
5. L'intersoggettività dialogica, che le è propria in tutte le sue forme e che la qualifica in quelle più libere e meno istituzionalizzate, si esprime al meglio nell'improvvisazione, che la musica condivide con il dialogo conversazionale e con l'agire filosofico.
6. L'attivazione emozionale, del "sentimento," che essa produce è sì legata alle "forme" della sua struttura, ma lo è ancor più ai complessi nessi intersoggettivi che costituiscono la musica in quanto pratica sociale.
7. Così, la "trascendenza" cui la musica sembra alludere nella sua apparente "insondabilità" e alla quale ci dà accesso è in realtà un'"immanenza": quella dei molteplici nessi intersoggettivi cui siamo soggetti culturalmente e che la musica, in quanto pratica socioculturale, manifesta con le sue specifiche modalità.
8. Intesa perciò (per riprendere le precedenti parole di Galimberti) come «interrogazione dell'anima e del mondo», la musica ci comunica qualcosa che fa parte di noi, che abbiamo appreso inconsapevolmente, incorporandola senza rendercene pienamente conto, che riscopriamo, con sorpresa, ascoltando e reagendo ad essa.
9. Infine - ultima, più generale e suggestiva conclusione - pur rappresentandola nelle sue forme specifiche, sonore e non concettuali, la musica costituisce una parte della nostra visione del mondo: creandola mettiamo "in forma" parte dei nostri valori e dei significati che assegniamo alla realtà, così come ascoltandola con attenzione possiamo scoprire i valori e i significati che possediamo e conserviamo dentro di noi.
Quest'ultima considerazione, che può forse suonare sorprendente, emerge in modo chiaro allorquando, come mi è più volte capitato di fare, si sottopongano contemporaneamente all'ascolto di più persone di età, biografia e cultura diverse, brani musicali altrettanto diversi tra loro, per poi dialogare assieme alla ricerca delle ragioni dei loro discordanti giudizi. Qui, l'interrogazione che la musica ci pone viene condivisa all'interno di una collegiale e concettuale ricerca filosofica [Nota 22], che ci permetta di capire cosa ci piace o ci urta e perché ciò avvenga. E, sempre qui, la musica, pur rimanendo un diletto (perché essa è e rimane un gioco), grazie all'esplicita e consapevole riattivazione dell'intersoggettività di cui essa si nutre - grazie cioè all'intervento della filosofia - non solo ci svela molto di noi e del mondo, ma soprattutto ci rimette ludicamente in comunicazione e ci aiuta a tessere nuovi legami con gli altri, per quanto diversi essi siano da noi, anzi, in misura maggiore quanto più essi siano diversi. Un'opera preziosa che la musica, di solito in modo immediato e solo apparentemente "inesplicabile," svolge tra gli uomini fin dalla sua origine, persa nella notte dei tempi.
NOTE:
1) Umberto Galimberti, Orme del sacro, Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 154-155.
2) Op. cit., p. 155.
3) Questo carattere, evidente fin nella musica primitiva ove assume significato rituale, lo è mutatis mutandis nelle diverse culture musicali in forma di medium nelle occasioni di festa, di fenomeno sociale, culturale, e conomico, ecc.
4) Pietra miliare delle riflessioni sul gioco rimane il lavoro di Roger Caillois, I giochi e gli uomini, Milano, Bompiani, 1981 (ed. or. Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967).
5) Ad esempio, giocare a "guardie e ladri" significa assumere il ruolo della "guardia" o del "ladro," ma al tempo stesso non significa essere realmente "guardie" o "ladri" - il divertimento sta proprio nell'essere al tempo stesso "dentro" e "fuori" (su questi temi cfr. Alessandro Dal Lago e Pier Aldo Rovatti, Per gioco, Milano, Raffaello Cortina, 1993).
6) Cfr. tra gli altri Marcel Mauss, Saggio sul dono, Einaudi, Torino, 2002 (ed. or. Essai sur le don, Press Universitaires de France, Paris, 1950), Jacques Godbout, Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino, 1993 (ed. or. L'Esprit du don, La Decouverte, Paris, 1992).
7) Su questo aspetto rinvio a Donald Schön, Formare il professionista riflessivo, Milano, Franco Angeli, 2006 (ed. or. Educative the reflective practitioner, San Francisco, Jossey Bass, 1987), che mostra come la formazione dei musicisti si svolga all'interno di comunità di pratiche.
8) Si osservi che quando si parla di musica improvvisata non ci si riferisce ad un "genere," perché l'improvvisazione è presente in misura variabile in ogni tipo di musica e in particolare nella "madre di tutte le musiche," la musica popolare.
9) In proposito, meriterebbero un confronto le opposte, eppure alla fine per questo aspetto coincidenti posizioni espresse da Hegel (nelle Lezioni di estetica) e di Eduard Hanslick (in Il bello musicale, Milano, Martello, 1971, ed. or. Vom Musikalisch-Schönen, Leipzig, 1854).
10) Tra la sconfinata letteratura vale forse la pena di ricordare per suggestione e per l'importanza che hanno avuto per la comprensione della nostra cultura popolare (non solo musicale) i molti lavori di Ernesto de Martino sulla musica del sud Italia e quello del danese Andreas Fridolin Weis Bentzon, Launeddas, Cagliari, Iscandula, 2002 (ed. or. The Launeddas. A Sadinian folk-music instrument, Copenhagen, Akademisk Forlag, 1969) su quella della Sardegna.
11) Bologna, Il Mulino, 2005.
12) «Aspetti rilevanti del sapere di chi improvvisa possono essere appresi "senza insegnamento," ossia in contesti di interazioni, senza che ciò richieda un'esplicita trasmissione e traduzione linguistica» (op. cit., p. 129).
13) Op. cit., p. 130.
14) Op. cit., p. 132. Ma vedi anche p. 130: «Differenza tramite ripetizione - è questa appropriazione trasformatrice lo stigma del jazz».
15) Cfr. Neri Pollastri, Consulente filosofico cercasi, Milano, Apogeo, 2007, pp. 67-68, e Improvisation. A Method of Philosophical Consultation, in José Barrientos Rastrojo (ed.), Philosophical Practice. From theory to practice, Sevilla, 2006.
16) Bollati Boringhieri, Torino, 2007.
17) Op. cit., pp. 37-38.
18) Op. cit., p. 48.
19) Sarebbe interessante studiare tali forme di istizionalizzazione, che possono essere in prima approssimazione distinte tra: a) concrezioni culturali che le universalizzano e rendono "modelli" rigidi non più modificabili se non al costo di una "violazione" dei canoni del "bello" (secondo una modalità che segue l'intellettualismo delle due letture filosofiche classiche); b) irrigidimenti dovuti all'affermazione culturale di modelli consuetudinari (secondo la naturale tendenza "economica" umana ad apprezzare maggiormente il noto rispetto all'ignoto); c) pastoie imposte con modalità persuasive più o meno occulte (secondo il modello oggi in auge della promozione dei prodotti commerciali).
20) In un bel disco d'una quindicina d'anni orsono, Sudori, il trombettista pugliese Pino Minafra titolava scherzosamente un brano Au fond, je suis un africain du Nord.
21) Si pensi qui alle resistenze che critica e pubblico pongono ad ogni "innovatore" in qualsivoglia genere musicale, dalla classica al rock, e che di solito sono minori proprio nell'ambito della musica folk.
22) Si tratta di una delle forme di "pratica filosofica," attività di cui mi occupo da anni e per le quali rinvio al mio già citato Consulente filosofico cercasi e al precedente Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, Milano, Apogeo, 2004.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.