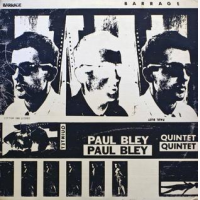Home » Articoli » Live Review » I concerti sacri di Duke Ellington a Parma
I concerti sacri di Duke Ellington a Parma
Il lavoro che Roberto Bonati svolge tutto l'anno al Conservatorio (e l'esperienza direzionale e compositiva accumulata con l'orchestra del festival Parma Jazz Frontiere) erano evidenti nella coesione e nella qualità della big band, tutta formata da alunni, docenti e diplomati del Conservatorio Boito, con una salutare iniezione di strumentisti e cantanti provenienti dalla sezione “classica” a dimostrazione che, sia pur lentamente, certe barriere stanno cadendo. Non si è infatti trattato di una calligrafica ripetizione delle magistrali pagine registrate dal Duca ma di una esecuzione vera e viva, piena di scelte personali sia del direttore che dei solisti chiamati a ricoprire i ruoli degli storici solisti ellingtoniani e capaci di farne rivivere la passione senza imitarne pedissequamente il linguaggio: Alberto Mandarini alla tromba solista con Giuseppe Virone prima tromba chiamato a ripercorrere gli impervi percorsi di Cat Anderson, Emiliano Vernizzi all'alto, Marco Ferri al clarinetto, Claudio Morenghi al tenore, Alessandro Creola al baritono e Giuseppe di Benedetto al trombone, per citare le posizioni chiave nella riproposizione del sound ellingtoniano (ci sarebbe voluto un terzo clarinetto a voler essere pignoli, ma è stata giustamente rispettata la scelta di basarsi su forze locali o comunque legate al Conservatorio).
Importante anche il ruolo della sezione ritmica, affidata a musicisti giovani ma di sicuro talento e impegnatissimi a dare il meglio nella complessa partitura: Alessandro Sgobbio al piano, Matteo Ravizza al basso e Gregorio Ferrarese alla batteria, in particolare evidenza nell'interpretazione della swingante Something 'Bout Believing con la sua atmosfera un po' decadente da sala da ballo, per accentuare la quale si sarebbe potuta usare anche una tastiera.
Aggiungiamo a questo il poderoso coro frutto dell'unione tra quello del conservatorio di Parma e quello dei Civici Corsi di Jazz di Milano, sotto la guida di Giorgio Ubaldi che non solo ha dato sostanza alla scrittura corale dell'originale armonizzandone le parti e ha poi ben integrato la sua direzione con con quella di Bonati, ma è riuscito a coinvolgere emotivamente i cantanti, molti dei quali giovanissimi, nel progetto, cosicchè anche quando non erano direttamente coinvolti nell'esecuzione la loro presenza sul palco dei coristi era vivace: seguivano sorridendo gli assoli, oscillando e muovendosi a tempo, applaudendo calorosamente i solisti, un coro groovy!
Ma il concerto si è soprattutto retto sulla capacità di Bonati di dare dal podio direttoriale quell'impulso in avanti alla musica della cui essenza il contrabbassista parmense è ben cosciente grazie alla sua grande esperienza. Senza perdersi nei dettagli ma curando in particolare, ben sostenuto dal tecnico del suono Corrado Cristina, la disposizione dei vari livelli sonori, Bonati ha evidenziato la struttura portante della musica con i giochi di “chiamata e risposta” tra le sezioni dell'orchestra e tra queste e il coro, lasciando spazio ai solisti e usando pienamente le dinamiche della complessa formazione.
Come sottolineava Maurizio Franco introducendo il concerto, si è trattato di una intelligente operazione di educazione musicale, nel senso più pieno di questa frase: per gli allievi del conservatorio e per i giovani solisti, chiamati a una prova impegnativa; per le voci e gli strumentisti di formazione classica, che hanno fatto una esperienza del tutto diversa rispetto a quelle cui sono abituati; e per il pubblico, che si è divertito assistendo a un concerto capace di essere spettacolare e coinvolgente senza rinunciare alla serietà e direi a un certo rigore.
Ed interessante anche la molteplicità “etnica” dei cori e dei solisti, accanto alla varietà dei look: rasta e code di cavallo, riccioli e teste pelate, mises eleganti e jeans coi buchi, inno visivo alla capacità di accoglienza della musica.
Particolarmente importante la restituzione della ironia tipicamente ellingtoniana dei testi, ad esempio nel parlato introduttivo, spiritosamente reso dal baritono Oscar Ferrara in veste recitante, in cui tra le caratteristiche dell'universo prima della Creazione si enumera “No questions, no answers / No music, no dancers”. E così il coro che scandiva i titoli dei libri della Bibbia protestante e delle Lettere di S. Paolo per arrivare al climax con i nomi degli Evangelisti, ha ben interpretato l'uso delle parole come pura e semplice magica evocazione, mentre il baritono coreano Eun Hyok Yun è stato adeguatamente profetico. (Con un po' più di tempo e probabilmente di fondi sarebbe stato ancora più efficace dare al pubblico ulteriore informazione, con la possibilità di seguire i testi dei brani e magari la bellissima introduzione scritta dallo stesso Ellington per il programma di sala della prima esecuzione del 1965; analogamente, It's Freedom, dal secondo Concerto, con la sua personalissima base teologica e dedicato a Billy Strayhorn, si apprezza ancora meglio leggendo “le quattro libertà” cui Billy aveva ispirato la sua vita: "libertà incondizionata dall'odio; libertà dall'autocommiserazione; libertà dalla paura di far qualcosa che potrebbe aiutare qualcun altro più di quanto aiuta me; e libertà dall'orgoglio che mi fa sentire migliore di mio fratello.").
E' stata poi la voce calda ed espressiva di Marta Colombo ad eseguire Come Sunday disegnandone la complessa melodia sugli statici, solenni accordi dell'accompagnamento. Uno degli aspetti più interessanti e tipicamente ellingtoniani di questi Concerti è la capacità di integrare nelle composizioni l'intera storia della musica e del teatro afroamericani, dal gospel fino al free, e bene ha fatto Bonati a integrare la partitura con episodi improvvisati in cui usava la tecnica della conduction elaborata da Butch Morris disegnando in diretta la musica, con grande sorpresa del pubblico; bello il contrasto con Almighty God, dai profumi di New Orleans, in cui l'uso strumentale della voce senza parole è stato ben interpretato dalla soprano Simona Severini la cui voce si librava suggestivamente sopra coro e orchestra.
Nella versione originale dei concerti la parte di Re David che danza con tutta la sua potenza di fronte a Nostro Signore è affidata, anche qui con grande humour, a un ballerino di tip-tap; analoga operazione è stata tentata a Parma ma purtroppo malgrado il lodevole sforzo del danzatore l'integrazione ritmica con l'orchestra non è stata adeguata, e le figure della danza lontane da quelle dei grandi ballerini afroamericani, né potrebbe essere diversamente, considerata la tecnica totalmente differente e la necessità di crescere in una specifica cultura della danza. Il pubblico ha tuttavia gradito e, come dice lo stesso Ellington, l'importante non è la tecnica, ma lo spirito con cui si offre la propria creatività.
Conclusione esplosiva e trascinante con Praise God And Dance dal secondo Concerto punteggiata ancora dagli assoli del brillante Mandarini insieme alla elegante voce di Hitomi Kuraoka, e applausi lunghissimi e meritati per tutti i protagonisti.
Foto di Francesco Martinelli.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.