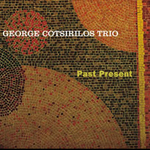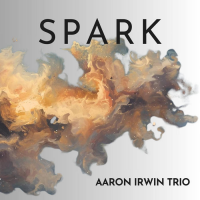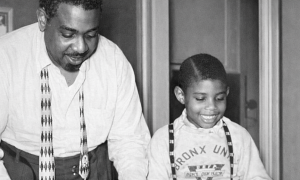Home » Articoli » Lyrics » Django Reinhardt: genio e sregolatezza
Django Reinhardt: genio e sregolatezza
Per decenni l'immagine di Django Reinhardt è stata forgiata sulla base del già citato (e molto conosciuto) libro di Charles Delaunay, suo grande amico e manager. Si tratta di un testo diventato un classico della letteratura jazzistica, che per diversi lustri ha rappresentato l'unica fonte di notizie di prima mano sul chitarrista manouche. Pur con alcune inesattezze, Delaunay tratteggia la vita dell'artista con dovizia di particolari, infarcendola di aneddoti dai quali tutti hanno attinto a piene mani per la compilazione di innumerevoli (e spesso sempre uguali) articoli.
Nel complesso, dalla lettura ci si forma l'immagine di un personaggio quantomeno stravagante, di un uomo dalle mani bucate, incallito giocatore d'azzardo, analfabeta e incapace di leggere anche una sola nota sul pentagramma. Sebbene l'autore non usi mai questo termine, è facile comprendere i motivi che hanno portato, per alcuni decenni, critici ed appassionati a considerare Django come un "genio spontaneo," un musicista puramente istintivo e, forse, inconsapevole della sua arte.
Se a questo quadro aggiungiamo lo stupefacente virtuosismo, ottenuto tra l'altro ad onta della grave menomazione fisica subita dalla sua mano sinistra (la quasi totale paralisi dell'anulare e del medio in seguito all'incendio sviluppatosi, la sera del 2 novembre 1928, nel suo carrozzone), è facile comprendere perché si è spesso parlato e scritto di lui come di un fenomeno musicale miracoloso. Visto da questa angolatura, Django Reinhardt è stato quindi troppo spesso inquadrato come un artista naif e primitivo, una specie di Henry Rousseau della chitarra.
Una tesi difficile da sostenere in quanto il concetto di naif è legato in maniera indissolubile all'ingenuità nel pensiero artistico e all'approssimativo controllo di una qualsivoglia tecnica, almeno in relazione alle regole accademiche o ai parametri in uso tra i professionisti. Tutti fattori inapplicabili all'arte di Django, che anche a un primo ascolto si rivela sofisticata sotto diversi aspetti. Nella visione distorta della sua figura di artista si sconta dunque il peso di una pubblicistica sul jazz che si è più volte distinta per l'ansia nella ricerca del genio inconsapevole, capace di incarnare l'immagine del "buon selvaggio" della musica, cioè di un artista esente dai condizionamenti dell'Accademia e insofferente a ogni regola.
Di un'analoga impostazione storiografica ha pure sofferto, per fare un solo esempio, Thelonious Monk, anch'egli frainteso per anni e addirittura scisso nella sua personalità musicale: da una parte considerato un grande compositore, dall'altra giudicato un pianista dalle modeste qualità strumentistiche, un autodidatta naif, per troppo tempo non ha visto riconosciuto il legame profondo che univa la sua arte di autore a quella di esecutore.
Nel caso di Django la tesi di una presunta naïveté è dunque insostenibile in quanto ci troviamo di fronte, in primo luogo, ad un virtuoso, e dei più entusiasmanti e sorprendenti, che ha saputo reinventare l'intera diteggiatura della mano sinistra sulla tastiera della chitarra, strumento a cui si dedicò dopo l'incidente in quanto più maneggevole, meno duro da suonare del banjo tenore, adeguando il suo approccio tecnico alle particolari esigenze della mano menomata. Tra l'altro, non si trattò di un adattamento rudimentale, bensì di uno scientifico ripensamento, causato dalla quasi totale impossibilità di utilizzare due dita fondamentali per la tecnica chitarristica, da cui sviluppò una profonda conoscenza dello strumento trovando il modo di utilizzare la tastiera in maniera funzionale alla sua concezione melodica e armonica. Proprio in virtù di questa consapevole ricerca di nuove modalità tecnico-strumentistiche, talvolta è più facile riprodurre i suoi assoli utilizzando soltanto l'indice e il medio della mano sinistra anziché tutte e quattro le dita.
È quindi tempo di mandare definitivamente in soffitta l'immagine pittoresca di Django, alimentata anche dalla fama dell'artista tutto genio e sregolatezza costruita guardando ai suoi comportamenti fuori dal palcoscenico e non certo, come dovrebbe essere, da quelli dell'artista in scena o in sala di registrazione.
Ad avallare questa tesi hanno contribuito non poco svariati aneddoti sulla sua inaffidabilità in fatto di rispetto per i contratti e per l'orario d'inizio dei concerti, tra i quali il più conosciuto è legato al clamoroso ritardo con cui giunse alla Carnegie Hall nel 1946 quando, ospite dell'orchestra di Duke Ellington, si presentò nel tempio della musica classica newyorchese tre ore dopo l'inizio del concerto perché attardatosi a chiacchierare con il pugile francese Marcel Cerdan, incontrato casualmente.
Un fatto che in realtà assume nuova luce se consideriamo che Django si trovava a proprio agio soltanto nel suo ambiente socio-culturale (rappresentato in quel momento da Cerdan) e non comprendeva, forse temendola, la società americana. Lo dimostrano tutti i racconti sulla sua tournée con Ellington (di cui New York fu la tappa più importante), che ci forniscono il ritratto di un uomo disorientato e per nulla incline a sviluppare nuovi rapporti sociali, e nemmeno a conoscere "dal vivo" quel mondo musicale jazzistico a cui apparteneva e che, in Europa, lo affascinava.
Non si può però travisare il suo comportamento in questa specifica circostanza, e nemmeno equivocare sulla professionalità di Django durante le performance: la sua presunta o reale inaffidabilità terminava infatti nel momento stesso in cui prendeva in mano lo strumento e si sedeva di fronte al pubblico. In quell'istante si trasformava in un professionista rigoroso, addirittura pignolo, attento ai minimi dettagli della musica e ben conscio di tutto quello che gli succedeva intorno. Per questo, nella sua produzione non si avvertono le cadute che hanno avuto come protagonisti altre personalità di primo piano della storia del jazz.
Il violinista Stéphane Grappelli, che fu il principale partner di Django nel Quintette Du Hot Club De France e la cui figura è legata a filo doppio a quella del chitarrista, ricorda che "cambiava sovente i musicisti; una nota sbagliata lo faceva infuriare. Una sera un contrabbassista ha dovuto andarsene per non aver suonato in maniera levigata. Queste difficoltà musicali, dovute al fatto che lui era molto esigente, lo portarono a preferire che suonassimo in duo piuttosto di lavorare con altri musicisti" (Nota 1).
Il cantante francese Jean Sablon, un classico esempio di chansonnier influenzato dalla canzone americana, che fu tra i primi a far lavorare e ad apprezzare sinceramente Django, delle sue collaborazioni con il chitarrista rammenta la precisione che lo contraddistingueva: "era un uomo che aveva in dono il senso della perfezione. In musica era molto meticoloso ed esigente con se stesso, ed era particolarmente attento al modo in cui suonava l'insieme" (Nota 2).
Esattamente il contrario di quanto avviene in un artista naif. Comunque il vero problema di Django non era il comportamento in scena, bensì il fatto "di arrivarci". Spesso occorreva andarlo a prendere in automobile per evitare che si scordasse degli impegni o, semplicemente, non avesse voglia di onorarli. Sablon, riguardo alle doti naturali di Django, ricorda che "suonava tutto ad orecchio. Gli bastava ascoltare una sola volta per appropriarsi subito di un tema e ricreare delle armonie ancora più belle delle originali. Era un fenomeno, e lo faceva con naturalezza. Non aveva alcuna istruzione musicale, ma la musica era la sua lingua" (Nota 3).
Un orecchio alla Mozart, e la rarissima fortuna di riuscire ad apprendere "sul campo," direttamente, le conoscenze musicali che gli servivano. Del resto la cultura orale propone un diverso modo di apprendere, attraverso il quale si possono raggiungere anche ambiziosi obiettivi, e non è certo un sinonimo di cultura popolare o rozza. La trasmissione analogica del sapere può portare a livelli di sofisticazione molto evoluti, come avviene per esempio nella cultura musicale africana tradizionale, mettendo però in campo materiali differenti da quelli utilizzabili in presenza di una cultura trasmessa per via analitica.
Django non era affatto un ingenuo, inconsapevole di quanto accadeva intorno a lui, come si ricava chiaramente dalle testimonianze di Grappelli e Sablon: conosceva benissimo il senso e il colore di ogni accordo ed era perfettamente conscio delle sue scelte armoniche e melodiche. In tal senso c'è un aneddoto sul quale occorre riflettere, tra l'altro citato in varie fonti. Verso la fine degli anni '40, nel periodo in cui, trascurando in parte la musica, Django si dedicò alla pittura, un giornalista gli chiese in quale tonalità amasse dipingere. La risposta, laconica ma arguta fu: "in fa diesis minore". Tutti pensarono ad una battuta ma, in realtà, quella frase affascinante è rivelatrice di una coscienza sul colore dei suoni che si riflette nella stessa varietà timbrica della sua musica.
Ancor più significativa, riguardo al rigore del Django musicista, è anche un'altra sua affermazione: "il jazz mi attira perché vi trovo la perfezione della forma e la precisione strumentale che ammiro nella musica classica e che manca nella musica popolare in genere". Questa attenzione per gli aspetti formali, esecutivi, tecnico-espressivi è di per sé una dimostrazione di consapevolezza della dimensione artigianale del fare musica che non è certo appannaggio del solo mondo eurocolto, ma anche di una comprensione profonda della natura del jazz raramente espressa da un musicista in maniera così lucida.
In effetti, la precisione di Django e la cura nell'esecuzione, tipiche del resto di tutto il grande jazz, non si discostavano da quelle dei grandi concertisti classici, a cominciare dall'accordatura dello strumento, come sottolinea tra gli altri anche Marc-Edouard Nabe: "uno dei grandi segreti tecnici di Django Reinhardt è che la sua chitarra è incredibilmente ben accordata. I suoi accompagnatori l'hanno sottolineato: quando si accordava, c'era già della grande musica" (Nota 4).
1) Sportis, Felix W.: "Stephane Grappelli," in Jazz Hot, aprile 1993. Si tratta di una interessante intervista con Grappelli in cui vengono toccate alcune tematiche relative alla tecnica di Django e alla nascita del Quintette Du Hot Club De France.
2) Sportis, Felix W.: "Jean Sablon," in Jazz Hot, aprile 1993. Intervista con il cantante francese che ricorda alcuni aspetti della personalità musicale del chitarrista.
3) Sportis, Felix W.: op. cit.
4) Nabe, Marc-Edouard: "Nuage," Le Dilettante, Parigi, 1993, pag. 31. Il libro, un vero e proprio tascabile, è una riflessione sull'arte di Django che ad osservazioni acute ne affianca altre molto discutibili; comunque un'opera controcorrente anche se non particolarmente approfondita.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.