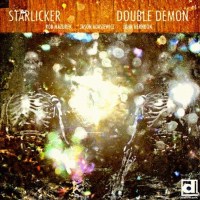Home » Articoli » Lyrics » Coleman Duemila: in alto il (contrab)basso
Coleman Duemila: in alto il (contrab)basso
Ornette Coleman torna a Milano dopo quattro anni, presentandosi con una formazione molto simile a quella con cui fece scalpore al Teatro Strehler nel giugno 2004 per la quinta Milanesiana: allora al fianco del grande sassofonista (e polistrumentista) e di suo figlio Denardo alla batteria c'erano i due contrabbassisti Tony Falanga e Greg Cohen (la formazione documentata da quello che è tuttora l'album più recente di Coleman, Sound Grammar del 2006); oggi insieme allo strumento acustico di Falanga si ascolta il basso elettrico di Al McDowell.
Sassofono contralto (o tromba, o violino), due bassi, batteria: l'organico non è dei più consueti e può sembrare un capriccio del vecchio rivoluzionario del jazz. Ma esplorando più da vicino la formula ci accorgeremo non solo che la sua idea corre trasversale lungo tutta la carriera di Coleman, ma soprattutto che racchiude alcuni fra i nodi principali del pensiero musicale di quello che è stato definito il "padre del free jazz".
Per cominciare, vale la pena di ripercorrere in sintesi le varie formazioni che Coleman ha potuto documentare su disco. Nel 1958 le prime incisioni già mostrano al suo fianco il trombettista Don Cherry. Fra 1959 e 1961 il sassofonista dà testimonianza di un quartetto con sassofono, tromba (sempre Cherry), contrabbasso e batteria, dunque senza pianoforte, formula ancora piuttosto insolita (benché già esplorata pionieristicamente da Gerry Mulligan con Chet Baker). Nel 1962 Coleman riduce a trio la formazione, con contrabbasso e batteria; dal 1965 in questo gruppo il leader suona anche la tromba e il violino. I due accompagnatori sono a lungo David Izenzon e Charles Moffett, ma più avanti la stessa formula è ripresa con Charlie Haden (che era stato il primo bassista del quartetto) e Denardo Coleman, ancora bambino. Nel 1968 nasce un quartetto con due sassofoni: affianca Ornette il sax tenore di Dewey Redman.
La seduta dell'album Science Fiction, del 1971, mostra Coleman aperto a nuove formule strumentali ma anche interessato alla ripresa di vecchi organici, in particolare il quartetto con Cherry. Dopo l'esperienza sinfonica di Skies of America (anch'essa rielaborata più volte negli anni successivi), intorno al 1976 prende corpo il gruppo "elettrico" del sassofonista, Prime Time, che nella sua struttura definitiva lo vede attorniato da due chitarre, due bassi elettrici (Jamaaladeen Tacuma, poi sostituito da altri, e Al McDowell) e due batterie; con questa formazione, nel 1978, nasce un nuovo e peculiare recupero del passato, perché il disco In All Languages propone l'esecuzione di vari temi in due diverse versioni, con il Prime Time appunto e di nuovo con il quartetto "originale" del 1959. In certo modo simmetrica è l'operazione del successivo gruppo colemaniano, il più convenzionale almeno sulla carta, essendo un quartetto con pianoforte contrabbasso e batteria: nel 1996 incide due album "gemelli" nei quali il repertorio è praticamente identico.
* * *
Abbiamo dunque incontrato l'uso di due bassi all'interno del gruppo elettrico tutto basato sulla specularità strumentale. L'idea del "doppio" era già stata utilizzata da Coleman nel 1960 in uno dei suoi dischi più famosi: Free Jazz, sottotitolato programmaticamente "a collective improvisation by the Ornette Coleman Double Quartet". In quel caso il sassofonista la applicava al proprio quartetto, usando due ance, due trombe, due contrabbassi e due batterie. Naturalmente, una volta accettata la logica del raddoppio, potrebbe sembrare inutile sottolineare la presenza dei due bassi (imbracciati da Charlie Haden e Scott LaFaro); ma non va trascurata un'acuta postilla di Martin Williams, estensore delle note di copertina, che dopo aver aperto il suo commento sottolineando l'eccezionalità dell'incisione ribadiva però, nel momento in cui giungeva a descrivere il lungo duetto fra Haden e LaFaro: "Sono sicuro che questa incisione sarebbe eccezionale anche solo per il magnifico lavoro dei due contrabbassisti".
Inoltre è il momento di dire che il percorso discografico sintetizzato poco sopra contiene una lacuna importante. Tra il 1967 e il 1968 il trio era divenuto proprio un quartetto con due contrabbassi: lo abbiamo volontariamente escluso perché si tratta del "gruppo perduto" di Coleman, con il quale non riuscì mai a entrare in studio d'incisione e di cui rimane traccia soprattutto grazie all'incisione (clandestina) di un paio di concerti italiani. I contrabbassisti erano Haden e Izenzon; con loro Coleman suonò anche ai funerali di John Coltrane.
Il gruppo con Falanga e Cohen, e in buona misura anche quello con Falanga e McDowell (nonostante le novità portate dal basso elettrico), riprendono le concezioni di allora: uno dei due bassi sostiene ritmicamente il gruppo, l'altro è impegnato, spesso con l'arco, a riempire lo spazio acustico. Entrambi hanno comunque una libertà molto pronunciata, tanto da sviluppare una sorta di duetto improvvisato, spontaneamente contrappuntistico; una scelta molto simile a quella che si ascolta in Free Jazz, e che non si riconosce invece all'interno del Prime Time, dove i due bassi sovrappongono forti linee ritmiche d'accompagnamento.
Nella riflessione musicale di Ornette Coleman il suono e il ruolo del (contrab)basso compiono dunque un lungo percorso, del quale abbiamo del resto rilevato solo alcune tappe. Aggiungiamone qualche altra, procedendo a ritroso. Buona parte dell'ultimo decennio vede dominare lo strumento. Nel giugno del 2003 un concerto del sassofonista alla Carnegie Hall è previsto in trio ma egli desta scalpore presentandosi con due contrabbassi, che già sono Falanga e Cohen (anche se in qualche annuncio si parlava di Charnett Moffett, il figlio del batterista). La formazione si fa ascoltare in tutto il mondo fino all'inizio del 2006, ma nel luglio di quell'anno, di nuovo alla Carnegie Hall, Coleman aggiunge ai due strumenti acustici anche il basso di McDowell. Da allora sono Falanga e McDowell ad accompagnare il sassofonista e suo figlio, ma almeno in un'altra occasione (in California, nel settembre 2007) si tornano ad ascoltare due contrabbassi e un basso elettrico, con l'aggiunta di Moffett.
La simpatia verso il contrabbasso era già stata testimoniata da alcuni dischi del periodo 1976-1977, in cui Coleman per la prima volta decideva di incidere in duo; la scelta cadeva sul suo bassista storico, Charlie Haden. La coppia dapprima dava testimonianza di sé in due lavori di Haden dedicati a vari duetti, Closeness e The Golden Number; nella rosa di grandi personalità chiamate a collaborare, Coleman era l'unico a comparire due volte. Poco dopo nasceva un intero album a nome dei due, Soapsuds, Soapsuds.
All'inizio di quel decennio un'altra circostanza aveva mostrato quanto delicato fosse il ruolo dello strumento. Nelle sedute d'incisione che danno vita a Science Fiction Coleman non solo riprende, come si è accennato, il suo "quartetto originario"; evoca anche il doppio quartetto di Free Jazz, incidendo alcuni brani con due sax, due trombe, due batterie, più Haden. Ma appunto, il contrabbasso è uno solo: denuncia il desiderio di differenziare gli esiti sonori rispetto al passato o (più probabilmente) le difficoltà nel trovare la giusta coppia di strumentisti?
* * *
Da questa lunga serie di informazioni emerge un dato importante: l'intreccio sonoro fra due contrabbassi ha accompagnato la musica di Ornette Coleman con una continuità e una insistenza rare. Possiamo forse dedurne qualcosa di più? L'impressione è che questa idea di "musica d'insieme" corporea, viscerale, che sposa quasi irrazionalmenre ritmo e melodia, sia fortemente legata a uno dei più sfuggenti concetti (musicali, ma ancor più filosofici) del compositore, quello di "armolodia" (harmolody), ovvero la fusione di "armonia, movimento e melodia".
Idea volutamente ambigua, assolutamente aliena dalle riflessioni sulla musica sviluppate dalla civiltà occidentale, l'armolodia va "percepita" più che analizzata. Anche perché Coleman utilizza in modo del tutto personale la stessa terminologia europea. Basti considerare il termine "unisono," che è centrale nella sua concezione della musica. "Per me," sostiene il musicista, "l'intervallo temperato più libero è la terza minore e una scala cromatica [sic]. Si tratta di suoni che sono all'unisono e che, una volta eseguiti insieme, diventano altri suoni". L'uso del termine aveva già sconcertato Martin Williams, che nelle citate note a Free Jazz cercava di spiegare: "Quello che Coleman chiama un "unisono armonico" (...)non ha senso finché egli non spiega che ogni fiato deve suonare una nota precisa, ma queste sono così distanziate da dar vita a qualcosa che non sembra un'armonia ma piuttosto un unisono". Più chiara, forse, è la descrizione di John Snyder: "Il suo unisono è qualsiasi gruppo di note che all'improvviso si raggruppano insieme e hanno purezza di suono".
In definitiva, come dice Peter Niklas Wilson nel suo Ornette Coleman, His Life and Music, "la teoria armolodica per Coleman è una sorta di programma musical-filosofico che si prefigge di sviluppare la creatività individuale" in qualsiasi campo. E su un piano più strettamente strumentale, afferma Coleman, "ecco come vedo l'armolodia: puoi prendere una qualsiasi melodia e usarla come una linea di basso. O come una seconda parte. O come parte principale. O come ritmo". Non è difficile riconoscere, in questa affermazione, il ruolo dominante che può assumere proprio il basso, acustico o elettrico, solo o ancor meglio in coppia. Non stupisce, a questo punto, che il vecchio maestro si stia sempre più concentrando sull'uso di due bassi.
Ma c'è un'ultima considerazione da fare, che intreccia il livello musicale a quello personale, umano: appunto come è nello spirito dell'armolodia. Nel 1966 A.B. Spellman scriveva nel volume Four Lives In Bebop Business il primo saggio di rilievo dedicato a Coleman. Diverse pagine si concentravano sul ruolo del contrabbasso nella musica colemaniana, ruolo che in quegli anni "militanti" appariva spinoso perché il leader aveva quasi sempre scelto, per quello strumento, accompagnatori bianchi. Nelle parole di Spellman: "Dei nove musicisti che avevano lavorato con Ornette per un periodo abbastanza lungo tre erano stati bianchi, e tutti e tre erano contrabbassisti. Poteva trattarsi di una coincidenza?".
"Non ho trovato," spiegava il sassofonista, "contrabbassisti neri che avessero in pugno la storia dello strumento come diversi dei bianchi che ho conosciuto. Certo gli strumenti ad arco sono stati una delle prime espressioni del mondo non-nero, dato che, a quel che vedo, quasi tutta la musica classica è sostanzialmente musica per archi e gli altri strumenti sono usati per sviluppare le idee degli archi (...) Non mi sono mai imbattuto in un bassista nero che potesse stare al passo con i miei sviluppi musicali. Veramente non ho neanche mai trovato un bassista bianco che sapesse farlo, ma loro possono capire le istruzioni, anche molto complesse, in modo più rapido, e suonare una certa cosa insieme a ciò che sto facendo io semplicemente perché sanno cosa scegliere, sanno che parte dell'estensione utilizzare (...) Nei miei gruppi ho sempre voluto che ognuno esprimesse qualunque cosa desiderasse, ma allo stesso tempo facesse in modo che si suonasse musica insieme (...) Di solito, chi è nella ritmica pensa di dover suonare per i fiati, non di fare musica (...) ma uno strumento è uno strumento, tu devi fondere il tuo strumento con gli altri per dar vita alla musica, non fare semplicemente da supporto perché qualcuno ha bisogno di te per suonare bene".
Dall'argomentazione di Coleman, molto più estesa, par di capire che avesse sofferto gli atteggiamenti egocentrici dell'unico contrabbassista nero con cui aveva lavorato all'epoca, Jimmy Garrison, e che questo lo aveva portato a generalizzare in maniera eccessiva. Si può immaginare che fin dall'inizio della sua carriera di leader Ornette abbia cercato di intrecciare lo spirito individuale della grande creatività jazzistica con le esigenze primarie della musica come totalità e annullamento delle singole personalità. Il nodo della questione, per lui, stava nel ruolo del contrabbasso, strumento che riassume le varie funzioni della musica; e non sembra eccessivo ritenere che finalmente, in questi anni Duemila, il grande jazzista sia riuscito a scioglierlo.
Foto di Claudio Casanova.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.