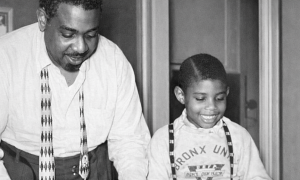Home » Articoli » Lyrics » Cannonball Adderley - Parte prima: la formazione e gli a...
Cannonball Adderley - Parte prima: la formazione e gli anni Cinquanta
La prima volta che ebbi l'opportunità di ascoltare dal vivo Cannonball Adderley fu la sera del 24 marzo 1969 alla Sala Bossi di Bologna. Dietro di me erano seduti Mary Lou Williams ed un suo giovane accompagnatore di colore che portava al collo una vistosa croce: la loro partecipazione entusiastica alla musica ed alle presentazioni verbali del sassofonista, contrastante con la tiepida compostezza del pubblico bolognese, fu la cosa che mi colpì maggiormente di tutto il concerto, dandomi la misura del prestigio di cui godeva Cannonball presso una certa comunità nero-americana.
Quale messaggio, per noi oscuro, riusciva a comunicare al "suo" pubblico? Egli incarnava innanzitutto la figura del preacher, cioè del predicatore, della guida capace di indicare i valori certi della tradizione, ma rappresentava anche lo showman di successo, impostosi a livello internazionale grazie ad una tenace determinazione, oltre che alla debordante e naturale forza creativa.
Come altri jazzisti egli era visto quindi come modello da seguire, etico prima che estetico. Questo ed altro Adderley ispirava nella platea in un rapporto affabile e colloquiale, che si rinnovava ritualisticamente ad ogni concerto: principalmente in patria, dove il "suo" pubblico era composto non tanto dall'alta borghesia nera, né dalle frange dell'estremismo politico, ma piuttosto da una fascia sociale intermedia, sufficientemente colta, prevalentemente integrazionista e soprattutto con solide radici religiose.
Appunto questo carisma ha fatto del grande jazzman un personaggio emblematico di un'epoca - quella che dalla fine degli anni '50 si spinge verso la fine del decennio successivo - e di un genere specifico: quello dell'estroversione, della più calda ed esplicita comunicativa, scevra di intellettualismi e di particolari ambizioni progettuali. Adderley al contrario non è stato un grande innovatore, essendosi impegnato ad estendere nel senso della fluidità il modello parkeriano ed avendo risentito di molte altre influenze nel corso della sua carriera. Anche in seno alla corrente del Soul Jazz, a ben vedere, egli non è stato né il primo né il più geniale esponente, bensì il più fortunato divulgatore. D'altra parte, proprio l'estroversione del suo carattere e la connaturata facilità tecnica gli hanno impedito di scavare in profondità nella direzione della ricerca.
L'inizio della sua carriera, per certi aspetti calato nella leggenda, si è prestato a storielle aneddotiche, delle quali i suoi biografi hanno abusato. È accertato per esempio che il suo soprannome deriva da una deformazione dell'appellativo 'cannibal' affibbiatogli da ragazzino a causa dell'appetito dimostrato durante una sfida gastronomica ingaggiata con un compagno quando era ancora allievo al College di Tallahassee (Florida). È controverso invece se l'alterazione in Cannonball sia stata contestuale a quella gara di voracità o sia piuttosto intervenuta successivamente.
Assai contrastanti, e forse manipolate ad arte, sono pure le notizie riguardanti la prima apparizione del sassofonista a New York, avvenuta al Café Bohemia la notte di domenica 19 giugno 1955. La versione più attendibile sembra essere quella data dal fratello Nat, secondo la quale Charlie Rouse, che lo aveva già conosciuto in Florida, avrebbe incoraggiato Cannonball a salire sul palco per sostituire l'assente Jerome Richardson nel gruppo diretto da Oscar Pettiford: l'impressione suscitata dal giovane sconosciuto fu tale da farlo inserire stabilmente nella formazione a cominciare dal martedì successivo.
Quasi immediatamente nella metropoli si sparse la voce che era sorto il 'nuovo Bird' e, come ha ricordato Orrin Keepnews, ci fu persino chi era pronto a giurare che Cannonball possedeva quello stile già da ragazzo, ancor prima di aver potuto ascoltare il grande Bird; anzi sarebbe stato quest'ultimo a copiare il più giovane collega, dopo averlo udito in Florida. A parte questi eccessi di fantasia, l'appellativo 'nuovo Bird,' che non nasconde intenti ed effetti pubblicitari, dimostra la disinvoltura di un certo tipo di giornalismo effettistico, che tende a ridurre la complessa evoluzione musicale in un passaggio di mano in mano dello scettro del primato. A queste semplicistiche schematizzazioni talvolta i jazzisti si adeguano per convenienza, più spesso vi si contrappongono, cercando di essere considerati per ciò che sono realmente, non perché assomigliano ad altri, per quanto incontestabile possa essere l'influenza dei maestri.
Reso il nostro inevitabile tributo all'impostazione aneddotica che ha spesso afflitto la critica jazzistica, cerchiamo di fare ordine e di ripercorrere le tappe fondamentali della carriera del sassofonista con la maggiore obiettività possibile.
A Tampa in Florida, dove nacque il 15 settembre 1928 da una famiglia di origine caraibica, Julian Edwin Adderley rimase fino all'età di quattro anni; trasferitosi a Tallahassee, tre anni più tardi cominciò ad apprendere i primi rudimenti musicali sotto la guida del padre, che era cornettista, per poi passare a studi regolari al college locale. La sua prima ammirazione fu per i tenoristi, in primo luogo Ben Webster e Coleman Hawkins, ma dall'età di quattordici anni si applicò assiduamente al contralto, sfruttando ogni occasione all'interno ed all'esterno della scuola per fare esperienze jazzistiche.
A quel periodo risale il sodalizio con il fratello Natanjel, trombettista di tre anni più giovane, che si protrarrà, salvo brevi, forzate interruzioni, fino agli ultimi giorni di vita del sassofonista.
Diplomatosi nel 1948, accettò subito un incarico di insegnamento alla Dillard High School di Fort Lauderdale, sempre in Florida, dove per arrotondare lo stipendio si adattò a fare occasionalmente il venditore di automobili. Dal 1950 al 1953 prestò servizio militare; durante questo periodo dapprima diresse la Dance Band della 36^ Armata, della quale facevano parte anche il trombonista Curtis Fuller ed il pianista Junior Mance e nella quale favorì l'inserimento del fratello Nat, poi pilotò una formazione alla U.S. Naval School of Music di Washington ed infine organizzò un gruppo a Fort Knox.
Conclusa la lunga e gratificante parentesi militare, Julian riprese per un paio d'anni l'insegnamento a Fort Lauderdale, fino a quando nel 1955 non decise di tentare la fortuna a New York, dove si recò una prima volta sperando invano di essere assunto nell'orchestra di Lionel Hampton, della quale il fratello faceva parte già da alcuni mesi, ed una seconda volta nel giugno, con l'intenzione di seguire un corso di specializzazione all'università e contemporaneamente di costituire un gruppo assieme a Nat ed ai fratelli Cooper, anch'essi provenienti dalla Florida.
Ma, come è già stato anticipato, il caso volle che fosse subito ingaggiato al Café Bohemia nel gruppo di Oscar Pettiford. Immediatamente dopo venne contattato da Bob Shad, direttore artistico della Mercury, che gli diede l'opportunità di entrare in sala d'incisione. Dalle sedute del luglio 1955 videro la luce tre LP: Bohemia After Dark a nome di Kenny Clarke, Julian 'Cannonball' Adderley, in cui il sassofonista è alla testa di un ottetto, che si regge su raffinati impasti timbrici di sapore ancora cool, e Presenting Cannonball Adderley, che propone un solido quintetto composto da Hank Jones, Paul Chambers e Kenny Clarke, oltre ai fratelli Adderley.
In queste primissime fatiche discografiche, che comprendono sue composizioni, piacevoli e misurate, abbastanza convenzionali e quasi tutte su tempi medi, Cannonball palesa il suo debito verso il modello parkeriano, che traduce in un linguaggio stentoreo e declamatorio, ancora un po' brusco, non perfettamente intonato nella sonorità e non sempre sorretto da una fluidità e da una fantasia ineccepibili. Inoltre, il ventisettenne sassofonista dimostra, soprattutto nei tempi lenti, di avere in Benny Carter e Johnny Hodges altre fonti di ispirazione, anche se in questo caso talvolta eccede in toni un po' leziosi e pigolanti. Sono comunque evidenti anche le sue notevoli risorse tecniche: per esempio nel registro grave dello strumento rivela una morbidezza vellutata ed un controllo del basso volume che costituiranno una delle sue caratteristiche peculiari.
Nell'autunno di quell'anno fu costretto a fare la spola fra Manhattan, dove incise altri dischi, uno dei quali lo vede accompagnato da un'orchestra d'archi diretta da Richard Hayman, e Fort Lauderdale, dove doveva portare a termine il suo impegno di insegnante. Di nuovo e definitivamente a New York nel gennaio 1956, poté costituire finalmente un proprio gruppo più o meno stabile, composto fondamentalmente da Nat, Junior Mance, Sam Jones e Jimmy Cobb. Non mancarono moderate occasioni di lavoro, né l'apprezzamento dei critici; continuarono le incisioni per la EmArcy, sottoetichetta della Mercury dedicata al jazz, ed altri leader, per esempio Dinah Washington, Milt Jackson e Machito, si assicurarono la partecipazione di Cannonball a propri dischi.
Tuttavia la concorrenza a New York era tale da non permettere a un nuovo gruppo di sopravvivere dignitosamente. A tale proposito è assai significativa la testimonianza che lo stesso sassofonista ci ha consegnato nel suo saggio "Paying Dues; The Education of a Combo Leader," pubblicato su Jazz Review nel 1960: "Fu presto chiaro che essere abili in Florida non aveva nulla a che fare con la competizione a New York. Alla fine fummo costretti a sciogliere quel primo gruppo: dopo venti mesi non riuscivamo a guadagnare più di 1000 dollari alla settima. In realtà nessuno ci riusciva esclusi Miles, Chico e Brubeck. Io avevo ricevuto da Dizzy l'offerta di aggregarmi al suo gruppo. Mi imbattei in Miles al Bohemia, gli dissi che stavo per mettermi con Dizzy e Miles mi chiese perché non mi mettevo con lui... Gli risposi che non me lo aveva mai chiesto!"
Questo, dopo l'arrivo a New York, fu uno degli avvenimenti cruciali nella carriera di Cannonball. Egli rimase nel gruppo di Davis dall'ottobre 1957 al settembre 1959 (ma anche in seguito non mancarono occasioni di collaborazione fra i due) e l'esperienza fu di fondamentale importanza per la sua maturazione musicale e professionale. Non è questa la sede per affrontare un'approfondita analisi sui presupposti e sui risultati di questo sodalizio; basti ricordare che dal canto suo Miles aveva sempre ammirato il suo particolare senso del blues ed anche le sue qualità umane, che lo indussero ad affidargli pure il delicato incarico di road manager del gruppo.
L'insegnamento che l'ormai trentenne sassofonista trasse dal mondo poetico del leader e dalle complessità armoniche che andava esplorando John Coltrane, l'altra ancia del sestetto, fu enorme: in particolare cominciò a pensare diversamente lo sviluppo degli assoli, dando più peso di un tempo alla limpidezza del disegno, all'essenzialità ed alle pause, pur ampliando le possibilità delle soluzioni melodico-armoniche.
La produzione discografica di questa formazione occupa notoriamente un posto di rilievo nella storia del jazz. Qui è appena il caso di rilevare come il carattere generale e l'andamento degli assoli nelle registrazioni dal vivo risultino notevolmente diversi da quelli delle incisioni in studio. In quest'ultimo caso infatti prevale una enorme attenzione per la forma, la struttura dei brani è più calibrata e precisa, l'atmosfera pacata e pensosa, mentre nelle più estese versioni delle live performance compare una maggiore spericolatezza, un'accesa carica espressiva, decisamente visionaria: in particolare il linguaggio di Cannonball, stralunato ed accentuato negli intervalli, trascende l'esempio di Parker ed anticipa la pronuncia di Dolphy.
D'altra parte, nel biennio trascorso con Davis il nostro personaggio poté affrontare altre collaborazioni discografiche in gruppi pilotati dai davisiani Paul Chambers e Philly Joe Jones, o da Kenny Dorham, ma è soprattutto la sua partecipazione all'album New Bottle, Old Wine a nome di Gil Evans che richiama la nostra attenzione. La parte orchestrale, sontuosa e ricca di timbri e cadenze diverse, costituisce un supporto solidissimo alla voce protagonista di Adderley, che, in qualità di ospite d'onore, si inserisce con sicurezza perentoria, ma anche con vivacità ed ironia, nel contesto predisposto dal pianista.
Sempre nel periodo 1958-'59 furono una decina i dischi incisi a suo nome, dapprima per la EmArcy, poi occasionalmente per la Blue Note, quindi, dall'estate del 1958, per la Riverside diretta da Bill Grauer, con la quale firmò un regolare contratto. In genere si tratta di blowing sessione, vale a dire di sedute d'incisione in studio, prive o quasi di preparazione, sulla base di semplici arrangiamenti di brani dall'impianto abbastanza risaputo. Al suo fianco, non disponendo di un gruppo fisso, si alternano musicisti di ottimo livello: i trombettisti Blue Mitchell e Freddie Hubbard, ancora un po' acerbo, oltre ovviamente al fratello Nat, il vibrafonista Milt Jackson, i pianisti Hank Jones, Bill Evans, Wynton Kelly, i bassisti Sam Jones, Percy Heath, Paul Chambers, i batteristi Art Blakey, Philly Joe Jones, Connie Kay, Jimmy Cobb.
Di questa produzione, che di solito vede la forma prevalere sull'espressività, è il caso di segnalare Something Else! e Cannonball Adderley Quintet in Chicago, che si avvalgono rispettivamente delle presenze tutt'altro che marginali di Davis e Coltrane, Portrait of Cannonball, che include due takes di "Minority" scattanti ed esasperate, nelle quali il leader dimostra una straordinaria abilità nella respirazione, intessendo assoli fin troppo continui e compatti; inoltre Things Are Getting Better, di grande eleganza ed equilibrio e Takes Charge, che è uno dei pochissimi dischi in quartetto dell'intera produzione adderliana. Quello che è rilevabile da tutti questi LP è la grande ricchezza della sua tecnica strumentale (ma, come vedremo, la sua evoluzione in tal senso non si fermerà mai). In particolare, il suo approccio si adegua alle caratteristiche implicite di ogni brano ed il fraseggio è fluido e rilassato, di grande mobilità armonica, riuscendo comunque a concludersi sempre brillantemente.
Lasciato il gruppo di Davis e dopo una breve parentesi quale solista nell'orchestra di George Shearing, il sassofonista pensò seriamente a rimettere in piedi un proprio combo assieme al fratello, che nel frattempo aveva suonato con Jay Jay Johnson e con Woody Herman. A completare il quintetto chiamò il bassista Sam Jones, anch'egli originario della Florida, il batterista Louis Hayes ed il pianista Bobby Timmons. The Cannonball Adderley Quintet in San Francisco, registrato nell'ottobre 1959 al Jazz Workshop durante un'acclamata permanenza di quattro settimane, costituisce il primo esaltante documento di questo gruppo. Il repertorio è costituito da vecchi brani, ma rinnovati nello spirito esecutivo, come "Spontaneous Combustion" del leader, "Hi-Fly" di Randy Weston, "Bohemia After Dark" di Pettiford e soprattutto include "This Here," una eccitante hit di Bobby Timmons.
Da questo momento in poi la musica e le performances di Cannonball, impreziosite fra l'altro dalle sue coinvolgenti introduzioni verbali, acquisirono un'inconfondibile fisionomia e il decollo del suo successo, sancito anche dalle votazioni dei referendum delle riviste specializzate, fu inarrestabile. È appunto dalla fine del 1959 che Adderley venne visto come l'alfiere del Soul Jazz, vale a dire di quel movimento che, richiamandosi al senso ritmo-melodico del Gospel ed alla temperie sovreccitata delle funzioni della Chiesa Metodista, perseguiva una comunicazione semplice ed intensa, ricca di umori funky. Anche se, per l'obiettività storica, bisogna ricordare che il sassofonista già nel gennaio 1957 aveva partecipato all'incisione di Plenty Plenty Soul di Milt Jackson e appena un mese dopo aveva inserito nel suo Sophisticated Swing un brano intitolato programmaticamente "Another Kind of Soul," quasi a voler dare una propria, inedita versione del concetto di soul.
A questo punto s'impone una breve digressione appunto sul Soul Jazz che, a ben vedere, non si configurò come una corrente compatta ed innovativa, con regole vincolanti, ma piuttosto come un'opzione stilistica che alla fine degli anni '50 serpeggiò trasversalmente nell'area dell'hard bop. In altre parole, mi sembra ozioso fare, come è stato fatto, una sorta di graduatoria dei primati in merito alla creazione di questa tendenza musicale: la verità è che l'esigenza di ancorarsi saldamente alle proprie radici culturali, in un momento caratterizzato fra l'altro da acute tensioni sociali, affiorò più o meno contemporaneamente e più o meno genuinamente nei lavori di molti jazzmen di colore, da Mingus a Blakey, da Horace Silver a Bobby Timmons, da Milt Jackson a Les McCann (... ma contagiò anche un classico come Coleman Hawkins, che nel novembre 1958 incise un album intitolato appunto Soul).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.