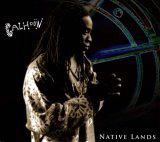Home » Articoli » Interview » A fondo con Gavin Bryars
A fondo con Gavin Bryars
Dopo la seconda guerra mondiale ci sono state tre grandi "soluzioni rivoluzionarie" nel campo della musica: una è stata quella di John Cage, la seconda è stata il minimalismo e la terza è stata la musica sperimentale.
Gavin Bryars è un compositore che pare sostanzialmente divertirsi a fare ed eseguire la propria musica: questa è l'impressione che mi ha dato nel corso di una lunga e amabile conversazione. L'opera proposta al Teatro Malibran la sera precedente, The Sinking of the Titanic, è, insieme a Blood Never Failed Me Yet, il suo cavallo di battaglia. Nel cartellone di una Biennale dedicata al "teatro musicale" una sua ri-proposizione è parsa quasi divinatoria.
The Sinking of the Titanic è un'opera aperta (per definizione dello stesso Bryars). Risulta essenziale per capire una filosofia che più che essere devota al minimalismo, alla ripetizione e alla scomposizione delle scritture minime del suono, pare affidare ad un esuberante processo di continua rielaborazione il suo dinamismo e la sua profondità. Ha una durata che oscilla tra venticinque minuti e l'"ora e oltre" ed è mutevole anche nella strumentazione con cui può essere realizzata. Come possibili materiali include ensemble d'archi, percussioni, ottoni e quartetto per ottoni, clarinetto, cassette con registrazioni di voci, tastiere, diapositive, effetti sonori, music box...
La versione presentata da Bryars era un adattamento "in forma scenica" di un The Sinking of the Titanic per ensemble. In un Malibran particolarmente oscuro, con un grande schermo su cui scorrevano le immagini video di Andrew Hooker, erano presenti sul palco l'Alter Ego Ensemble, lo stesso compositore al contrabbasso e Philip Jeck ai giradischi. La partitura adattata per l'Alter Ego era accompagnata da segnali morse affidati a woodblocks, voci registrate dei sopravvissuti, nonché elaborazioni di immagini dei volti di un certo numero di cadaveri rinvenuti nel relitto ed effetti sonoro-rumoristici da vero e proprio abisso marino. Suoni e immagini rigorosamente corrose dai pulviscoli sonori e dalle lesioni o abrasioni visive che calcolatamente evocavano - in un ritmo che ondeggiava nella scura e lenta dimensione della memoria - la dimensione temporale (ossessivamente dilatata) e le profondità (cupe, oscure, abissali) in un cui è affondato il relitto del Titanic. Tragedia, leggenda, senso di morte e di vita insieme, assenza di circolazione di sangue, ossa, volti emaciati, oceano, ottenebramento, sprofondamento, silenzio, assenza d'ossigeno: queste alcune delle immagini che il Titanic e la sua tragedia hanno inglobato. Dal silenzio e dal oscurità degli abissi, Bryars fa emergere schegge di memoria...
All About Jazz Italia: Mi è piaciuta molto la tua interpretazione di ieri sera. Non deve essere stato facile mettere insieme l'Ensemble Alter Ego, il tuo modo di elaborare da anni quest'opera, quello completamente nuovo di Andrew Hooker e di Philip Jeck. Come è nata l'idea di fare una versione per ensemble, video artist e artista di punta della scena noise?
Gavin Bryars: I membri dell'Ensemble Alter Ego mi hanno contattato lo scorso anno perché erano molto interessati a registrare questo progetto. Volevano interpretare i miei pezzi e a me sembrava un'occasione interessante per pensare ad una ri-elaborazione di The Sinking of the Titanic. Forse in gennaio la registreremo a Roma. Nel frattempo con l'Alter Ego abbiamo in programma una serie di concerti e vorremmo portare in scena una versione di The Sinking of the Titanic nella quale ci sono i miei figli che suonano. Sono in gamba i musicisti dell'Alter Ego e mi piace molto come suonano...
AAJI: L'Alter Ego ha inciso ottime interpretazioni di quella che tutti definiscono musica minimalista. Le loro registrazioni di Philip Glass sono molto belle. Vi siete preparati a lungo per il concerto di ieri sera?
G.B.: Loro forse sì! Ma insieme abbiamo lavorato relativamente poco, in tutto solo due giorni. Sono comunque abbastanza, perché considera che normalmente dedico lo stesso tempo anche ad altri ensemble. Quando ci siamo incontrati, ho sostanzialmente cambiato alcune dinamiche ed abbiamo rivisto insieme i suoni di alcuni passaggi.
AAJI: Quando e perché hai scelto di lavorare sul Titanic?
G.B.: È stata la prima grande tragedia del Novecento.
Non ho mai smesso in fondo di lavorare a quest'opera. Il pezzo nasce per una mostra in un momento in cui ero molto interessato a capire se era possibile creare un equivalente musicale di un lavoro d'arte concettuale. Sono stato sollecitato da un gruppo di studenti della scuola d'arte di Portsmouth in cui insegnavo nel 1969 e quella è stata la prima occasione di mettere in scena The Sinking of the Titanic. Nel 1972 ho poi realizzato una versione per un concerto a Londra e da allora ho suonato quest'opera moltissime volte, in versioni molto differenti tra loro.
È senza dubbio un'opera aperta, che tiene conto di tutte le testimonianze e dei dati sul disastro che sono emersi e che ho avuto a disposizione da quando ho incominciato a scrivere questo lavoro ad oggi. Quella del Titanic è diventata una sorta di leggenda ricca di materiali di ogni tipo. Leggenda che è stata tragedia...
Nonostante il pezzo abbia ormai molti anni, continuo a divertirmi a trovare sempre nuovi modi di guardare a questo materiale e sono felice ogni volta che ho l'opportunità di immergermi in esso come se fosse la prima volta.
AAJI: Continui a leggere e raccogliere materiali sul Titanic anche ad anni di distanza?
G.B.: Non ora, ma se mi capita di trovare qualcosa di nuovo lo metto da parte. Tempo fa per esempio, avevo in progetto di realizzare una nuova versione in Olanda. Dall'ultima volta che ci avevo lavorato erano emerse nuove informazioni su una serie di sopravvissuti, interviste, memorialistica e materiale di questo tipo. Avevo scoperto, ad esempio, che sul Titanic c'erano un gran numero di libanesi e di arabi. Mi si è aperto un mondo completamente nuovo che non conoscevo. Sul Titanic si sono incrociate moltissime storie, le più diverse e incredibili, e questo è davvero un aspetto interessante. [1]
AAJ: Per curiosità, hai mai realizzato una versione di The Sinking of the Titanic su una nave?
G.B.: No, su una nave mai; in una piscina, una volta. È stata una delle performance più belle, con il Balanescu Quartet.
AAJI: Sarei molto curiosa di saperne di più sulla versione di The Sinking of the Titanic che hai fatto per la mostra di Christian Boltanski all'Art Tower Mito in Giappone. Quali sono le principali differenze con quella che abbiamo visto ieri sera?
G.B.: Con Christian Boltanski abbiamo collaborato in due grandi occasioni. La prima è stata quella in cui Boltanski ha realizzato una installazione per una mia performance al Festival della Primavera di Bourges, nel 1990, in un serbatoio idrico in disuso. Si trattava di un'installazione molto strana, con alcuni video che mostravano il Titanic e degli oggetti recuperati direttamente da esso. Di questo live abbiamo realizzato in CD per la Crepuscole. Anche se contiene materiali consimili, si tratta di una versione diversa da quella registrata per la Obscure del 1975. La seconda è stata l'esecuzione di The Sinking of the Titanic all'Art Tower Mito, in Giappone, con il Balanescu Quartet, ma questa volta è stata realizzata come parte della mostra di Boltanski. Devo dirti che ha funzionato benissimo. Sono oramai venticinque anni che conosco Christian e con lui mi trovo molto bene.
Per tornare alla tua prima domanda: dato che sono molti anni che collaboro con artisti visivi, mi sembrava del tutto naturale coinvolgere Andrew Hooker...
AAJI: Hai collaborato con molti altri artisti o video artisti?
G.B.: Parecchi! Con Tim Head per una performance live di Jesus' Blood Never Failed Me Yet, con Bruce MacLean per Invention of Tradition e con James Hugonin per The North Shore, From Mina Harker's Journal e The Island Chapel - che sono state scritti appositamente per sue esibizioni. I quadri di Jennifer Bartlett sono stati diventati parte integrale del disegno di Four Elements. Anche Bill Culbert ha realizzato una istallazione per una performance live di The Sinking of the Titanic. Poi ho fatto altre cose ma come parte di mostre collettive, ma quasi sempre suonando cose mie; quindi senza lavorare direttamente con loro, ma nel contesto artistico. La mia prima esperienza di insegnamento è inoltre stata in una scuola d'arte...
AAJI: E... non hai mai pensato di fare arte?
G.B.: No!
AAJI: Hai voglia di dirmi cosa significa per te - se significa qualcosa - il termine minimalismo? Esiste per te un tipo di musica che possiamo dire minimalista, anche se ci sono alcuni che pensano non esista?
G.B.: Certo che esiste qualcosa che chiamiamo minimalismo. Il minimalismo nasce a partire dai lavori degli anni Settanta di Steve Reich - che allora era completamente sconosciuto ai più e non era assolutamente famoso. Io andavo ai suoi concerti dove c'erano al massimo dodici persone! Tra di noi c'era uno scambio di idee su quello che lui pensava del minimalismo e sull'idea di fare una musica nuova, diversa, minimalista appunto. Mi piaceva il suo lavoro, ma ad un certo punto avevo bisogno di prendere un'altra strada. Lui è diventato molto famoso, continuando a riproporre da allora, all'incirca, le stesse cose che suonava.
Il minimalismo come genere musicale è, per me, sostanzialmente definito da quel periodo - è un fatto di storia della musica se vuoi - e da quei compositori che vi sono stilisticamente legati, ovvero da quei compositori che hanno scritto pezzi in base allo stile tracciato in quegli anni. John Adams, per esempio, era uno di quelli. Oggi non potresti definire la musica che John Adams compone minimalista, perché in realtà è molto più eclettica. John compone musica "classica" combinandola, a volte, con il rock e con differenti altri tipi di musica. È senza dubbio un compositore molto più poliedrico, ma capisci quanto sarebbe riduttivo qualificarlo solo come minimalista - anche se c'è chi lo definisce un minimalista!
Minimalista è dunque un aggettivo che si applica alla tradizione, a quella fase iniziale musicale, ma lo stesso è un aggettivo che diventa statico se applicato a quelle successive. Fase iniziale in cui - tengo a precisare - si lavorava sulla ripetizione e sulla scomposizione delle scritture minime del suono.
Trovo che a volte sia troppo semplicistico definire un compositore o un artista minimalista. È stata un'idea sulla quale molti hanno lavorato. Ora non potrebbe funzionare.
AAJI: C'è stato chi ha pensato che in qualche modo il minimalismo potesse essere un'idea "rivoluzionaria" di intendere la musica. Cosa ne pensi?
G.B.: Rivoluzionaria?! All'inizio senz'altro! Credo sia stato un cambiamento drammatico, una vera e propria rivolta critica con la musica che c'era allora. Dopo la seconda guerra mondiale ci sono state tre grandi "soluzioni rivoluzionarie" nel campo della musica: una è stata quella di John Cage, la seconda è stata il minimalismo e la terza è stata la musica sperimentale. Il minimalismo ha avuto sicuramente grandi connessioni con l'avanguardia americana e con John Cage - che è stato il maestro di molti compositori che hanno poi fatto parte del minimalismo. Effettivamente nel momento in cui è nato il minimalismo è stato rivoluzionario perché si poneva "contro", ma poi le cose sono cambiate in fretta...
AAJI: E per quanto riguarda la musica sperimentale inglese?
G.B.: Moltissime cose sono cambiate dagli anni Sessanta, ma soprattutto Settanta. Ora quella scena sperimentale non esiste più...
AAJI: Evan Parker continua però a fare sperimentazione...
G.B.: Conosco molto bene Evan Parker, da più di quarant'anni oramai. Siamo persino stati vicini di casa per tre anni! Mi piacciono le cose che fa adesso, anche se abbiamo preso strade completamente diverse.
Ho partecipato alla scena sperimentale inglese, all'inizio soprattutto, nell'ambito dell'improvvisazione con Joseph Holbrooke, Tony Oxley, Derek Bailey e altra gente di quel mondo. [2]
AAJI: Sei ancora interessato a fare quella musica?
G.B.: Musicalmente, artisticamente ed emozionalmente penso sia un'esperienza conclusa. Dopo quest'esperienza ho avuto altre opportunità, ho cominciato a lavorare con John Cage e mi ha interessato di più la composizione. Questo è un mondo completamente differente da quello dell'improvvisazione, molto più distaccato, intellettualmente parlando, e meno coinvolgente a livello emozionale per un musicista. Nel 1998 con Tony Oxley ci siamo ritrovati a suonare insieme per una radio, in Germania. È stato un week-end durante il quale abbiamo esclusivamente lavorato su suoi temi, una specie di anniversario.
AAJI: È stato difficile ritrovarsi a suonare insieme dopo così tanto tempo e con esperienze così diverse alle spalle?
G.B.: Per nulla! Certo nel corso di tutti quegli anni Tony aveva continuato a lavorare nell'improvvisazione. Non l'avevo rincontrato molte volte, ma ero rimasto in contatto con lui, come amici intendo. Dopo il sound-check, abbiamo cominciato a suonare; eravamo davanti a poca gente, come in genere accade per le registrazioni in radio, ed abbiamo suonato per circa cinquanta minuti. Come vecchi amici che incominciano a parlare, così noi abbiamo preso a suonare. È stato un po' difficile trovare la giusta strada, ma poi mi sono divertito e non ero per nulla nervoso. Abbiamo registrato quelle sessions per la Cortical Foundation. [3]
AAJI: Hai collaborato anche con Eddie Prevost?
G.B.: Ho lavorato con Eddie, ma lui era più un teorico. Sono stato coinvolto in alcuni progetti nei quali partecipava Eddie, soprattutto in alcuni progetti collettivi [4]. Eddie per alcuni versi è un militante sulla questione dell'improvvisazione. Ha scritto molto sull'improvvisazione, sulla scena radicale, sul jazz [per leggere degli scritti di Eddie Prevost clicca qui]. Una volta ha dato una conferenza, alla quale ho partecipato. Quando mi sono presentato, mi ha chiesto: "Cosa ci fai qui? Tu sei un compositore non dovresti essere qui!". Era quasi come se vedesse improvvisazione in opposizione alla composizione! Comunque conosco bene sia Eddie, che Keith Rowe, Lou Gare e molti di quelli che in quegli anni hanno lavorato con Eddie.
AAJI: C'è una nuova generazione di compositori, ma anche di jazzisti, che tu pensi sia davvero interessante da seguire?
G.B.: Ci sono moltissimi improvvisatori, ma anche giovani compositori interessanti. Soprattutto nel jazz noto che c'è gente molto giovane e davvero in gamba... Devo però confessarti che non sono aggiornatissimo. In genere mi capita di sentire cose nuove quando ascolto la radio. Oppure leggo riviste di musica e ogni tanto compro le cose più interessanti. In genere sono i festival i momenti in cui ascolto il maggior numero di giovani e di cose nuove.
AAJI: Ascolti molta musica?
G.B.: Si, soprattutto quando guido in macchina. In generale cerco di ascoltare di tutto. Siccome sono molto interessato a scrivere per la voce - canzoni, madrigali, musica corale, opera - ascolto molta musica antica. Di recente, ad esempio, sto ascoltando musica medievale perché per la mia etichetta [GB Records] ho inciso una rivisitazione delle laudi medievali intitolata Oi Me Lasso con il soprano Anna Maria Friman.
Qualche anno fa, qui alla Biennale di Venezia, avevo presentato Lauda un lavoro scritto in apertura di un pezzo di danza di Carolyn Carlson, Writings on Water. Questo pezzo per voce sola affonda le sue radici nella musica antica ed è basato sullo spirito e sulle atmosfere delle laudi del 14 secolo. Di recente ho anche registrato I have heard it said that a spirit enters... con Holly Cole, un lavoro per low female voice e orchestra da camera, su testo di Marilyn Bowering [CBC Records].
Ascolto anche molte cose della musica dell'Europa del Nord, dell'Estonia e della Lituania. Quelle atmosfere e quelle musiche mi piacciono molto...
AAJI: Sei o saresti interessato a produrre musica del Nord Europa e dell'Estonia per la tua etichetta?
G.B.: Tra vari work in progress ho intenzione di incidere The Third Book of Madrigals. Si tratta di una traduzione di un testo di Petrarca in una specie di prosa in irlandese fatta da J.M. Synge circolato sotto il titolo di Laura in Death. Mi ci sono imbattuto alla Biblioteca della University of Victoria, dove è conservata una bella collezione di lavori di Synge. I pezzi sono scritti per Red Byrd (soprano, tenore, basso e liuto). Alcuni sono per l'ensemble intero, altri per sola voce, tre sono combinazioni in duo con alcuni interludi per liuto solo.
AAJI: Hai in progetto collaborazioni con altri contrabbassisti?
G.B.: Charlie Haden mi ha chiesto di incidere qualcosa con lui. Qualche anno fa, avevo già registrato un pezzo, "By the Vaar", in Farewell to Philosophy [1996, Point].
AAJI: Come mai tra tutti i "minimalisti" sei quello che ha collaborato meno con il Kronos Quartet? Non ti piace come suonano, hai avuto problemi oppure è una semplice casualità? Ho come l'impressione che la tua musica sia difficilmente "kronosizzabile". Voglio dire che il Kronos Quartet ha avuto collaborazioni ovunque e con molti musicisti diversi nel mondo, ma, soprattutto ultimamente, tende ad applicare un modello "alla Kronos" - per intenderci - su qualsiasi musica eseguita e a qualsiasi latitudine. Forse è una nuova forma di globalizzazione. Cosa ne pensi?
G.B.: È un concetto molto americano! È una forma di colonialismo, nel vecchio senso del termine ed anche in senso politico. Vogliono che il mondo si americanizzi, senza ascoltare le diversità che ci sono nel mondo. Guarda cosa è stato con le culture indigene americane... Non stupisce che questo possa filtrare anche nella musica, per nulla immune dalla politica e dalla storia. Il Kronos è una manifestazione di questa politica ma ad un livello "alto", "raffinato", "colto". Questo credo sia un aspetto insidioso. Comunque conosco il Kronos Quartet molto bene e credo ci siano delle musiche su cui si applica alla perfezione l'idea di esecuzione del Kronos.
AAJI: Per quanto ti riguarda, il Balanescu resta il tuo quartetto di riferimento?
G.B.: Sono molti anni che collaboro con Alexander Balanescu. Ora il Quartetto suona fondamentalmente la sua musica, ma anni fa abbiamo inciso molte cose insieme. Quando ho suonato in Giappone per la mostra di Boltanski [v. foto a sinistra], ad esempio, c'era il Balanescu. Negli anni Novanta Alexander è stato talmente preso dai suoi lavori che le collaborazioni sono diventate più rade e difficili e a quel punto abbiamo deciso di chiudere. Ho collaborato con altri Quartetti ed Ensemble: dall'Arditti Quartet, The Lyric Quartet, al The Hilliard Ensemble e anche il Vienna Saxophone Quartet e il Delta Saxophone Quartet. Non ho comunque un quartetto di riferimento fisso. In Italia, ad esempio, ho collaborato con il Quartetto di Parma, ma è stata una collaborazione occasionale, e ora, come hai sentito, con l'Alter Ego Ensemble.
NOTE
[1] Incuriosita dal racconto di Gavin Bryars, ho approfondito l'argomento, scoprendo tra le altre cose che esiste un sito "enciclopedico" colmo di informazioni di ogni tipo sia sul Titanic che sulle vite di coloro che vi erano a bordo: www.encyclopedia-titanica.org - torna al testo dell'articolo.
Gavin Bryas mi ha poi raccontato ("a microfoni spenti") molti aneddoti sulle diverse e varie versioni da lui registrate di quest'opera. Molto di quanto raccontatomi si trova in due scritti, pubblicati entrambi sul suo sito, a cui rimando: The Sinking of the Titanic (1969-) e The Sinking of the Titanic at Xebec (1990)
[2] Per approfondire quegli anni, rimando ad uno scritto dello stesso Gavin Bryars, pubblicato sul suo sito, Cover Notes, e ad uno scritto di Derek Bailey, On the other hand... - torna al testo dell'articolo.
[3] Di questa esperienza - pubblicata in Joseph Holbrooke 98 [1998; Incus 39] - Gavin Bryars parla dettagliatamente in uno scritto pubblicato sul suo sito: Notes for Cortical Foundation CDs - torna al testo dell'articolo.
[4] Keith Rowe, Eddie Prevost, Cornelius Cardew, Gavin Bryars e altri compositori e improvvisatori registrarono nel 1969 Silver Pyramid [2001; Matchless Recordings, MRCD40] - torna al testo dell'articolo.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.