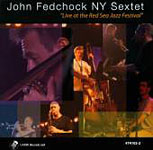Home » Articoli » Lyrics » USA versus Europa. Alle radici di una diversità.
USA versus Europa. Alle radici di una diversità.
Nella Mitteleuropa non ho trovato nulla che si possa definire come una tendenza assolutamente nuova in campo compositivo, se si escludono le sperimentazioni che partono dallo stile sincopato del jazz americano...
Sono convinto che in questo dopoguerra stia costituendosi una cultura nuova, e che in America essa si manifesterà nella forma di un rinascimento musicale
[Edgar Varèse, 1922]
Nel più importante dizionario musicale edito in Italia, la voce Stati Uniti (venti colonne di testo) presenta il seguente indice: A) Musica popolare: I. Strato culturale amerindio [vi si parla della musica delle comunità autoctone, dagli indiani delle grandi pianure, ai Navajos, ai Pueblos, fino al contatto con la cultura dei bianchi e ai fenomeni musicali legati ai sussulti nazionalisti della fine del secolo scorso come la "danza degli spettri"]. - II. Strato culturale anglosassone [vi si descrive il repertorio originato dalle tradizioni dei pionieri inglesi: ballads, square dances, broadsides ecc.]. - III. Strato culturale afro-americano [vi si accenna alle caratteristiche modali, formali ed interpretative del blues, del gospel, dello spiritual]. - IV. Strato culturale euroamericano [vi si rileva la presenza di distinguibili connotati etnici italiani, balcanici, slavi all'interno musica tradizionale bianca]. - B) Musica colta: I. Le origini [dalle 39 melodie dell'innario dei padri pellegrini, ai primi importanti compositori statunitensi come William Billings, Jeremiah Ingalls, Francis Hopkinson ecc.]. - II. - Il periodo dal 1790 al 1865 [la diffusione delle musiche di Händel, di Haydn ecc., il sorgere delle prime società concertistiche, le figure "rivoluzionarie" di compositori come Antony Ph. Heinrich, George F. Bristow, Louis M.Gottschalk]. - III. Il periodo dal 1865 al 1900 [John K. Paine, Edward MacDowell, Horatio Parker ecc., l'importanza di Antonin Dvorák]. - IV. Il secolo XX [la solitaria lezione di Ives, quindi una rapidissima carrellata di nomi che include fra gli altri Varèse, Gershwin, Antheil, Cowell, Copland, Harris, Piston, Carter, Thomson, Session, Menotti, Bernstein, quindi John Cage, Lukas Foss, Morton Feldman, Christian Wolff, Earle Brown, La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass].
Scorrendo i capitoli di questa voce enciclopedica e poi alla fine di essa, si incontrano i rimandi alle voci Blues, Country and Western, Jazz, Musical, Negro Spiritual, Pop music, ovvero a tutti quei generi musicali che nel corso della trattazione vengono volutamente tralasciati.
Questa voce Stati Uniti è paradossalmente esemplare: esemplare nel senso della totale incapacità o dell'impossibilità tout court di trattare questa materia attraverso le griglie della musicologia sistematica tradizionale, entro la partizione fra "popolare" inteso come etnico e "colto" inteso come eurocolto. Una volta letta questa voce sulla musica degli Stati Uniti non si è appreso nulla o quasi circa la sua funzione determinante nel quadro della cultura contemporanea.
Per rintracciare nozione di questo ruolo, per reperire dati su "ciò di cui si parla," su ciò che si intende nella media cultura con la locuzione "Musica degli USA," bisognerebbe spigolare proprio fra quei rimandi: assemblando Blues, Country, Jazz, Musical, Negro Spiritual, Pop si otterrebbe un resoconto assai più pertinente in questo senso. Ma anche in questo caso la trattazione sarebbe inevitabilmente viziata dall'incompletezza del quadro e dall'assenza di quella foltissima rete di nessi che intercorrono fra i diversi campi.
Poiché se è vero che la cultura musicale statunitense è il melting pot in cui si sono formati e si formano tutt'ora i fattori trainanti e determinanti del costume musicale di questo secolo, è anche vero che in questa cultura eventi e poetiche sono maturati proprio come prodotti della complessa interazione di quelle molteplici stratificazioni che la musicologia concepisce invece come campi oggetto di competenze separate. L'imbattersi in una voce enciclopedica incapace di comprendere e sintetizzare questa molteplicità esemplifica prima di tutto un sostanziale e grave imbarazzo sistematico, alle cui spalle c'è un'impotenza teorica.
Quando una delle più aggiornate e importanti storie della musica USA, Music in the New World di Charles Hamm, pubblicata nel 1983 e recentemente tradotta in italiano, si conclude affermando: "Che ci piaccia o meno, il resto del mondo vede in maggioranza la musica leggera e il jazz americani come il prodotto più importante e riuscito del Nuovo Mondo," essa fotografa la serie intera delle questioni fondamentali. Col rimando al "resto del mondo," Hamm, coglie una forma di alienazione della musica USA che è il corollario obbligato di quell'imponente realtà mediale di un mondo che consuma musica di produzione statunitense, di un mondo colonizzato da rock-star, colonne sonore, jazzmen, dance music e quant'altro di provenienza prettamente nordamericana.
Questa gigantesca diffusione si traduce qui nella percezione dell'importanza oggettiva assunta dall'opinione pubblica mondiale, nella percezione cioè dell'espropriazione di una musica che si avvicina pericolosamente ad essere ciò che gli altri pensano di essa, che perde in altre parole la propria identità, l'ubi consistam, che rasenta una condizione eterodiretta, influenzata e gestita dal consumo planetario. Nella frase dello studioso statunitense c'è dunque una rivendicazione di identità che è sì la rivendicazione dell'americano, ma è, ancor prima la rivendicazione del musicologo, o meglio la concessione alla Musikwissenschaft del diritto di dissentire ("piaccia o meno") da tale giudizio, diritto che prevedibilmente essa continuerà ad esercitare energicamente.
Dinnanzi a un universo musicale che ratifica apertamente il capovolgimento di una gerarchia plurisecolare, con la musica popular assurta al ruolo di guida e protagonista della cultura dominante e, di contro, la musica di tradizione colta ridotta ai margini, la saggezza musicologica eurocolta ha accentuato via via un atteggiamento di distacco, ritraendosi con sufficienza, demandando ad altri l'occuparsi di una materia di cui, anche prescindendo da giudizi di valore, non si sente partecipe culturalmente, né ambisce esserlo.
La storia del rapporto fra la musica degli USA e la musica europea, anche se ciò può sembrare paradossale, è forse sintetizzabile in forma di un incrocio fra due strade rettilinee. Dapprima viene la scoperta, quell'avvicinamento curioso, entusiasta da parte dei musicisti europei cui la musica d'oltreoceano si schiude con la fragranza del nuovo, nella quale con una metamorfosi stupefacente nel giro di pochi decenni l'esotico si trasforma in attualità, up to date. Dvorak, Debussy, Ravel, Stravinskij e altri ancora ne sono testimoni direttamente coinvolti.
Ma a frugare fra modalità afroamericane, fra idiomi ritmici (di cui la sincopazione è solo l'accezione più facilmente volgarizzabile in lingua europea), fra accenti, fraseggi, strumentalismo di jazzmen e big band sono francesi, neoclassici o comunque artisti limitrofi, difficilmente Mitteleuropei. L'arcipelago musicale che va delineandosi oltreoceano attira cioè musicisti meno di altri oberati dal peso della storia, dal dovere di berne fino in fondo il calice e più disponibili alla prassi dell'esotismo, del mistilinguismo, dell'imprestito, dell'eclettismo.
Tuttavia c'è una differenza fondamentale nell'appropriazione di certi fonemi nordamericani da parte degli europei, rispetto ad altre parallele metabolizzazioni etnomusicali. In questo caso si producono infatti scimmiottamenti, caricature pallide di un originale del quale si conosce bene il volto, un volto dai tratti alquanto pronunciati. Ciò può funzionare per tratti culturali allogeni con cui non si ha quasi nessun altro tipo di familiarità (dai gamelan, ai primitivismi generici o a periferie di ambito europeo - ritmi bulgari o spagnolismi che siano); con la musica americana viceversa le carte via via si scoprono, poiché dinnanzi al pubblico stanno sia l'originale, sia l'imitazione. E mentre l'originale vince, dilaga, conquista schiere di nuovo pubblico, l'imitazione arretra, diviene anemica.
Proseguendo per la loro direzione le due strade rettilinee, dopo essersi incrociate, si distanziano, com'è ovvio. Il Novecento americano diviene un mondo sempre più eteroclito, all'interno del quale il ruolo accademico della musica di matrice alta-europea appare sempre più marginale e non solo in termini quantitativi, di mercato, bensì di capacità propulsiva, ideatrice. Tutto ciò mentre, al di qua dell'Oceano, in un alveo che è principalmente mitteleuropeo, si elabora via via una nozione di contemporaneità musicale per la quale l'imperativo alla ricerca, la volontà di attingere al nuovo, assume sempre più connotati di antagonismo ideologico, di opposizione programmatica al consumo musicale di massa, a tutto quanto è inscrivibile nella categoria della musica mercificata.
E' un'opposizione che si traduce in un vero processo senza appello alla musica di consumo e nella cui assise il nuovo mondo musicale degli USA, proprio in quanto costituisce indiscutibilmente il nerbo per quantità e modalità di questa produzione musicale, diviene il principale inquisito. Quella voce Stati Uniti, dunque, racchiude in sé anche il senso di un antagonismo, di una vera e propria contesa ideologica al di là della quale non è facile collocarsi nel tentativo di tracciare un quadro sintetico di tutti questi elementi.
La prima fondamentale questione su cui interrogarsi è forse proprio quella dell'eterogeneità: sono davvero così alieni fra loro questi elementi o strati o generi musicali, li si chiami come si vuole, fioriti negli Stati Uniti? Nessuno, neppure in Europa, si sognerebbe di negare la folta rete di rivoli, sotterranei o visibili, che collegano i linguaggi e la prassi di generi musicali tanto diversi fra loro, ma fondati nella maggioranza dei casi sul medesimo sistema musicale tonale. Eppure nella tradizionale prospettiva musicologica questa intercomunicazione di elementi lessicali si riduce a elemento scarsamente pertinente e rispetto ad essa prevalgono decisamente i fattori di separazione su base sociologica o ideologica.
La visione che ne scaturisce teorizza un'eterogeneità che vuole ben distinti sia il quadro sociale, sia gli orizzonti di valori entro cui si muovono o si muovevano, ad esempio Bruce Springsteen e Jimi Hendrix, Charlie Parker e Max Roach, Woody Guthrie e Pete Seeger, Elliott Carter e John Cage, George Gershwin e Leonard Bernstein. Eppure a questa separatezza si oppongono considerazioni tutt'altro che marginali.
Tracciare una linea precisa di demarcazione fra i destinatari di questi diversi generi di produzione musicale è pressoché impossibile. Esistono certo "ascoltatori risentiti," chiamiamoli come li chiamava Adorno, attratti solo ed unicamente da un certo tipo di musica e tendenti a spregiare ciò che non rientra nel loro angolo visuale, ma è senza dubbio più consistente e senza dubbio anche più rilevante socialmente, un pubblico sui cui apparecchi stereo brani dell'uno o dell'altro musicista e appartenenti a generi diversi, si alternano fra loro senza traumi eccessivi, ricondotti ad una generica nozione di musica che si consuma, cioè che si ascolta con motivazioni e atteggiamenti i più diversi.
Così come esistono da decenni artisti border-line, che deviano dai loro percorsi, che saltano da un genere all'altro o si muovono su linee di confine o in senso trasversale ad esse: Scott Joplin, George Gershwin, Leonard Bernstein, Benny Goodman, Bill Evans, Miles Davis, Keith Jarrett, Winton Marsalis, Frank Zappa, Steve Reich, Prince, Laurie Anderson, John Zorn, il Kronos Quartet non sono soltanto una lista di celebrità, sono più appropriatamente alcuni degli artisti - interpreti e autori - per opera dei quali la musica statunitense dell'ultimo secolo ha aggiunto ai tanti motivi di originalità, anche quella fortissima spinta comportamentale a mescolare linguaggi, competenze, generi. Una spinta che nella pratica conduce alla negazione di ogni rigida settorialità del moderno sapere musicale e della pratica a esso connessa.
Rispetto alla concezione musicale eurocolta questa diffusa tendenza di marca tipicamente statunitense costituisce un'antitesi che più netta non potrebbe essere. Se si mira a cogliere le radici dell'alterità fra gli universi musicali europeo e nordamericano, l'interrogarsi sui presupposti e sulle conseguenze di questa realtà è un motivo di riflessione che si presenta assai più sottile, fecondo e spiazzante di quanto non lo sia il soffermarsi partitamente sui tanti e originali contributi musicali vecchi e nuovi che gli USA non cessano di riversare a getto continuo sulla superficie del pianeta.
In altre parole negli USA il comportamento degli artisti, il mercato e persino l'insegnamento universitario, pongono istanze non compatibili con l'impostazione della musicologia sistematica di formazione europea. Il pragmatismo asistematico, il mistilinguismo diffuso e, da ultima ma non ultima, la sperimentazione quasi totalmente sgravata da quelle considerazioni fortemente ideologizzate che occupano invece l'orizzonte delle avanguardie eurocolte, toccano nel vivo e sconvolgono uno dei gangli vitali della concezione musicale del vecchio continente.
Questa, in virtù della sua costituzionale tendenza all'organicità speculativa, all'interpretazione in base a valori di segno storicistico, ha distinto negli ultimi due secoli in maniera sempre più rigida gli ambiti di una Kunstmusik e di una Trivialmusik, di una musica d'arte e di una musica triviale, dove quest'ultima gode di un statuto di inferiorità culturale definito in termini quasi assiomatici. Tale inferiorità, definita in base ad una gerarchia estetica che ha assunto stabilmente come fattori costitutivi dei suoi giudizi di valore, implicazioni etiche e sociali, si fonda essenzialmente sulla categoria della "volgarità," della "banalità," della "falsità," individuata vuoi nei modi della produzione, vuoi nei modi della ricezione.
Il giudizio negativo su quella musica compresa sotto definizioni quali musica pop, leggera, di consumo, Trivialmusik, Gebrauchmusik (musica d'uso) si riassume, dal lato "poietico," in una sua pretesa estraneità-indifferenza-incompetenza nei confronti dello stadio di avanzamento del linguaggio cui è giunta la ricerca musicale contemporanea e per una generalizzabile e preminente attenzione alle ragioni della vendibilità, della mercificazione, da cui deriva la sua ideologia omologabile al sistema del mercato e quindi la falsità della sua eventuale pretesa di proporsi come oggetto portatore di valori estetici autonomi. Dal lato "estesico" essa invece viene qualificata, altrettanto negativamente, per la superficialità della ricezione che essa richiede e auspica, proponendosi come oggetto di un ascolto che si vuole regredito a puro passatempo, affogato nel conformismo, fino a immiserirsi al rango avvilente del prodotto concepito espressamente come confortevole sfondo sonoro, la cosiddetta muzak.
La conclusione di Charles Hamm in base alla quale "il resto del mondo vede in maggioranza la musica leggera e il jazz americani come il prodotto più importante e riuscito del Nuovo Mondo," non può essere schivata da un'impostazione storica e ermeneutica che si liberi da paraocchi ideologici e storicisti e accetti di dar conto dell'esistente. L'esigenza di ricomprendere entro un sistema di gerarchie estetiche l'insieme di questi fenomeni così divaricati, questo panorama creativo così frastagliato è però un'esigenza tipicamente europea. Un'esigenza che avanzando i suoi interrogativi, formulando le sue requisitorie di ordine estetico, in realtà ne scambia i contenuti e ne fonda i giudizi riferendosi a un quadro di natura sostanzialmente etica, manifestando il bisogno di distinguersi, di dissociarsi da questo universo musicale vincente denunciandone la falsità ideologica e rivendicando per sé e per la propria cultura una dignità, una "purezza" che, insieme, funziona anche come l'unico antidoto e giustificazione della più completa impopolarità.
Quel ruolo di opposizione al sistema che la tradizione europea della neue Musik tiene saldamente fermo come articolo centrale del proprio orizzonte storico e artistico, negli USA viene fatto proprio, al contrario, proprio dalle frange più radicali e politicizzate della popular music e del jazz. La spinta alla dissociazione, l'ostilità verso il sistema del consumo si accampa infatti con forza dirompente, abbinandosi di frequente a esplicite connotazioni politiche, proprio in certe avanguardie della Black Music o del rock - questo sia inn USA sia in Europa - ovvero proprio entro i confini di quei campi che la visione colta e europeizzante riconduce comunque entro il regno del consumo musicale.
Eppure questa circostanza mette fortemente in dubbio, e anzi fa sostanzialmente cadere, proprio quel giudizio di falsità ideologica gravante sulla musica formatasi entro la cerchia massmediale. E,' viceversa, indiscutibile il fatto che proprio certe parti di questa musica sono quelle che si caricano più apertamente delle espressioni di protesta o di rivolta proprie dalle subculture o dalle realtà di emarginazione. In altre parole, da questo punto di vista è innegabile che questa musica, sia una delle più "vere" del nostro tempo.
Nella cultura musicale statunitense, l'esigenza del distinguersi, del tenersi a distanza, sotto la bandiera della "ricerca," dalla lingua "svilita" del consumo musicale gode tradizionalmente di ben scarsa considerazione, contrariamente a quanto accade in Europa dove questo genere di distinguo è fortemente avvertito. Le ricorrenti perplessità, l'abituale tono di sufficienza che caratterizzano i giudizi critici formulati in ambiente europeo nei confronti dei più celebri compositori americani che attingono variamente all'area colta - da Gershwin, a Copland, a Bernstein - sono proprio legate alla constatazione del loro intrattenere rapporti troppo pacificati e confidenziali col linguaggio del mondo musicale mercificato, con l'etica svilente del mercato.
In un certo senso la categoria così empirica e provvisoria della "contaminazione," del "disinvolto eclettismo stilistico" è l'unica elementare e inflazionata risposta-lettura che all'insieme di questi fenomeni è stata data in sede critica secondo l'impostazione di pensiero europea. E non è un caso che il termine "contaminazione" rechi in sé un significato di impurità corruttrice. A una cultura musicale che non possiede una nozione di storia stilistica così forte e radicata come la plurisecolare tradizione europea, è invece estranea questa accezione negativa della contaminazione, mentre vi predomina una prassi di esperienza musicale pratica e di scrittura che opera all'interno di un sentimento di appartenenza, in vista di una appropriazione e di una conoscenza, nella prospettiva cioè di un accorpamento, di un avvicinamento, di un'identificazione, anziché nella prospettiva di una dissociazione o di una manipolazione straniante, sorretta da quell'idea-sfondo della crisi culturale europea che è l'alienazione delle coscienze.
Un possibile fulcro interpretativo è individuabile proprio in Charles Edward Ives, una delle pochissime figure di compositore USA che anche gli europei indicano come un precursore della neue Musik, fraintendendo per altro totalmente il senso del suo agire, un agire nel quale, viceversa, può essere individuata una strada in buona parte antitetica all'avanguardia e alla sperimentazione contemporanee. In Ives - che viene chiamato in causa ogni qual volta si vuole indicare un solitario precursore delle ricerche musicali più avanzate sul linguaggio, sulla "spazialità" del suono, sull'utilizzo di materiali "esauriti" eccetera - la sperimentazione, indubbiamente avanzatissima per i suoi tempi, si fonda su presupposti totalmente estranei a quell'idea di superamento o di azzeramento di una tradizione esaurita e a quell'antagonismo intriso di disprezzo per il consumo musicale che guida il radicalismo musicale europeo di questo secolo.
Le bizzarre sperimentazioni di Ives, guidate, come ha scritto Wilfrid Mellers, da una fondamentale innocenza di spirito e dal "coraggio del pioniere¯" - cioè da un individualismo che però non è mai disgiunto da un profondo senso di responsabilità morale e di rispetto nei confronti della comunità - hanno sempre come punto di partenza e come punto d'arrivo la musica della sua provincia americana, il "paesaggio sonoro" della sua vita quotidiana. etti veri di un modo di vivere. Inoltre la distanza di questa musica dalla convenzione accademica stimolava l'immaginazione uditiva".
Lo psicologismo ipersensibile e allucinato, il senso di alienazione, il conflitto con il milieu filisteo, tratti che segnano e condizionano profondamente il processo creativo dell'avanguardia europea nel suo complesso, non solo sono completamente assenti in Ives, ma sono ribaltati in un atteggiamento che attinge al materiale musicale e sonoro circostante individuando in esso un patrimonio di cui appropriarsi e da elaborare individualmente, lasciandosi andare ad una sperimentazione che, per quanto spericolata e deformante, ha come suo sfondo un costante realismo poetico, un'accezione particolarissima di illustratività pittorica (ben altra, comunque, rispetto all'impressionismo) che mentre trasforma e travolge il linguaggio tradizionale, preserva la riconoscibilità, l'immediatezza del segno e del messaggio.
E' un atteggiamento sicuramente antiaccademico, tenendo conto però che per Ives l'accademismo più insidioso si identifica con le propaggini, anche le più avanzate, della temperie tardoromantica e del primo Novecento. La sua ricerca è frutto di un atteggiamento ingenuo, "grezzo" se si vuole, nel quale però il rapporto con i materiali utilizzati è un rapporto vitale, affettivo, dominato appunto da un senso di appartenenza, anziché di alienazione.
A ciò si aggiunge un dato biografico che è al tempo stesso una dichiarazione di poetica: com'è noto la professione di Ives fu quella dell'assicuratore e la scelta di svolgere la propria attività di compositore in forma amatoriale, nel tempo libero, mirava a svincolare la sua musica da ogni impegno e condizionamento di carattere professionale. Perfettamente consapevole del fatto che le sue composizioni musicali possedevano uno scarsissimo valore d'uso, alcun carattere di funzionalità sociale, Ives, pur adoperandosi sempre per far eseguire le proprie musiche, non si pose per questo in conflitto con l'ambiente culturale, né teorizzò il carattere reazionario e filisteo del gusto musicale dominante per il fatto che esso non si adeguava all'orizzonte estetico espresso nelle sue opere. Questo suo modus operandi indica una sostanziale e irriducibile alterità rispetto al pensiero musicale ed estetico europeo.
All'artista che vuole sperimentare liberamente, Ives sembra indicare la condizione di isolamento come una conseguenza scontata, in quanto, pragmaticamente, viene riconosciuto il diritto di esistenza alla tradizione musicale, alle tante musiche che non sono né sperimentali, né innovative e che formano il corpo del gusto predominante. Anzi, queste musiche vengono sentite come il sostrato necessario al musicista, come il nutrimento di una creatività che implicitamente le valorizza come componente essenziale della propria cultura di riferimento, anziché mirare alla loro distruzione in quanto regressive o addirittura reazionarie.
E' questo il fondamento di quella fusione, altrimenti improponibile, fra realismo estetico e sperimentalismo cui Ives approda, trasformando le sue svariate esperienze atonali, sui quarti di tono, sui poliritmi e quant'altro, in mezzi di poetizzazione del reale, anziché in ricerche accademiche finalizzate unicamente a nuovi linguaggi. Nessun linguaggio, nessun procedimento per Ives reca in sé qualche intrinseca "veridicità" fondata su base storica o stilistica: per lui "ciò che è buono" invece è sempre una pura constatazione empirica, è un giudizio formulato sulla base di un obiettivo poetico raggiunto.
Più che singolare, la coincidenza dell'atteggiamento di Ives con quello di un compositore come Frank Zappa, è estremamente eloquente. Col suo linguaggio hard, intriso di un dadaismo perforante, Zappa fornisce le seguenti istruzioni a chi vuole fare il compositore:
1) Dichiarate la vostra intenzione di creare una composizione.
2) A UN CERTO PUNTO INIZIATE un brano.
3) Fate SUCCEDERE QUALCOSA PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO (non conta quel che accadrà nel vostro buco temporale, ci sono i critici che ci diranno se va bene o meno. Non è cosa di cui dobbiamo angustiarci).
4) A UN CERTO PUNTO FATE FINIRE IL BRANO (o fatelo andare avanti dicendo al pubblico che è un work in progress).
5) Trovatevi un lavoro part-time per poter continuare a fare roba del genere.
E' certo azzardato proporre Ives come modello generalizzabile, eppure la sua poetica evidenzia alcuni elementi fondamentali che restano alla base della concezione profonda della musica americana del nostro tempo, una concezione genericamente progressista che è rintracciabile non solo nella musica di estrazione colta, ma anche nella maggior parte dei generi in cui si sono espresse le istanze delle numerose sottoculture che formano il complesso amalgama nordamericano. Istanze che come spesso succede, quando sono fortemente antagonistiche e critiche dell'establishment musicale, lo sono in quanto radicate in un gruppo, in una realtà culturale - emarginata o maciullata quanto si vuole - di cui vogliono essere espressione. In tal caso però il ripudio, lo sfregio al linguaggio musicale di successo diviene una trasparente metonimia in cui si legge l'attacco al sistema sociale vigente.
Al di là dell'efficienza dei sistemi di produzione e di distribuzione, la forza d'urto che le musiche di provenienza nordamericana hanno su scala planetaria - siano gli Evergreens di Tin Pan Alley, il Be-Bop, Elvis Presley, le provocazioni di Cage, West Side Story, la Soul Music o il Rap - risiede probabilmente nel suo conservare e restituire comunque certi tratti della propria etnìa originaria, qualcosa che, anche una volta svanita la moda, permane nella veste di Graffiti. Con diverse intenzioni il New Dada, la Pop Art, l'iperrealismo segnano certamente il culmine paradossale e corrotto di questo processo di identificazione, con il parossistico figurativismo tridimensionale degli hamburger di Claes Oldenburg, dei manichini di George Segal o di Duane Hanson, ma anche con le bandiere Star and stripes di Jasper Johns e, naturalmente con gli Imaginary Landscapes e le tante altre trovate di Cage. Se Steve Reich può scrivere che "in fin dei conti ogni musica è una musica etnica" è perché vive immerso in questo universo multiculturale in cui anche le espressioni più trasgressive serbano in mille modi la traccia dell'identità originaria.
Ma l'antitesi all'universo anche artisticamente tecnologizzato degli USA non è rappresentata dal Terzo Mondo o dall'emisfero meridionale. L'antitesi è proprio la vecchia Europa che nel suo accademismo cosmopolita e autorigenerantesi in veste di avanguardia, ha da tempo scambiato i valori della propria etnìa con quelli dell'ideologia e della storia. Nel nostro (nostro in quanto europei) e inevitabile (inevitabile in quanto nutriti di pensiero dialettico e storicista) fraintendimento dello sperimentalismo di Ives è inscritto il fraintendimento degli sperimentalismi futuri, da Edgar Varèse a Charlie Parker, John Cage, Conlon Nancarrow, Ornette Coleman, Steve Reich, Frank Zappa. Ma è inscritta anche la svalutazione aprioristica dei tanti che dalla nostra prospettiva, impossibilitati come siamo a concepire la sperimentazione e l'innovazione sotto forma di rilettura del già esistente, di empirismo polistilista, giudichiamo eclettici o contaminatori.
Della sperimentazione pionieristica, autori come Gershwin, Bernstein, Miles Davis, Bill Frisell non solo condividono la libertà di movimento a 360 gradi, ma soprattutto convivono con essa in regime di organico arricchimento reciproco, un regime dove, inversamente a quanto accade sulla sponda destra dell'Oceano, la ricerca del nuovo non risponde necessariamente al codice di superamento-obliterazione già fissato da Hegel nell'Aufhebung dialettica, ma si risolve in una serie di opzioni possibili, affiancabili, combinabili e intercambiabili.
La lingua straordinariamente versatile di un autore come Leonard Bernstein, il suo atteggiamento di totale, apertissima curiosità intellettuale, ma, al tempo stesso, le insormontabili perplessità e idiosincrasie che egli suscita in molti critici al di qua dell'Oceano, si possono comprendere a fondo solo se si riflette su quanto diverso sia lo sfondo di pensiero e di prassi che caratterizza questi due mondi.
Nel 1970 in un articolo intitolato Qualche predizione ottimista sull'avvenire della musica, Steve Reich scriveva:
Sarà la musica non occidentale in generale e in particolare le musiche africane, indonesiane e indiane a fornire nuovi modelli strutturali ai musicisti occidentali. Ma esse non costituiranno tanto dei nuovi modelli sonori (il vecchio fantasma dell'esotismo!). Bisogna sperare piuttosto che coloro di noi che si innamorano dei suoni prodotti da queste musiche imparino semplicemente a eseguirli.
E' precisamente quello che il musicista europeo non fa. Laddove il musicista americano tende a incorporare nel suo lessico il Nuovo e il Diverso prima di tutto come prassi esecutiva, a considerare l'apprendimento come condizione prima della creatività, il musicista europeo vede in essi prima di tutto un problema teorico, da sottoporre a critica e ad analisi. L'Europa disseziona e scarta, gli USA apprendono e accumulano. Forse in termini musicali la differenza tra Vecchio e Nuovo Mondo non può ridursi soltanto a questa, ma, comunque sia, si tratta già di una differenza gigantesca.
Foto di Steve Groer (Zappa), Paul de Hauck (Bernstein).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.