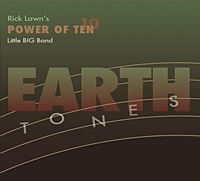Home » Articoli » Lyrics » Suoni (e parole) di un decennio nato settimino – terza parte
Suoni (e parole) di un decennio nato settimino – terza parte
In parallelo a lavori come Fabbrica occupata, Colloquio con Malcolm X, Concerto della Resistenza, Murales, Graffiti, ecc., Giorgio Gaslini persegue con forza il suo pallino per la "musica totale" (il libro omonimo esce per Feltrinelli nel '75), suona ovunque ci sia bisogno di musica non supina (università, fabbriche, carceri, manicomi) e - forse soprattutto - porta per primo il jazz in conservatorio: nel 1972 viene infatti chiamato a Santa Cecilia, a Roma, a tenere il primo corso di jazz. La cosa durerà un solo anno accademico, ma lascerà tracce incancellabili: da lì nasce di fatto la Scuola del Testaccio, dove operano, insegnanti e/o allievi (spesso tutte e due le cose), i vari Bruno Tommaso (primo ideatore del progetto, oltre che bassista di Gaslini), Giancarlo Schiaffini, Michele Jannaccone ed Eugenio Colombo (riuniti nel trio SIC), Martin Joseph, Maurizio Giammarco, lo stesso Massimo Urbani, che Gaslini inserisce quindicenne nei suoi workshop. Qui, attorno a Colombo (e a Tommaso Vittorini), nascono i Virtuosi di Cave, primo gruppo italiano di soli sassofoni (sempre Colombo formerà poi i Fratelli Sax). Qui viene accolta (caldamente invitata, anzi) Giovanna Marini, a insegnare canto popolare [Nota 1]. Sempre nei gruppi di Gaslini si affacciano alla grande ribalta Andrea Centazzo, Gianluigi Trovesi e Paolo Damiani, mentre Franco D'Andrea, uscito dall'esperienza del Perigeo, si guarda dentro, maturando nuove certezze che ne faranno di lì a poco uno dei fari del nostro jazz. Enrico Rava torna in Italia dopo gli anni-chiave trascorsi in America. E ci sono poi Guido Mazzon (E ora parliamo di libertà, 1974; Ecologia, ecologia, '75), Gaetano Liguori (Cile libero Cile rosso, 1974; Cantata rossa per Tall El Zaatar, '76), l'OMCI di Rusconi e Geremia, i Cadmo di Antonello Salis, l'Art Studio, ecc.
Cantautori, "eletta schiera"
I titoli degli album appena citati evidenziano come un diffuso didascalismo - scopertamente militante, spesso - permeasse il jazz italiano degli anni Settanta. Il vertice di tale piramide non poteva che coincidere col movimento cantautoriale, che il decennio in oggetto ha rivestito di una specificità fortissima (e viceversa), come mai prima né dopo (anche se, per esiti formali, gli anni Ottanta non sono probabilmente da meno). Ciò, essenzialmente, per un motivo fin troppo evidente: la presenza della parola, posta sullo stesso piano della musica (quanto meno). Abbiamo già individuato, in apertura, in Fabrizio De André e Francesco Guccini gli artisti-simbolo del decennio: perché in esso trovano la definitiva consacrazione, perché vengono da lontano, perché fungono da traino per tutta una schiera di più giovani colleghi, più o meno orientati su analoghe lunghezze d'onda. De André, dopo la già menzionata Buona novella, sforna un paio di capolavori: nel 1971 Non al denaro non all'amore né al cielo, tratto com'è noto dall'Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, nel '73 Storia di un impiegato, album largamente sottovalutato (dallo stesso autore, fra l'altro) in quanto sostanzialmente frainteso. In entrambi De André si avvale del supporto di Giuseppe Bentivoglio per i testi e di Nicola Piovani per le musiche. Il successivo Vol. 8 (1975) vede invece l'intervento, massiccio, di Francesco De Gregori, anche se poi, di fatto, i due capolavori coincidono con le due canzoni del solo Fabrizio: "Giugno '73" e "Amico fragile". E' quindi l'ora di Massimo Bubola, che collabora (eufemisticamente, verrebbe da dire, perché in realtà il grosso del lavoro lo fa lui) a due album. Il primo è Rimini (1978), dopodiché De André si unisce alla PFM in un tour destinato a lasciare il segno (anche in un doppio LP), poco prima di esser rapito con Dori Ghezzi (agosto '79). Le scorie di quella brutta esperienza - parecchio sublimata, in verità - convoglieranno nell'81 nel secondo LP dell'era Bubola, il famoso Indiano (in realtà senza titolo). Guccini, per parte sua, fra 1972 e '78 pubblica a scadenza biennale quattro lavori che costituiscono il cuore della sua migliore stagione: Radici, Stanze di vita quotidiana (talora sottovalutato, mentre è album di rara unitarietà, oltre a contenere almeno due capolavori, "Canzone per Piero" e "Canzone delle osterie di Fuoriporta"), Via Paolo Fabbri 43 (con la celebre "Avvelenata," in tempi successivi quasi "sconfessata" dall'autore, mentre rimane una pagina fondamentale di un fermento - anche barricadero, se vogliamo - così tipico dell'epoca) e Amerigo.
Altri due coetanei (1943, qui, come per De André e Guccini era il 1940) raggiungono verso metà anni Settanta una loro consacrazione, pur di diversa natura. Il primo è Lucio Dalla, attivo da tempo, che dopo due ottimi Sanremo (1971 con "4/3/43" e '72 con "Piazza Grande") giunge a un'invidiabile epifania espressiva in tre consecutivi album su testi del poeta Roberto Roversi, Il giorno aveva cinque teste, del '73, Anidride solforosa (il migliore) del '75, e Automobili, del '76 [Nota 2], anche se il grande, definitivo successo arriverà fra 1977 e '79 con gli album Com'è profondo il mare (il primo con testi interamente suoi) e Lucio Dalla, nonché col tour di Banana Republic in coppia con De Gregori. Il secondo è Roberto Vecchioni, per anni limitatosi al ruolo di autore (nell'omofono, curioso binomio con Lo Vecchio), finché nel '71 debutta a sua volta anche come interprete: quattro dischi (la prolificità già non faceva difetto al "professore") in tre anni, una visibilità invero piuttosto modesta, poi, nel '75, il boom, con Ipertensione, che apre una cinquina di lavori in cui trova posto quasi tutto il meglio della sua produzione (ma non "Luci a San Siro," presente già nell'iniziale Parabola). Dal '76 al '79 seguiranno infatti Elisir (il più completo), Samarcanda, Calabuig e Robinson. Poi, con gli anni Ottanta, la flessione, rotta solo qua e là da qualche ulteriore colpo d'ala (su tutti Il cielo capovolto, del '95).
Intorno a metà anni Settanta, del resto, il terreno, per la figura del cantautore, è quanto mai fertile. Si afferma così tutta una schiera di artisti più giovani, nati intorno al 1950, che pure - come appunto Vecchioni - già hanno alle spalle precedenti lavori, per lo più beatamente ignorati. Si chiamano Francesco De Gregori (Rimmel, 1975), Antonello Venditti (Lilly, idem), Edoardo Bennato (La torre di Babele, 1976), Angelo Branduardi (Alla fiera dell'est, idem), Rino Gaetano (Mio fratello è figlio unico, idem), Eugenio Finardi (Diesel, 1977). Alcuni di loro percorreranno poi carriere particolarmente luminose. De Gregori, in primis, è a tutt'oggi uno dei prototipi stessi del cantautore. E ai tempi di Rimmel già aveva prodotto, nel '73/74, due LP dell'importanza - ce ne saremmo accorti dopo - di Alice non lo sa ("Alice," "1940," "La casa di Hilde," "Saigon") e la celebre Pecora ("Niente da capire," "Cercando un altro Egitto," "Giorno di pioggia," "Bene," "Souvenir"), al di là di Theorius Campus ('72), in coppia con Venditti. Che ne ebbe i maggiori benefici. E firmò pure album non peregrini (in particolare Le cose della vita, con "Mio padre ha un buco in gola," e Quando verrà Natale, con "A Cristo," "Marta," "Campo de' Fiori," la titletrack), prima di virare - dopo un altro lavoro degno di nota, Ullalla (1976) - verso lidi decisamente più nazionalpopolari. Fra prima e dopo (l'acquisita notorietà), di Bennato vanno ricordati, fra '73 e '75, Non farti cadere le braccia ("Un giorno credi," la titletrack), I buoni e i cattivi (su tutto "In fila per tre") e Io che non sono l'imperatore ("Signor censore," "Affacciati affacciati," ecc.), nonché la consacrazione con il concept album Burattino senza fili (1977); di Branduardi La luna ('75), soprattutto per "Confessioni di un malandrino," da Esenin, e il rinnovato successo con La pulce d'acqua ('77) e Cogli la prima mela ('79); di Finardi Sugo ('76), con "Musica ribelle," e poi Blitz ('78), con "Extraterrestre," e Roccando rollando ('79), ultimo di cinque LP con la Cramps [Nota 3]. Per parte sua Rino Gaetano, dopo averci regalato canzoni divenute nel tempo autentici evergreen ("Il cielo è sempre più blu," "Aida," "Berta filava," "Nuntereggae più"), il 2 giugno 1981, all'indomani della sua partecipazione (decisamente ardita) al Pinocchio di Carmelo Bene, perde la vita in un incidente stradale. E qualcuno ricorda quanto accaduto vent'anni prima a un altro outsider di talento, tale Ferdinando "Fred" Buscaglione.
Un elemento che accomuna diversi dei succitati, è - molto nel dettaglio, per carità, ma emblematico - il fatto che s'inizino a scrivere canzoni sulla "nuova professione". Quella di cantautore, appunto. L'occhio è per lo più disincantato, ironico, spesso (auto)parodistico. Ma se Bennato, in "Cantautore," ne fa una questione globale ("tu sei perfetto/ tu non hai un difetto"), altri sembrano chiamarsi fuori. Così Guccini - toccando un altro tasto comune, quello della "svendita," della venalità - nella già citata "Avvelenata" parla di "colleghi cantautori eletta schiera/ che si vende ogni sera/ per un po' di milioni"; così, analogamente, in "Pesci nelle orecchie" Vecchioni si rivolge senza mezzi termini a un "amico mio di vino di canzoni e grandi alibi/ amico pronto fatto e poi fumato sopra i tavoli/ tu che sei tanto bravo, che alzi il pugno e fai l'anarchico/ insegnami a cantare come canti tu/ mezzo milione a sera o perdi la virtù". E più d'uno ne coglie il destinatario proprio in Guccini (tutto lo lascerebbe intendere); senonché, nel disco successivo (Elisir), il milanese dedica al collega bolognese la bellissima, per più versi tenera, "Canzone per Francesco". Non evitando di arricchire il filone, nell'ancora successivo Samarcanda, con "Vaudeville" ("E spararono al cantautore/ in una notte di gioventù/ gli spararono per amore/ per non farlo cantare più/ gli spararono perché era bello/ ricordarselo com'era prima/ alternativo, autoridotto/ fuori dall'ottica del sistema"). Fra dirimpettai, i messaggi più o meno in codice, del resto, sono agevoli. E così pure gli equivoci, tipo quello secondo cui tra gli ex-gemelli De Gregori (che, fra due album notevoli quali Bufalo Bill e De Gregori, il suo bravo processo - pubblico - per "asservimento al sistema" lo subisce davvero, nel '76 al Palalido di Milano) e Venditti sarebbe corso, a distanza di qualche mese, un neanche troppo velato botta e risposta, fra "Piano bar" del primo (in Rimmel) e "Penna a sfera" del secondo (in Lilly). Una leggenda metropolitana come tante, peraltro non senza elementi (testuali e biografici) ad avvallarla. Pacifico è invece il riferimento che ancora Guccini indirizza a De André in "Via Paolo Fabbri 43" (la singola canzone), dove dice che "ad un summit per il canto popolare/ Marinella non c'era/ fa la vita in balera," riferendosi palesemente al fatto che il collega, dopo annosi dinieghi, nel marzo '75 si è infine piegato a esibirsi dal vivo, scegliendo - guarda un po' - la Bussola di Viareggio (e qualcuno, riprendendo il titolo di uno dei suoi ultimi brani - in realtà di De Gregori - titolava il commento La cattiva strada).
Altri costituiscono dei casi per un verso o per l'altro anomali. Ne scegliamo due. Il primo è Claudio Lolli, che appartiene alla generazione dei Bennato e De Gregori (è esattamente del '50), ma trova un suo seguito fin dal debutto, nel '72 con Aspettando Godot, del resto opera prima tra le più folgoranti dell'intera storia cantautoriale. Negli anni che seguono, Lolli, bolognese come Guccini, di cui è amico e in qualche misura seguace (però con una cifra più tormentata, per certi versi più profonda), snocciola altri due album che vanno a formare un trittico assolutamente esemplare (Un uomo in crisi, nel '73, e Canzoni di rabbia, nel '75), per sposare in seguito, a partire da Ho visto anche degli zingari felici (1976), un'ispirazione in qualche modo più "ecumenica" (del resto annunciata fin dal lato B di Canzoni di rabbia, sottotitolato La rabbia lucida - di contro alla Rabbia solitaria del lato A - in particolare con la straordinaria "Compagni a venire"), più aperta sull'esterno. Il risultato, paradossalmente, sarà quello di perdere via via mordente, e pubblico (mai oceanico, ma molto fedele), fino a una piuttosto tribolata rentrée, però ormai fuori dai grandi circuiti. Il secondo caso riguarda Franco Battiato, di cinque anni più âgé, che dopo un precoce debutto canzonettaro, dal '71 sforna uno dietro l'altro album schiettamente sperimentali che neppure ne giustificherebbero l'inclusione in questo paragrafo. Titoli come Fetus, Pollution, Sulle corde di Aries, Clic, M.elle le Gladiator, tutti racchiusi nel quinquennio '71/75, sono infatti "altra" cosa. Il grande successo conosciuto a partire dagli anni Ottanta ce li fa leggere oggi come l'incipit di una parabola creativa sostanzialmente a sé.
Altri fenomeni, presentatisi in punta di decennio, meritano una veloce disamina. Il primo è Pierangelo Bertoli da Sassuolo, cui la concittadina Caterina Caselli, nel '76, produce il primo album non "semiclandestino," Eppure soffia, lui ormai trentaquattrenne. La piena consacrazione arriva però solo tre anni dopo, con A muso duro, dal titolo di quella che rimarrà la sua canzone-manifesto: "canterò le mie canzoni per la strada/ ed affronterò la vita a muso duro/ un guerriero senza patria e senza spada/ con un piede nel passato/ e lo sguardo dritto e aperto nel futuro". La sua parabola si svolge tutta in questa direzione. C'è poi Paolo Conte, autore abbastanza di lungo corso (e successo), a cui nel '74, un po' per caso, viene pubblicata una serie di provini. E' il suo primo album (lui di anni ne ha trentasette), che non manca di colpire alcuni intenditori, primo fra tutti Amilcare Rambaldi, patron del Premio Tenco, alla cui terza edizione, nel '76, Conte tiene il suo primo concerto. L'escalation è piuttosto lenta ma inarrestabile, una sorta di crescendo wagneriano che ha il primo acuto nel '79 con Un gelato al limon, e fa dell'avvocato astigiano l'autentico dominatore (anche in quanto a influenza su tanti più giovani colleghi, su un terreno che recupera atmosfere ben poco cantautoriali, danzanti, sensuali, ampiamente allusive, e magari elusive) del decennio seguente. Nel quale si tuffa a pesce un altro fenomeno di fine anni Settanta, lui giovanissimo, Pino Daniele, che col suo melting pot anglo-italo-partenopeo (e musicale, fra cantautorato, jazz-blues e afrori popolari), conquista in un amen un suo altare personale, da Terra mia (1977), che contiene già un paio di capolavori ("Napule è" e - appunto - "Terra mia"), in avanti.
A voler scegliere tuttavia, in chiusura, una figura, una sola, paradigmatica dell'intero decennio, opteremmo per Giorgio Gaber, i cui anni Settanta si fissano come una monade nella storia della nostra canzone d'autore. E' proprio nel 1970, infatti, che, dopo anni anche piuttosto disimpegnati, durante i quali ha fatto comunque i conti col famigerato show business (quattro Sanremo, per esempio), Gaber, reduce da un felice tour con Mina, taglia di netto i ponti col passato, creando il Signor G e la sua grande stagione teatrale. Gli spettacoli, regolarmente documentati da LP doppi (per lo più live), s'intitolano appunto Il Signor G (1970), Dialogo fra un impegnato e un non so ('72), Far finta di essere sani ('73), Anche per oggi non si vola ('74), Libertà obbligatoria ('76), Polli di allevamento ('78). Ci sono poi un paio di album a sé (non a caso singoli): Sexus et politica, del '70, a quattro mani con Virgilio Savona, e I borghesi, del '71, fra l'altro con tre riprese da Brel, sicuro modello di riferimento per Gaber. Che si è fatto ora fustigatore lucidissimo e impietoso di ogni malcostume, pratico e mentale, di un'Italia (e non solo) in rapido mutamento. Le sue posizioni sono nette, spesso impopolari. Gli capita così di scontentare qualcuno, anche fra quanti affollano i suoi récital. Accade soprattutto in Polli di allevamento, che gli provoca sonore, talora violente, contestazioni ("Quando è moda è moda" è un anatema di sette minuti contro tutto e tutti, contro ogni ipocrisia, retorica o conformismo, peggio se camuffato). Il signor G si prende così una pausa di riflessione, e abbandona le scene. Per un paio di stagioni, non di più. Il suo "gemello" Jannacci, frattanto, pur seguitando a incidere (citiamo almeno Quelli che..., del '75, con la celebre "Vincenzina e la fabbrica," "El me indiriss," e i monologhi - un po' alla Gaber, già - "La televisiun" e "Quelli che...," poi ripetutamente aggiornato), è un po' un fantasma, come presenza, causa il rinnovato impegno sul fronte medico (per specializzarsi sta a lungo anche in America).
Fratelli, zii, cugini e parenti tutti
L'America, già. Partiamo da quella del Sud, dove i Settanta sono anni duri, anni di golpe e dittature. In Brasile tutto ciò è merce comune fin dal '64, il che spinge uno come Chico Buarque de Hollanda, arrestato nel '68, ad autoesiliarsi proprio in Italia, decidendo congiuntamente di interrompere l'attività live finché la dittatura non cadrà. In Italia sono di casa anche altri brasiliani, tipo Vinicius de Moraes, mentre Caetano Veloso e Gilberto Gil hanno scelto Londra. Da noi trovano poi asilo numerosi esuli cileni - in primis i celeberrimi Inti Illimani - invisi (eufemisticamente) al regime di Pinochet, insediatosi nel '73. L'11 settembre, per l'esattezza (data evidentemente infausta già prima delle Twin Towers): appena cinque giorni dopo il cantautore Victor Jara, attivista comunista, viene assassinato. Isabel Parra, figlia di Violeta (sua "Gracias a la vida"), ripara in Francia, e molte altre delle "migliori menti" cilene non possono che seguirne l'esempio. In Argentina il giro di vite data 1976. Lì rifulge ancora il mito di Atahualpa Yupanqui, all'epoca quasi settantenne (nell'80 sarà Premio Tenco, con la consegna corredata da un'esibizione solitaria rimasta memorabile), ma già brilla da tempo la stella di Mercedes Sosa - lei pure Premio Tenco, nel '99, come del resto, negli anni, Chico, Vinicius, Veloso, Gil [Nota 4] - che fra il '79 e l'82, ovviamente sempre per motivi politici, è esule prima a Parigi e poi a Madrid.
Se fra i cubani vanno ricordati almeno Silvio Rodriguez e Pablo Milanés, in Nord America, specificatamente negli Stati Uniti, il mito è indiscutibilmente Bob Dylan, i cui Seventies si presentano peraltro alquanto tribolati, tra frizioni con la critica, accuse di fondamentalismo ebraico e un certo regresso ispirativo. Da ricordare, comunque, almeno la partecipazione, nel '72, al film Pat Garrett & Billy the Kid, come attore e autore del soundtrack, in cui compare uno dei capolavori dylaniani per eccellenza, "Knockin' on Heaven's Door". E' spuntata frattanto, tardiva quanto luminosa, la stella di Leonard Cohen (in realtà canadese, come del resto Joni Mitchell, che nel '79 chiude un decennio fitto di album importanti - primo fra tutti Hejira, del '76 - con Mingus, dedicato al grande bassista, appena scomparso). Di cui iniziano a diffondersi i primi brani-cult ("Suzanne," "Nancy," "Joanne of Arc," ecc.). Cinque LP, per lui, negli anni Settanta, fra cui il primo dal vivo, Live Songs (1973). Più sommessamente, inizia a imporsi anche il talento di Randy Newman (Little Criminals del '77, in particolare) e quello - invece straripante, sulfureo, luciferino - di Tom Waits (uno all'anno fra 1974 e '76, The Heart of Saturday Night, il doppio live Nighthawks at the Diner, Small Change, e soprattutto Blue Valentine, del '78), col suo personalissimo cocktail di blues, song e cascami post-beat generation. Fra le signore, infine, non possiamo non citare Patti Smith (fin dall'opera prima Horses, del '75, e poi almeno Wave, del '79), altrimenti detta "la sacerdotessa del rock".
Negli States si affermano anche, fin dai primi anni Settanta, figure particolari, vagamente inquietanti, come Alice Cooper o lo stesso Lou Reed (ex-Velvet Undergroud), che fanno di una spettacolarità aggressiva, fisica, un elemento portante della loro proposta, talora ricorrendo al travestitismo (Cooper, quanto meno), pratica che trova il suo apice nell'inglese David Bowie (che in particolare da Reed si dichiara esplicitamente influenzato), nonché nel nostro Renato Zero. Sembra una moda più che altro, anche se non mancano connotati espressivi forti. Nell'Inghilterra di Bowie, peraltro, la frangia solistica di maggiore spessore passa per altre latitudini: i Gabriel, gli Sting, i Byrne, e tutti i nomi già fatti trattando i loro gruppi di provenienza. Sul finire del decennio, in piena punk-era, sale poi alla ribalta l'artista english più interessante - il più creativo, specie a lunga gittata - in chiave cantautoriale: Elvis Costello. Fattosi le ossa scimmiottando questo e quello in giro per i pub londinesi, il giovanotto si dota di un bagaglio impressionante, che gli tornerà utile una volta trovata una propria via (debutta nel '77 con My Aim Is True), sorta - per certi versi - di Waits britannico, con un'analoga propensione, all'inizio celata, per un lirismo anche struggente, benché mosso da tutt'altro demone.
La Francia, per parte sua, continua a vivere nel cono di luce dei suoi patriarchi, ai quali non s'intravvedono alternative reali. Brel, peraltro, ha abbandonato le scene fin dal '67, per dedicarsi al teatro (dov'è fra l'altro Don Chisciotte) e al cinema (come regista, in Franz e Far West, e interprete), e salpare poi per il suo buen retiro a Hiva-Oa, come Gauguin. Rientrerà nel '77, a regalarci un ultimo capolavoro, semplicemente Brel. Brassens prosegue con gli ultimi due dei suoi album "numerici". Sempre in compagnia di chitarra acustica (una o due) e contrabbasso, con cui ha costruito tutta la sua arte. Nel '79, peraltro, accetta l'invito di Moustache e dà il suo imprimatur (partecipandovi) alla registrazione di Brassens en jazz, mise strumentale di svariati suoi pezzi da novanta ("La femme d'Hector," "Chanson pour l'auvergnat," "Le pornographe," "Les copains d'abord," "La non-demande en mariage," ecc.) con gente del calibro di Harry Edison, Cat Anderson, Joe Newman, Eddie Davis. Léo Ferré vive da noi, a Castellina in Chianti, e pur essendo il più in età, è anche di gran lunga il più attivo dei tre: si produce senza risparmio dal vivo, e solo in questo decennio pubblica la bellezza di quattordici LP ufficiali. Fra essi un live all'Olympia nel '72, Seul en scène, titolo che è un po' l'epigrafe di un'intera carriera.
Parecchio "francese" è uno degli outsiders di lusso del panorama continentale, il turco Zürfü Livaneli, compositore abilissimo a sposare l'opulenza, timbrica e ritmica, tipica della sua musica d'origine con un aplomb, una compostezza, un rigore, appunto, molto francesi (non solo, ovviamente). Altrettanto marginale di quella turca - in termini etnici, non certo qualitativi - è la realtà catalana, che ha saputo per contro esprimere personalità di grande spessore sia prima che dopo la caduta di Franco (1973), dal capostipite Joan Manuel Serrat, autore di brani ben noti anche da noi come "Mediterraneo" (portato al successo da Gino Paoli) e "La tieta" ("Bugiardo e incosciente," per Mina e Vanoni, "La ziatta," in modenese, per e da Guccini), a Lluis Llach, più di matrice popolare, da Pi de la Serra a Maria del Mar Bonet, al più giovane Joan Isaac, in altre parole tutta una schiera di autori e interpreti capaci di imporsi proprio come fenomeno globale, come scuola: la Nova Cançò [Nota 5]. Fra gli spagnoli castigliani, invece, va citato almeno Luis Eduardo Aute, peraltro nato a Manila da padre a sua volta catalano. Al di là del Mediterraneo, l'Africa è per parte sua continente troppo vasto e composito perché se ne possa anche solo abbozzare una mappa musicale. Volendo fare comunque qualche nome, citeremmo anzitutto, anche per la costante lotta contro l'apartheid in Sudafrica, la cantante Miriam Makeba, Mama Afrika, e il trombettista Hugh Masekela, nei primi anni Sessanta (fino al '66) marito e moglie (dal '68 al '73 la Makeba è stata poi sposata col leader delle Black Panthers Stokely Carmichael), la capoverdiana (quindi di lingua portoghese) Cesaria Evora, "regina della morna," la cui fama internazionale decolla peraltro nei tardi anni Ottanta, il nigeriano Fela Kuti, a sua volta attivista per i diritti civili, e il sassofonista camerunese Manu Dibango, artefice di una vivace fusione tra jazz e "africanismo" tout court.
Epilogo (o epitaffio?)
Le utopie degli anni Settanta (da non leggersi con una valenza negativa, anzi), così come erano germinate con un certo anticipo, più o meno con lo stesso anticipo iniziano ad affievolirsi, a sfaldarsi, a contatto (annoso, del resto) con incongruenze e moniti piuttosto veementi: la lotta armata a risolvere (risolvere?) contrapposizioni di natura ideologica e sociale, una progressiva perdita di identità (e di intenti), la stanchezza di molti, il "ritorno all'ovile" di altri (che sono poi le due facce di una stessa medaglia), un diffuso (cosiddetto) riflusso. In ambito creativo - musicale, nello specifico - il 1978, l'anno dell'affaire-Moro e dei tre papi, vede in pochi mesi la scomparsa di una serie di figure emblematiche, di giganti: Jacques Brel si spegne non ancora cinquantenne in ottobre, vinto dal cancro che lo sta braccando da anni; in novembre va a fargli compagnia, a neanche sessant'anni, Lennie Tristano, il poeta del primo jazz informale (bianco) fin dai tardi anni Quaranta, finché il 5 gennaio '79, in quel di Cuernavaca, tocca a Charlie Mingus, a cinquantasei anni: quello stesso giorno ad Agapulco, una manciata di chilometri più a sud, cinquantasei balene vanno ad arenarsi sulla spiaggia. Al di là di facili suggestioni, certe morti non possono che ritenersi emblematiche - come si diceva - di una fase storica che va a chiudersi. Il paradigma più pieno, almeno a casa nostra, di tale stato di cose può esser colto nella scomparsa di Demetrio Stratos: la notizia della grave malattia che lo ha colpito (una rara forma di aplasia midollare), costringendolo a cure costosissime che non si sa neppure quali risultati potranno sortire, inizia a diffondersi nella primavera '79. Il mondo della musica si mobilita compatto, col risultato, tuttavia, che il concerto organizzato in suo soccorso all'Arena di Milano (con Guccini, Venditti, Finardi, Vecchioni, Pagani, il Banco, ovviamente gli Area, ecc.) si tiene all'indomani della sua morte, avvenuta a New York il 13 giugno 1979. E' un'epoca che si chiude, già. Altri se ne vanno, anche subito in avvio del nuovo decennio: il 19 gennaio '80 ci lascia Piero Ciampi, livornese maledetto, addirittura preso in giro da una sorte che lo rapisce con la complicità di un cancro alla gola, quando tutti (lui per primo) si sarebbero attesi l'inevitabile cirrosi. Mesi dopo, il 25 luglio, tocca Vladimir Vysotsky, russo almeno altrettanto maledetto. Entrambi sono poco oltre i quaranta, anime molto "etiliche," irrequiete e bagarreuses. E' la fine di un'epoca, lo ribadiamo. L'opera postuma di Mingus, individuo non meno irrequieto e bagarreur [Nota 6], recuperata anni dopo da Gunther Schuller, non s'intitola forse Epitaph?
(3 - fine)
______________________________________
1. Nel già citato Parlami di musica, l'artista rievoca quegli anni e quell'esperienza alle pp. 203 e 206/7. Sia con SIC che con i Fratelli Sax, la Marini ha anche collaborato nei suoi lavori: in particolare, con i secondi, in Pour Pier Paolo (1984), tributo a Pasolini. 2. In realtà Automobili non reca la firma di Roversi, ma il semplice pseudonimo Norisso. Il poeta non ha infatti condiviso la decisione di Dalla di mettere su disco alcune canzoni dello spettacolo (comune) Il futuro dell'automobile e altre storie. Ciò segna implicitamente la fine del sodalizio. 3. La Cramps è indubbiamente l'etichetta di punta della "musica ribelle" dell'epoca. Nel catalogo dell'etichetta di Gianni Sassi, figura-chiave di un intero movimento, troviamo infatti personaggi largamente "centrifughi" quali gli Area e Steve Lacy, John Cage e gli Skiantos. 4. Quasi tutti gli artisti stranieri citati in queste pagine, di fatto, sono stati Premi Tenco: Ferré, de Moraes, Brassens, Brel, Cohen, Llach, Atahualpa e Chico Buarque, tutti di fila dal '74 all'81, Rodriguez nell'85, Waits e Serrat nell'86, Mitchell, Newman e Veloso fra '88 e '90, Vysotsky (postumo) nel '93, Milanés nel '94, Evora nel '95, Costello nel '98, Livaneli nel '99, Aute, Gil, Smith, Bonet e Hammill,tutti fra 2001 e 2004. 5. Particolarmente significativo, in merito, il doppio LP collettivo (con un ricco booklet fotografico-testuale) Dies i hores de la Nova Cançò, edito nel '78 su Edilgsa. 6. Su di lui ci permettiamo di segnalare Alberto Bazzurro, Psychomingus, saggio a suo tempo pubblicato su "Musica Jazz" e oggi reperibile su AAJ Italia (Rubrica "Déjà lu"), nonché l'autobiografia Peggio di un bastardo, Milano, B.C. Dalai, 2005.
Foto di Matt Morax (Gaslini), Roberto Amori (Guccini), Rex (L. Cohen), Jean-Pierre Leloir (Brel/Ferré/Brassens).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.