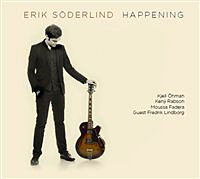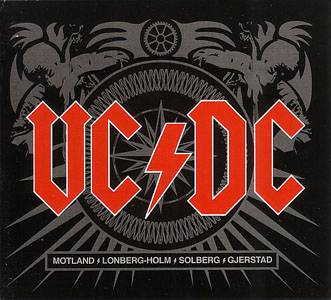Home » Articoli » Lyrics » Suoni (e parole) di un decennio nato settimino – prima parte
Suoni (e parole) di un decennio nato settimino – prima parte
Il 1970 arrivava a rimorchio del '68, in quel clima, con quelle stimmate, nel progressivo sgocciolamento delle istanze che avrebbero così fortemente segnato gli anni a venire. La musica giovanile più rivolta al presente/futuro lasciava in meno di un mese, fra settembre e ottobre, due eroi sul campo: Jimi Hendrix e Janis Joplin. Senza contare lo scioglimento dei Beatles, di cui John Lennon dava voce e corpo alla vena più sperimentale costituendo la Plastic Ono Band, in onore della sua nuova lady, quella Yoko Ono - artista stramba, onnivora quanto tutto sommato velleitaria - cui si vuole legata in primo luogo la morte di un mito (i Beatles, non Lennon: a lui avrebbe pensato di lì a dieci anni Mark Chapman).
Qualcosa era accaduto appena prima, e i riflessi si iniziavano ad avvertire appunto al decollare del nuovo decennio: nell'estate '69 si era officiato a Woodstock un festival-monstre destinato a imperiture celebrazioni nel quarantennio successivo. Uscito appunto nel 1970, il relativo film-documentario iniziava a fare il giro del mondo, già icona di tutto un nuovo modo di intendere e vivere la musica e ogni suo annesso e connesso. Sempre nel '69 i Pink Floyd, già orfani di Syd Barrett ma ancora imbevuti della sua geniale iconoclastia, avevano inciso Ummagumma (uscito nell'autunno di quello stesso anno), il loro album più sperimentale (buon coéquipier sarebbe stato, proprio nel '70 - sempre autunno - Atom Heart Mother, il celebre album della mucca, quanto meno relativamente al lato A, omonimo). E Miles Davis, in agosto (tornando al '69), aveva inciso Bitches Brew, uscito a inizio 1970 e destinato a scompaginare gli umori (e a guastare i buoni sonni) jazzistici a venire, con la sua immersione negli strumenti elettrici e nelle temperature del rock (magari mischiati con reminiscenze R&B e ingredienti soul), oltre che, con quanto ne sarebbe seguito nell'arte davisiana nell'immediato, ricettacolo-pigmalione di una messe di straordinari talenti, da John McLaughlin a Chick Corea, da Dave Holland a Keith Jarrett, a Jack DeJohnette [Nota 1].
Ma per il jazz l'estate 1969 era stata anche quella della grande diaspora parigina della seconda generazione free; chicagoana, anzitutto, da Anthony Braxton a Leo Smith, da Leroy Jenkins all'Art Ensemble dei vari Mitchell, Bowie, Jarman, Favors. Sempre in Europa nasceva la ECM, e ancora dall'Europa iniziava il suo forse tribolato ma fecondissimo ritorno in patria (l'Argentina, via USA) Gato Barbieri, che con The Third World dava il via alla sua fase terzomondista [Nota 2], di gran lunga la più fertile della parabola artistica del sassofonista di Rosario, con un manipolo di album maiuscoli concentrati nei primi anni Settanta, su tutti El Pampero, live a Montreux '71, e i primi due "capitoli" per la Impulse, Latin America e Hasta Siempre, usciti rispettivamente nel '73 e '74 (attingendo però da sedute piuttosto mischiate). A partire da Caliente (1976), poi, il Nostro avrebbe iniziato a marciarci un po' troppo vistosamente, scivolando in un baratro creativo di fatto senza uscita.
A casa nostra le cose stavano ancora un po' diversamente, benché cominciasse a muovere i primi passi il di lì a poco quanto mai concreto movimento progressive (PFM e Banco incideranno le loro opere prime nel '71). Il nuovo passava comunque soprattutto per quella che s'iniziava a chiamare "canzone d'autore," due dei cui pilastri, Fabrizio De André e Francesco Guccini, all'epoca entrambi trentenni, mettevano sul piatto (dei nostri giradischi) La buona novella il genovese e Due anni dopo il bolognese. Il quale, anzi, prima che quello stesso 1970 si esaurisse, partoriva addirittura un secondo album, L'isola non trovata. Ed è lampante come i "due anni dopo" del titolo del primo LP fossero (anche) quelli intercorsi dal succitato '68. Magari da quella stessa primavera di Praga che dava pure il titolo a una delle più riuscite canzoni del disco.
Zappa e i "padri nobili"
Naturalmente non c'era solo questo. Sempre nello sporgersi degli anni Sessanta su un decennio, il successivo, nato evidentemente settimino (in altre parole nel solito 1969), esordiva su disco uno dei gruppi-chiave del nuovo verbo progressive, i King Crimson (In the Court of the Crimson King, copertina storica, fra le più belle di sempre), seguiti l'anno dopo da Emerson Lake & Palmer (l'album omonimo, uscito come quello del Re Cremisi su Island). E il vorace Frank Zappa, con tutta probabilità il massimo genio del movimento rock (del resto era anche un sacco di altre cose), in quello stesso 1969 dava alle stampe due dei suoi album più significativi, il doppio Uncle Meat (primavera) e Hot Rats (autunno), oltre a incidere, in ottobre, King Kong, lavoro a firma del violinista francese Jean-Luc Ponty di cui Zappa, però, è autore, arrangiatore, conduttore, in una parola deus ex machina. In tutti questi lavori, l'artista di Baltimora iniziava a strizzare a sua volta l'occhio alle sonorità e alla filosofia (che vuol dire anzitutto improvvisazione) del nuovo jazz, seguendo un percorso che avrebbe dato la stura di lì a poco a capi d'opera quali Waka/Yawaka e The Grand Wazoo, sempre nel nome della voracità di cui sopra partoriti nello stesso anno, il 1972. Dell'anno prima era invece un altro doppio album, 200 Motels, colonna sonora dell'omonimo film, che pur (anzi: in fondo proprio) nella sua contraddittorietà rappresenta uno dei manifesti dell'arte zappiana, spesso così pericolosamente sporta sull'orlo del precipizio: per scoprire cosa ci sta di sotto, e creare, magari, qualcosa di inaudito, proprio nel senso etimologico del termine. In quest'opera sfrontata e un po' guascona, Zappa rivela nella maniera più compiuta (fino a quel momento) la sua devozione per un manipolo di artisti a loro volta (e a loro tempo) piuttosto scriteriati: Stravinsky (il primo, non quello neoclassico), Webern, soprattutto Cage e Varèse, dal concretismo alla serialità.
E cosa fanno, questi autori, che qualcuno (anche allora) vorrebbe paludati, in quegli stessi anni? Anton Webern, vertice con Schönberg e Berg del triangolo della cosiddetta scuola atonale viennese, è passato a miglior vita fin dal 1945. Edgard Varèse, suo coetaneo (1883), l'ha seguito vent'anni dopo. Igor Stravinsky ci lascia nel '71. John Cage, più giovane di trent'anni (1912), è invece ancora attivissimo. Iconoclasta per eccellenza (come già Varèse, e lo stesso Zappa, del resto), entro una produzione elefantiaca, eterodiretta e anticonformista come poche (probabilmente nessuna), negli anni Settanta Cage si rivolge, fra molto altro, agli Chants de Maldoror di Lautréamont, poeta decisamente irregolare, che "polverizza" nel 1971. Nel '76 scrive otto quartetti, che però arrivano a coinvolgere fino a novantatre esecutori! L'anno dopo parafrasa Proust in Alla ricerca del silenzio perduto (il silenzio, icona/ossessione cageana per antonomasia)[Nota 3]. In Italia lo si vede abbastanza spesso: è diventato a sua volta una sorta di icona della trasgressione in musica (e ci sarebbe mancato altro!), piuttosto noto - magari per sentito dire - anche fra i giovani che seguono progressive e nuovo jazz. Tiene concerti memorabili. Soprattutto perché spesso non sono affatto tali: sono non-concerti, nel corso dei quali spesso legge, proponendo il suo Finnegan's Wake joyciano e altre diavolerie [Nota 4]. Lo attrae la dimensione sociale (allora la si definiva senza mezzi termini "politica") della produzione artistica, del gesto creativo (e creatore). Incarna ben più il ruolo di maître-à-penser, al limite di guru, che non di musicista in senso stretto. Come per altri grandi sparigliatori dell'arte novecentesca (Fontana, Man Ray, Duchamp) il gesto, l'idea, l'intenzione contano persino più del risultato in sé e per sé.
A sua volta "santone" di sponda colta riconosciuto anche dai giovani, specie in virtù della sua sensibilità verso l'elettronica (ciò fin da Gesang der Jünglinge, pagina nodale nel settore, anno di grazia 1955), il tedesco Karlheinz Stockhausen sviluppa negli anni Settanta le sue attitudini didattiche, distinguendosi, sul piano della scrittura per un paio di pagine clarinettistiche del biennio 1976/77 costruite sulla figura di Arlecchino, e soprattutto concepisce quella che sarà la sua monumentale eptalogia operistica (in senso non tradizionale, ovviamente) che va sotto il nome di Licht (luce) e che a partire dall'81 lo vedrà dedicare una megacomposizione (tre/quattro ore in media) a ciascun giorno della settimana [Nota 5]. Altre figure, sempre di ambito colto-contemporaneo, di cui non si può tacere, anche proprio per il rilievo giocato specificatamente negli anni Settanta, sono quelle dei nostri Luigi Nono e Luciano Berio, e del francese Pierre Boulez (ma anche Ligeti, Xenakis, Kagel, Manzoni, Bussotti, Globokar, Sciarrino...), non ultimo per l'omogeneità anagrafica esistente fra loro, e del resto con lo stesso Stockhausen (si va dal 1924 di Nono al '28 proprio del tedesco). A Boulez, giusto nel 1970, il presidente francese Pompidou commissiona la creazione dell'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), che il compositore dirigerà fino al '92 (oltre ad altre direzioni, tra cui, dal '71 al '77, quella della New York Philharmonic), mentre come chef d'orchestre dirigerà, fra le moltissime, composizioni "colte" niente meno che di Frank Zappa (The Perfect Stranger, EMI, 1984). Berio, invitato dallo stesso Boulez, insegna a sua volta all'IRCAM (sezione elettro-acustica, e citiamo allora un paio di suoi lavori elettronici: Per la dolce memoria di quel giorno, del 1974, e Chants parallèles, del '75), prosegue nelle sue celebri Sequenze per strumento solo e scrive copiosamente - com'è del resto suo costume - per pianoforte e per voce (ricordiamo, al proposito, il suo matrimonio con Cathy Berberian, "musa" per antonomasia della vocalità del secondo Novecento), in particolare, nel '74, un Canto in memoriam del collega Bruno Maderna, scomparso l'anno prima poco più che cinquantenne, oltre a musicare testi di Sanguineti e Neruda. A quest'ultimo, così come a Pavese, Ungaretti, Lorca, ecc., quindi alla parola in senso lato, è quanto mai sensibile Luigi Nono, i cui lavori degli anni Settanta (e oltre) assumono - anche proprio grazie al ricorso alla parola - connotazioni largamente militanti (è nota la sua fede marxista), in un iter creativo [Nota 6] culminato (forse quintessenziato) nel 1980 col quartetto d'archi Fragmente-Stille, An Diotima. Da notare che fra i più assidui sodali di Nono figura il trombonista Giancarlo Schiaffini, su cui torneremo quando parleremo del nuovo jazz italiano, nonché del Gruppo d'Improvvisazione Nuova Consonanza.
Prima c'è però almeno da accennare ad alcuni musicisti, pure loro figli di quei medesimi anni Venti, che, pur lungo altre coordinate, caratterizzano il decennio di cui ci stiamo occupando (e non solo, del resto). Il più prossimo al côté contemporaneo-colto appena avvicinato è senz'altro Ennio Morricone, che a partire dal 1961, dopo il successo del Federale di Luciano Salce, di cui ha scritto non senza una certa dose di casualità la colonna sonora, mette un po' da parte le sue velleità da compositore serio per dedicarsi appunto alla musica da film (mezzo migliaio, a oggi, i soundtracks a sua firma), instaurando in particolare un sodalizio del tutto speciale col suo ex-compagno di scuola Sergio Leone, per il quale, nel '71, musica Giù la testa, cui fa da corollario un altro capolavoro, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, e poi Sacco e Vanzetti, Novecento, Todo Modo e tutta una lunga serie di altre pellicole più o meno entusiasmanti (sempre limitandoci agli anni Settanta), nelle cui musiche è comunque coglibile una cifra stilistica inconfondibile. Diplomatosi nel '54 con Goffredo Petrassi, Morricone non ha del resto mai accantonato la pratica della composizione "assoluta". Fin dal 1965 fa tra l'altro parte dell'appena citata Nuova Consonanza.
Improvvisazione, già: il vessillo, il connotato-base del jazz. Ci torneremo, come detto. Per il momento proseguiamo con altri due figli degli anni Venti. Il primo è l'argentino Astor Piazzolla, il profeta del nuevo tango, che sul ceppo del tango tradizionale introduce elementi inusitati (per alcuni, in patria, addirittura blasfemi), togliendogli un po' di "ballabilità" (e la voce, quella dei Gardel, Goyeneche, ecc.) e avvicinandolo, di converso, alla musica contemporanea (ha studiato a Parigi con Nadja Boulanger) e allo stesso jazz. Proprio negli anni Settanta, nei quali affianca al quintetto, sua formazione-base, un nonetto che accentua certo carattere "cameristico" della sua musica, Piazzolla incide fra gli altri con Gerry Mulligan (Summit, 1974), esperienza che ripeterà più tardi (1986), con esiti anche più succosi, accanto al vibrafonista Gary Burton. Come Morricone, Piazzolla è (ancora oggi) quello che potremmo definire un musicista trans-generazionale (e trans-stilistico). Lievemente diverso il caso del compositore e sitarista indiano Ravi Shankar, il cui mito viene fin dai tardi anni Sessanta ampiamente alimentato dagli uomini del pop/rock, a cominciare dai Beatles, specie da quel George Harrison che nel '71, al Madison Square Garden di New York, lo coinvolge nel celeberrimo Concert for Bangladesh, rito collettivo per eccellenza di un'epoca quanto mai sensibile ai megaraduni (oltre a Woodstock, ricordiamo almeno Isle of Wight 1970, con Jimi Hendrix e Miles Davis fra i protagonisti) che diventerà anche un fortunatissimo (Grammy Award, fra l'altro) album triplo (con Ringo Starr, Eric Clapton e Bob Dylan fra gli altri). Rock, pop, progressive, fusion: l'America
Parlando di megaraduni, non possiamo non aprire un'ampia finestra sulla musica giovanile, d'altra parte la più tipica (e incidente) dell'epoca. Due sono essenzialmente gli eden da cui il nuovo verbo musicale, sul ceppo rock/pop/beat (il cosiddetto progressive, in primo luogo), si diffonde: Stati Uniti e Inghilterra, pur non mancando altre piste, per esempio quella tedesca, come vedremo (né mancherà, ovviamente, uno scandaglio della scena nostrana). Negli States, sul versante più sperimentale, avanzato, oltre al già citato Frank Zappa (nella cui orbita gravita fra gli altri un artista pazzoide come Captain Beefheart, cantante, musicista e pittore), un'altra figura di riferimento è certamente il chitarrista e polistrumentista californiano Jerry Garcia, leader dei Grateful Dead, gruppo - cosiddetto - "psichedelico" (come per esempio i newyorchesi Vanilla Fudge, da una cui costola, peraltro, già nel 1970 sono nati i Cactus, decisamente più rockeggianti). Garcia ama del resto agire anche in proprio, a iniziare dal primo, nodale album a suo nome, Garcia (1972), largamente sperimentale. I Grateful Dead, in effetti, stanno iniziando proprio allora a sporgersi verso una china più "commestibile," imbevuta di quelle atmosfere soft rock di cui del resto la California è generosa dispensatrice. Il gruppo-guida di questo genere, fortemente intriso di umori country, tutto chitarre acustiche e voci lievi, è certo Crosby, Still, Nash & Young (Déjà vu, 1970; Four Way Street, 1971; del solo Neil Young, che si unisce in un secondo tempo al trio preesistente, Harvest, 1972), col possibile contraltare (piuttosto omologo, del resto) degli America, presenti fin dal 1971 con l'album omonimo.
La California è del resto teatro anche di esperienze piuttosto lontane da questo scenario, di cui sopravvive peraltro proprio una tendenza a battere strade più orecchiabili, fruibili. E' il caso dei Santana, che sembrano concentrare il loro afflato innovativo nel primo album, l'omonimo del '69, in particolare nello strumentale "Soul Sacrifice," trasfigurato in una sorta di orgia di chitarre e percussioni (soprattutto) nelle celebre live version woodstockiana. Altri brani già adombrano quella tensione - se così la possiamo chiamare - verso una cantabilità fin troppo ecumenica che il leader del gruppo, Carlos, sposerà sempre più massicciamente già a partire dal successivo Abraxas (1970), contenente la celeberrima "Samba pa ti," tutta per la sua chitarra, e più ancora nel discutibile Santana III (1971). La china è quella, indiscutibilmente, anche se un qualche colpo d'ala può essere colto in Caravanserai (1972), che introduce una (peraltro breve) stagione in cui Santana - sempre nel senso di Carlos - si avvicina all'area jazzistica e, in parallelo, alla cultura indiana. In tale contesto si colloca la sua collaborazione col collega John McLaughlin, che lo introduce al guru Sri Chinmoy (che lo ribattezza Devadip, così come McLaughlin è Mahavishnu) e con cui nel '73 incide il pregevole Love Devotion Surrender, che include in primis una soffice versione per due chitarre acustiche di "Naima" di Coltrane, con la vedova del quale, Alice McLeod, l'anno dopo Carlos Santana realizza Illuminations. In mezzo si situa il quinto album dei Santana (intesi qui come gruppo), Welcome, non privo di motivi d'interesse. Un interesse che, fuori da mere logiche di mercato, inizia a scemare senza ritorno a partire dal successivo Borboletta (1974).
Al di là di gruppi più prossimi alla costola hard del movimento complessistisco dell'epoca (dai Mountain di Felix Pappalardi e Leslie West, a Grand Funk Railroad e Iron Butterfly, tanto per fare qualche nome), il panorama americano di inizio decennio non manca di realtà che, ben più dei Santana, proprio a monte, recuperano stilemi tipici del jazz di sezione, impastato di R&B e soul. Ci riferiamo in primo luogo a Chicago T.A. e Blood Sweet & Tears, zeppi di fiati, mentre un'ideale compenetrazione dei due modelli - quello appunto fiatistico, e quello multipercussivo dei Santana - è coglibile negli afro-caraibici Osibisa (attivi peraltro in Inghilterra). Se parliamo tuttavia di contaminazione reale fra lessico jazzistico e rock, il cui veicolo è costituito, forse prima ancora che da un fatto idiomatico in senso stretto, dall'ampio ricorso alla strumentazione elettrificata (talora elettronica), non c'è dubbio che i risultati più probanti riguardino tutta quella costola (o diaspora) davisiana che passa attraverso gruppi quali la Mahavishnu Orchestra del già citato McLaughlin (peraltro inglese), i Weather Report di Wayne Shorter e Joe Zawinul, il sestetto di Herbie Hancock e il Return to Forever di Chick Corea; formazioni che, pur fra alti e bassi, hanno ospitato musicisti di chiara matrice jazz (come del resto i succitati, ovviamente) tipo i bassisti Miroslav Vitous, Buster Williams e Stanley Clarke, i batteristi Billy Cobham, Peter Erskine e Billy Hart, il trombonista Julian Priester, i polistrumentisti Joe Farrell e Bennie Maupin, a volte incrociatisi nei diversi organici.
Non è probabilmente un caso che le incisioni più significative del filone (per lo più identificato - non senza una qualche approssimazione - come fusion) siano di fatto racchiusi in pochi anni: quelli iniziali. Ci riferiamo ad esempio ai primi due album della Mahavishnu Orchestra, The Inner Mountain Flame e Birds of Fire, a I Sing the Body Electric e Sweetnighter dei Weather Report, Crossings di Herbie Hancock, Return to Forever del gruppo omonimo, tutti compresi fra 1971 e '73. Un'eccezione può esser fatta, eventualmente, per il periodo del passaggio per i Weather Report del geniale bassista elettrico Jaco Pastorius, eroe tragico della stirpe dei Charlie Parker e degli Hendrix prematuramente scomparso (a trentasei anni) dopo una vita sregolata come poche. Gli anni alla corte della premiata ditta Shorter & Zawinul vanno dal '76 all'80, attraverso album quali Heavy Weather, Mr. Gone, 8:30. Pastorius, che nella sua breve carriera collabora fra gli altri con Joni Mitchell e con un giovanissimo Pat Metheny, ama misurarsi con situazioni fra loro anche piuttosto diversificate. E' in tale contesto che si colloca il suo album forse più stimolante, Triologue, live berlinese del 1976 che lo vede dialogare abbastanza senza rete col trombone "multifonico" di Albert Mangelsdorff e la batteria di Alphonse Mouzon.
Inghilterra e dintorni
Venendo al panorama inglese, già si è accennato ad alcuni gruppi e incisioni particolarmente significativi del periodo a cavallo fra anni Sessanta e Settanta. Ci sono ovviamente anche gruppi di grande richiamo più "intinti" nei turgori dell'hard rock, Led Zeppelin e Deep Purple, Who e Ten Years After, Black Sabbath e Uriah Heep, più o meno tutti destinati ad avere più tardi una qualche influenza sugli estremisti dell'heavy metal; tuttavia è altrove che dimorano le idee, le intuizioni, più illuminanti. I già citati Pink Floyd riversano in Meddle (1971) l'estremo anelito dei più sani appetiti (post)barrettiani, per battere poi via via (dai fortunatissimi The Dark Side of the Moon, del '73, e The Wall, del '79, a quanto gravita lì intorno) sentieri più ecumenici. EL&P realizzano nel '71 ben due LP: Tarkus, più che probabile apice della loro produzione, che come già Atom Hearth Mother dei Pink Floyd, ruota attorno a un'ambiziosa suite che ne copre la prima facciata, e il live Pictures at an Exhibition, basato sull'omonima pagina pianistica di Musorgskij, cui si alternano brani originali del trio. Anche i King Crimson di Bob Fripp sono all'epoca quanto mai prolifici: fra 1970 e '71 escono infatti Lizard e Islands, album in qualche modo gemelli (anche per l'ottima qualità) che coinvolgono alcuni dei più bei nomi del nuovo jazz inglese, da Keith Tippett a Mark Charig, da Harry Miller (in realtà sudafricano) a Nick Evans. I Jethro Tull, attivi fin dal '67 attorno al flautista Ian Anderson, innamorato del polistrumentista neroamrericano Roland Kirk, nel '71/72 sfornano a loro volta due pezzi da novanta quali Stand Up e Thick Is a Brick.
Innumerevoli sono del resto i nuovi gruppi che si affacciano all'inizio del decennio, dai Van der Graaf Generator (a partire da Pawn Hearts, del 1971), il cui sassofonista, David Jackson, ha qualcosa a che fare con Dick Heckstall-Smith dei Colosseum (che sempre nel '71 firmano il doppio Colosseum Live) nonché col citato Roland Kirk (tutti e tre amano suonare più sassofoni simultaneamente), agli Yes (Fragile, 1971), dai Genesis (Nursery Cryme, 1971; Foxtrot, 1972) ai Gentle Giant (Three Friends, 1972), dai Curved Air, il cui nome trae spunto dal celebre album A Rainbow in Curved Air (1969) di Terry Riley, uno dei "santoni" (con Philip Glass, Steve Reich, John Adams) del cosiddetto movimento "minimalista" (o iterativo), ai Roxy Music (Roxy Music, 1972), dall'Electric Light Orchestra fino, un po' più tardi, a Talking Heads e Police. E non si può fare a meno di notare come da quasi tutte queste realtà prendano poi le mosse carriere solistiche particolarmente brillanti, da Peter Hammill (Van der Graaf) a Peter Gabriel e Phil Collins (entrambi Genesis), da Brian Eno (e lo stesso Brian Ferry) dei Roxy Music a David Byrne (Talking Heads) e Sting (Police); formazioni, queste ultime, che ci rimandano a una fase già successiva, segnata dall'ascesa del movimento punk (da alcuni letto come una sorta di fenomeno neo-dada), i cui gruppi di riferimento sono Sex Pistols (soprattutto) e Clash, entrambi inglesi, benché ne esista anche una "costola" americana (Heartbreakers, ecc.).
(1 - continua) [per leggere la seconda parte clicca qui e per la terza parte clicca qui]
______________________________________
1. Sulla svolta elettrica davisiana, segnaliamo il ponderoso quanto illuminante volume di Enrico Merlin e Veniero Rizzardi Bitches Brew. Genesi del capolavoro di Miles Davis, Milano, Il Saggiatore, 2009. 2. In un'intervista con l'autore del presente scritto, Gato Barbieri ha dichiarato al proposito: "Direi che tutto è cominciato nel 1969 con [The Third World]. In Francia è stato giudicato il miglior disco dell'anno, a posteriori tutti ne hanno parlato come del disco della grande svolta, ma allora non è successo un bel niente. Però è servito al produttore Bob Thiele per capire certe cose. Io, comunque, sono tornato a Buenos Aires, dove è stato organizzato uno show per me, da parte di qualcuno che mi conosceva bene fin da prima che me ne andassi dall'Argentina. Ci hanno messo dentro il tango, la musica indigena... E io ho cominciato a capire che dovevo tornare veramente alle origini, incidere i miei dischi lì, con i musicisti del posto [...]. Così è nato Chapter One e i successivi capitoli per la Impulse" (Alberto Bazzurro, Parlami di musica, Arezzo, Zona, 2008, pp. 50/51). 3. Al silenzio Cage aveva dedicato fin dal 1952 la celeberrima 4'33", appunto quattro minuti e trentatre secondi di nulla sonoro totale. E nel 1969 la già citata triade chicagoana Braxton/Smith/Jenkins aveva inciso un intero album intitolato appunto Silence. Dove, però, nel brano omonimo (durata un quarto d'ora) qualche suono, pur sporadico, si udiva. 4. Sulla natura delle performance cageane e relativa ricezione da parte del pubblico, Patrizio Fariselli così rievoca una serata al Teatro Lirico di Milano: "La situazione degenerò velocemente. Dalla bolgia si udirono levarsi cori che intonavano 'Fin che la barca va...,' 'Quel mazzolin di fiori...' e altri avanguardismi dello stesso tenore. Si videro volare alcuni rotoli di carta igienica. Finché qualcuno schizzò d'acqua il tavolo di Cage!". Che peraltro proseguì imperterrito, cosicché "Il concerto durò più di due incredibili ore! Poi di colpo Cage finì, si tolse gli occhiali, si alzò e, con nostra sorpresa e raccapriccio, si diresse con passo deciso verso la platea, allargando le braccia. Partì in quel momento un imprevedibile, scrosciante applauso!" (Patrizio Fariselli, Empty Worlds, in Storie elettriche, Milano, Auditorium, 2008). Il volume è largamente consigliabile non solo per il capitoletto dedicato a John Cage: offre infatti uno spaccato emblematico degli anni che stiamo trattando, sia per l'esperienza globale di Fariselli come membro degli Area, sia per elementi più specifici, in particolare il capitolo L'era dei grandi raduni (pp. 43/61), centrato sull'esperienza di Parco Lambro. Specificatamente su Cage, segnaliamo invece Michele Porzio, Metafisica del silenzio, Milano, Auditorium, 1995. 5. In realtà Stockhausen non completerà l'impresa, arrestandosi (nel 2003, quattro anni prima di morire) al sesto giorno: a rimanere fuori sarà il mercoledì. 6. Paradigmatica, peraltro (e del resto non isolata), la discrasia che viene a instaurarsi fra gli intenti del compositore veneziano e l'effetto reale delle sue opere sul "popolo," destinatario deputato delle stesse. Significativa, al proposito, una testimonianza di Ivan Della Mea riguardo a un concerto dei primi anni Settanta al Palasport di Roma, con Nono alternatosi allo stesso Della Mea, Giovanna Marini e Paolo Pietrangeli (abbinamento già di per sé emblematico di tutta un contesto socioculturale): l'esibizione di Nono, largamente sperimentale, fu accompagnata da ampie bordate di fischi, al punto che il compositore dovette fermarsi, prendere in mano il microfono e "apostrofare" gli astanti, spiegando le motivazioni che lo avevano spinto a essere lì. Solo a questo punto arrivarono, immancabili, gli applausi dei "compagni" (vedi Ivan Della Mea, Sinistra non di frizzi e lazzi, "Il Manifesto," 31.05.08).
Foto di Ivor Sharp (Lennon/Ono) e Erich Auerbach (J.Cage).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.