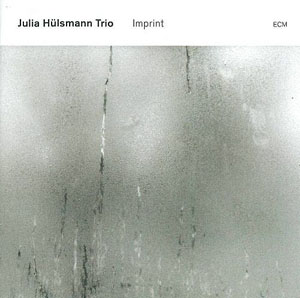Home » Articoli » Lyrics » Psychotrane #1: la definizione di un codice
Psychotrane #1: la definizione di un codice
Abbordando il pianeta-Coltrane con l'intento di carpirne qualche segreto, qualche angolo nascosto, in modo da oltrepassare i confini del biografismo più o meno ufficiale, non ci vuole molto ad accorgersi quanto aggrovigliato, enigmatico, apparentemente contradditorio appaia il personaggio. La matassa da srotolare è indubbiamente ingarbugliata. Per di più Coltrane non rappresenta certo un "caso" accattivante, a suo modo da manuale, come un Davis, un Monk, un Mingus. Nel suo caso, in effetti, il sociologo è ben accetto quanto l'analista del profondo, e così pure i suggerimenti su quelli che possono essere i primi nodi, i più urgenti, da sciogliere.
Ed ecco che ci vengono allora in soccorso un paio di interrogativi sollevati da quel vivace, acutissimo osservatore che era Arrigo Polillo. Non in ponderosi tomi monografici, bensì in due veloci testi, Polillo mette sul piatto alcuni degli enigmi-chiave che riguardano il grande sassofonista: "Che tipo di uomo era Coltrane? Questo è il punto: un punto che lui, taciturno e riservato com'era, fece di tutto per lasciare oscuro" [Nota 1]. E altrove: "questo singolare personaggio che passò con disinvoltura, nel giro di pochi giorni, dall'eroina alle tazze di acqua calda; che, senza abbandonare il suo timido sorriso, inventò una musica furibonda che sembrava volesse esplorare le leggi dell'universo; che leggeva Einstein e i sacri testi indiani e parlava di filosofia con gli amici jazzmen (che lo ascoltavano allibiti); che si preoccupava, prima di assumere qualche musicista, che fosse 'pulito,' ma che poi si tenne accanto, per anni, due tipi come Elvin Jones e Jimmy Garrison che 'puliti,' almeno allora, non erano di certo (...); che aveva una solida fama di marito affettuoso ma che per un certo tempo si giostrò contemporaneamente tre donne: la moglie Naima, Alice, che avrebbe sposato anni dopo, e una misteriosa signora bianca" [Nota 2]. Insomma, ce ne sarebbe già d'avanzo. E invece, a tutti questi interrogativi, bisogna aggiungerne almeno altri due, quasi scontati: quale reale rilievo ebbe nell'iter artistico ed esistenziale di John Coltrane l'aspetto mistico-religioso? E quali interconnessioni è lecito cogliere fra le sue scelte musicali e l'inquietante condizione di fermento permanente in atto fra i neri d'America in pratica lungo tutto l'arco della sua parabola creativa [Nota 3]?
Una religiosità ritualistica e collettiva
John Coltrane nasce ad Hamlet, North-Carolina, il 23 settembre 1926. Che rappresenti una delle tre figure-cardine dell'immagine nera degli anni Sessanta che lo dice già una semplice coincidenza di date: è pressoché coetaneo sia di Malcolm X che di Martin Luther King, entrambi usciti come lui di scena prematuramente verso i quarant'anni [Nota 4]. La loro è la generazione svezzatasi negli anni del New Deal, per i neri un periodo in fondo più favorevole di altri "per il semplice fatto che [anch'essi] si trovavano nella grande massa degli americani poveri che Franklin D. Roosevelt fuse in una potente maggioranza politica fondata sul principio che a ogni cittadino doveva essere garantito un livello minimo di benessere [in modo] da essere degli alleati tutt'altro che trascurabili. Eppure nemmeno allora il compenso che ricevettero per l'appoggio dato a Roosevelt fu pagato sempre in moneta di buona lega" [Nota 5]. I contrasti razziali, in effetti, sono all'epoca tutt'altro che sopiti. Intorno al 1920, grande seguito ha incontrato l'UNIA di Marcus Garvey, che predica il ritorno del neroamericano alla Madre Africa. Accusato nel 1925 di frode fiscale (sic), due anni dopo Garvey è deportato in Giamaica, dove morirà nel 1940. L'UNIA rimane attivo tuttavia almeno fino ai primi anni Trenta. Di esso fa parte anche Earl Little, padre di Malcolm X [Nota 6]. Nel 1931 la Legione Nera, corrispettivo nordista (i Little sono del Michigan) del Ku Klux Klan, lo punisce per questa sua attività: aggredito e malmenato, Little Sr. viene poi "disteso sulle rotaie in modo che una vettura transiti e possa passare sopra di lui" [Nota 7].
Earl Little è un pastore battista, come Martin Luther King. E come Walter Blaire, nonno materno di John Coltrane, grande oratore e anch'egli acceso difensore dei diritti degli afroamericani. Religione e impegno sociale, dunque: un'altra costante che lega Coltrane ai due leader neri. Una prima presa di coscienza degli attriti razziali, per la verità, non giunge per il piccolo John fino ai dodici anni, allorché, nel giro di pochi mesi, perde prima il nonno e poi il padre, e con essi quella sorta di limbo in cui il suo stato di piccoloborghese (il padre era sarto) lo aveva proiettato.
Ma sondiamo un po' più a fondo questi che sono anni-chiave nella formazione di qualsiasi individuo. Intanto l'aspetto mistico-religioso. Al ruolo del nonno materno si è accennato. L'infanzia di John è sostanzialmente serena. Quella religiosità ritualistica e collettiva che è tipica di tante famiglie nere entra anche in casa sua dalla porta principale. E con essa, naturalmente, la musica: suo padre, John Sr., suona violino e ukulele; sua madre Alice il pianoforte (esatto: stesso nome e stesso strumento della sua seconda moglie, coincidenza quanto meno singolare), in particolare proprio durante le funzioni religiose. E John è tutt'altro che insensibile alle magie (e alle malie) della church music. Ad affascinarlo è soprattutto la voce femminile.
La presenza femminile, del resto, lo avvolge, globalmente, in maniera massiccia. E altrettanta è la sensibilità che egli rivolge a tale universo: basti ricordare il forte legame con la cugina Mary, che vive nella stessa grande casa del reverendo Blaire a Haig Point, e a cui John dedicherà uno dei suoi temi più noti, "Cousin Mary". E poi c'è la madre, con la quale l'unione si fa a senso unico appunto con la morte del padre e del nonno. Alice Blaire è così costretta ad andare a servizio presso famiglie bianche. Per il dodicenne John, come si è detto, è l'estromissione dall'eden infantile. E l'esteriorizzazione di tutto il fitto intersecarsi di sensazioni e tumulti che - prevedibilmente - si addensano nel suo animo è già estremamente indicativa del suo temperamento. Perché, di fatto, tale esteriorizzazione non si manifesta. Dall'esterno, John seguita ad apparire un ragazzo compassato e tranquillo, che ha bisogno di sentirsi della gente attorno per poi magari scegliere di farsi intenzionalmente da parte, di isolarsi. Un introverso, insomma. Certamente un ragazzo che non ama usare gli altri come cassa di risonanza per ciò che lo rode nell'intimo.
Da cosa può derivargli un atteggiamento del genere? Verosimilmente da un fattore ben preciso: la sua condizione di piccoloborghese. Lontano dalle tribolazioni del ghetto, John avverte - a livello più o meno subgiacente - la responsabilità connessa a un tale privilegio: lui che non ha subìto particolari contraccolpi né morali né materiali (ricordiamo: un'infanzia serena, affettivamente gratificante, sulla quale torreggia un modello come quello offerto dal reverendo Blaire, e condizioni economiche discrete), sente di non avere il diritto, neppure quando certi scompensi iniziano a manifestarsi, di lasciarsi andare. Sarà questa una costante che lo accompagnerà per tutta la vita [Nota 8]. Il tarlo, tuttavia, esiste, e col tempo si fa sempre più urgente una valvola di sfogo. John William Coltrane la troverà nella musica.
La scissione (fuori dal limbo)
E' del tutto probabile che non sia un caso se la pratica musicale inizia per John proprio al tempo dei suoi primi dissapori con la vita. E' alla scuola del reverendo Steele, nella stessa chiesa che era stata di suo nonno, che apprende dapprima il sax alto, quindi il clarinetto. Le pulsioni compresse, quando non addirittura rimosse, creano delle ovvie fratture interiori. Al di là del fatto che certe costrizioni, quel tendere caparbio e sfibrante al dominio delle proprie emozioni, generino un sostanziale stato di spossatezza - che, a livello epidermico, può calarsi la maschera, di regola bene accetta dal mondo esterno, dell'impermeabilità [Nota 9] - è evidente che la pulsione non assecondata si prenderà le proprie rivincite nell'attività irrazionale: onirica e creativa. Freud ci conferma che "l'arte offre soddisfacimenti sostitutivi per le più antiche rinunce imposte dalla civiltà (...) e contribuisce perciò come null'altro a riconciliare l'uomo con i sacrifici da lui sostenuti in nome della civiltà stessa" [Nota 10]. In tal senso la musica, in Coltrane come in tanti altri, adempie meglio di qualunque altra forma d'arte a questa irrinunciabile funzione riequilibratrice: "tutta la personalità dell'artista - scrive Guido Lami - contribuisce alla creazione musicale, nella quale l'artista trova un appagamento se non perfetto, certamente totale: come nessuna altra arte la musica possiede capacità sublimatrici, 'sublimazione' intesa nel senso psicoanalitico di trasformazione inconscia di tendenze, istinti, complessi, repressi o nascosti nella zona dell'inconscio. (...) Questo non avviene né per la pittura, né per la poesia, né per qualsivoglia altra arte" [Nota 11].
E' così che la voragine fra il Coltrane quotidiano e quello pur sempre straordinario della creazione musicale, con gli anni, si fissa, sedimenta, diviene un'autentica strategia di difesa. E di sopravvivenza. "Tuttavia - come Freud c'insegna - non si fa nulla per nulla. Il successo è stato raggiunto a prezzo di una lacerazione dell'Io che non si cicatrizzerà mai più, che anzi si approfondirà col passare del tempo. Le reazioni antitetiche al conflitto permarranno entrambe come nucleo di una scissione dell'Io" [Nota 12].
A differenza dell'introversione del coetaneo Miles Davis, pur maturata a contatto con analoghe condizioni ambientali esterne (la comune appartenenza alla borghesia nera, fuori dai tormenti del ghetto), dalla quale traspare eloquente un rancore sordo, e che di conseguenza definiremmo "risentita," l'introversione coltraniana appare pacifica, incruenta. Tanto quanto Miles è collerico e permaloso, John è dolce, disponibile (anche se forse non proprio affabile), modesto. La causa di tale distanza è da ricercarsi nelle differenti esperienze familiari (quindi ambientali interne). La scissione davisiana affonda le proprie radici nel contrasto fra padre e madre, è subita fin dalla prima infanzia, per raggiungere il proprio acme con l'adesione all'etica "degenerata" dei boppers, irreparabilmente antitetica rispetto a quella familiare. La scissione coltraniana, per contro, si situa in epoca successiva, quando già il ragazzo ha potuto predisporre certi elementari meccanismi di difesa, e quel che più conta è tutta proiettata verso l'ambiente esterno, fermo restando il saldo legame con la famiglia. In qualche misura è dunque una scelta.
Varrà la pena a questo punto, dopo gli iniziali interrogativi di Polillo e questa prima ricognizione sulla natura della scissione coltraniana, di andarci a leggere qualche passo della vasta letteratura riguardante il sassofonista che torni utile in questa nuova luce. Joachim Berendt: "John Coltrane (...) regolò il suo rapporto con il mondo circostante con assoluta imperturbabilità" [Nota 13]. Frank Tenot: "John Coltrane assomigliava poco, fisicamente, alla sua musica. (...) Anzi, fuori di scena, questo impavido e temerario ricercatore si comportava in modo estremamente timido. A Parigi, nel 1962, sottraendosi alla folla degli ammiratori, trovò scampo in un negozio di alimentari della Rue Caumartin e qui comprò due mele che si ritirò poi a sbocconcellare nella sua stanza d'albergo, terrorizzato all'idea di dover fare il suo ingresso in un ristorante, di ordinare un pranzo e dover sopportare la curiosità delle altre persone. Di una riservatezza quasi morbosa, sempre sulla difensiva, rispondeva alle domande dei giornalisti con difficoltà, stupito e preoccupato al pensiero che tanto interesse potesse concentrarsi su di lui" [Nota 14]. Polillo: "Era un uomo 'serafico': questo è l'aggettivo giusto. Proprio il contrario della sua musica, tumultuosa, ubriacante" [Nota 15]. Infine Jean-Louis Comolli, a proposito di una versione live di A Love Supreme: "Musica non celeste, ma infernale, in cui l'amore di Dio è la morte dell'uomo" [Nota 16].
Sul piano musicale, le immagini evocate dalla critica sembrano schizzate un po' troppo univocamente sulla memoria di quanto partorito da Coltrane nell'ultimo biennio, in particolare dal vivo. Ogni microstruttura improvvisativa, invece - quand'anche urlata, dilaniata, con la rabbia rimossa che prende più scopertamente il sopravvento - è in lui immancabilmente innervata di profondo lirismo, talora addirittura soavemente estatico (si pensi solo a "Naima," a "To Be," a vari episodi dello stesso A Love Supreme in studio). Naturalmente ciò che non toglie che l'adesione al processo di elevazione a categoria del laid, iniziato un secolo prima con Baudelaire, quindi con Lautréamont e Rimbaud in poesia, non senza nitidi addentellati musicali (la dissonanza wagneriana) ed etici (l'esaltazione dionisiaca nicciana), segni profondamente la produzione del Coltrane maturo. Come felicemente colto ancora da Comolli nell'articolo citato, mai il jazz era stato "portato a un tal punto di esaltazione, l'improvvisazione così vicina al delirio e la bellezza alla mostruosità". A quest'estremizzazione contribuiscono ovviamente anche precise ragioni storico-ambientali. Ne riparleremo più avanti. Vediamo ora di riprendere invece il filo dell'iter esistenziale coltraniano, anche per soppesare l'immagine forse fin troppo edificante che potrebbe essere emersa da alcune delle annotazioni appena riportate.
L'Islam e i paradisi artificiali
Avevamo lasciato un John Coltrane tredicenne alle prese con i primi approcci musicali; lo ritroviamo una decina d'anni dopo a Filadelfia, dove si è trasferito e suona principalmente con gruppi rhythm and blues (nel 1947, con Eddie Vinson, ha scoperto il sax tenore). Ha subìto anche lui l'influenza parkeriana, e come per molti colleghi tale influenza oltrepassa l'ambito strettamente musicale. Anche John inizia così a frequentare i "paradisi artificiali" (alcool compreso), giungendo in breve a un ricorso massiccio all'eroina. Contemporaneamente si avvicina all'Islam, anche qui perfettamente in linea con gli usi della bop generation. E' in particolare Yusef Lateef, suo collega in seno alla big band di Dizzy Gillespie (1949/50), a suggerirgli la lettura del Corano e di altri testi a carattere religioso.
Negli USA, in quegli anni, sono in piena espansione i Black Muslims, movimento fondato nel 1931 da Elijah Muhammad e in grande ascesa a partire dal 1952, anno in cui Malcolm X, convertitosi all'Islam in prigione nel 1948 (singolare la coincidenza di date ed età con Coltrane), inizia la sua attività pubblica su quella sponda. Al di là delle palesi, fanatiche mistificazioni di cui lo stesso Malcolm X si avvede una volta separatosi dai Muslims (ciò che avviene alla fine del 1963), è proprio la sua Autobiografia a restituirci con proprietà di toni il clima infatuato e vagamente mitologico-apocalittico della cosiddetta Nazione dell'Islam. Il nemico numero uno è il "diavolo bianco dagli occhi azzurri". Nessun bianco - se non come individuo certo come entità - è meno che spregevole. Rigorosissime le restrizioni morali. "Nella Nazione dell'Islam erano proibiti tutti i rapporti sessuali illeciti, il consumo della carne dell'immondo suino e di altri cibi dannosi e malsani, del tabacco, dell'alcool e degli stupefacenti. Nessun Muslim seguace di Elijah Muhammad doveva andare a ballare, giocare d'azzardo, andar fuori la sera con rappresentanti dell'altro sesso, al cinema, praticare degli sport insieme con i bianchi, o prendersi delle lunghe vacanze. I Muslims non dormivano più del necessario per la salute (...) quanto all'insubordinazione nei confronti dell'autorità civile era ammessa soltanto se giustificata dagli obblighi religiosi" [Nota 17]. Sul piano dogmatico, l'impostazione non è meno rigida, non di rado in aperto contrasto con l'ortodossia musulmana afro-araba.
E' ovvio che la ferrea regola dei Muslims [Nota 18] non possa riscuotere particolari consensi presso i boppers. Ma è altrettanto evidente che certe suggestioni provengono ai musicisti più o meno direttamente dall'espandersi a macchia d'olio del movimento. L'adozione di nomi arabi e non della X voluta dai Muhammad è del resto indicativa di come i musicisti non aderiscano ai Muslims, mantenendo per contro una loro autonomia. John Coltrane, per parte sua, non muta nome: la sua religiosità è fin dall'inizio più intima, privata, prologo al panteismo della maturità.
Sarebbe utile, a questo punto, soffermarsi piuttosto nel dettaglio sulle interpretazioni date al fatto religioso da Freud e seguaci. Basterà tuttavia qualche rapido cenno. Fin dal 1907 Freud coglie una stretta connessione tra fenomeno religioso e nevrosi [Nota 19], tanto da definire "la nevrosi come una religiosità individuale e la religione come una nevrosi ossessiva universale". In un caso come nell'altro si tratta di un rifugio, una sorta di zona franca contro le castrazioni pulsionali. Tali rilievi sono ripresi in particolare da Theodor Reik (lo incontreremo più avanti), mentre lo stesso Freud torna ripetutamente sull'argomento, ribadendo la sostanziale funzione equilibratrice della credenza religiosa: "il pio credente è protetto in misura notevole contro il pericolo rappresentato da talune malattie nevrotiche; l'accettazione della nevrosi universale lo sottrae al compito di costruirsi una nevrosi individuale" [Nota 20]. A una funzione parallela adempie come abbiamo visto la stessa pratica artistica, tanto da determinare nei secoli sintomatici attriti fra i due universi. "La proibizione dell'attività artistica, permanente presso la civiltà ebraica e maomettana, temporale e parziale presso quella cristiana, si basa sulla credenza nell'efficacia magica dell'immagine [che conferirebbe] un potere sull'oggetto che essa rappresenta. Nel folclore artistico, il creatore di immagini è molto vicino allo stregone e al mago" [Nota 21].
Quale profonda incidenza possano avere sulla realtà del neroamericano i rilievi freudiani a proposito della funzione sublimante del credo religioso appare più che evidente. E la stessa linea intestina che unisce la pratica religiosa a quella artistica attraverso il comune tessuto magico-ritualistico è altrettanto palese. Il musicista neroamericano ricompone così in sé certe antiche fratture fra arte e religione, rivestendo quest'ultima di connotati strettamente spirituali più che etici, ampiamente suggestivi, astratti, anche medianici. Ed ecco che allora anche il ricorso agli stupefacenti concorre a questa sorta di dérèglement di rimbaldiana memoria, certamente pagana per la cultura occidentale, al contrario spiccatamente mistica per quella orientale, alla quale il nero è ovviamente più portato ad aderire.
A causa dell'indecorosa prostrazione psicofisica che gli provoca il massiccio ricorso all'eroina, John Coltrane perde una quantità impressionante di ingaggi; nel '51 è licenziato da Gillespie, nel '54 da Johnny Hodges, nel novembre '56, infine, da Miles Davis. All'epoca è sposato da poco più di un anno con Juanita Grubbs (cioè Naima), una giovane musulmana conosciuta nel giugno '54 a casa di Steve Davis. Scaricato da Miles, è costretto a lasciare New York per tornare a Filadelfia. Qui, nel dicembre 1956, forma il suo primo quartetto, già con i giovanissimi McCoy Tyner e Jimmy Garrison, più Al Heath alla batteria. Ottiene un ingaggio al Red Roster, ma non dura più di tre serate: nel tentativo di liberarsi dall'eroina, si è imbottito di alcool oltre ogni limite ragionevole. Col fallimento al Red Roster, ad appena un mese dal ben servito ricevuto di Davis, John tocca realmente il fondo. Il più, ora, è riuscire a risalire.
Il 1957 rappresenta in tal senso il suo anno zero, l'anno delle prime importanti rivincite. In gennaio, come già Miles Davis e tanti altri, affronta il cosiddetto "tacchino freddo": si isola in camera per giorni e giorni, poi chiede dell'acqua da bere. Scosso fino al midollo nell'orgoglio, vuole risciacquarsi da capo a piedi, per poi rielevarsi spiritualmente e creativamente. Si dedica a letture mistiche e mitologiche, si avvicina sempre più alla cultura africana e orientale, abbraccia i primi esperimenti modali, rielaborando canoni propri del raga indiano. In primavera è con Thelonious Monk e dirige le prime sedute d'incisione a suo nome. Poi, in novembre, riesce a far quadrare il cerchio: Miles lo richiama con sé.
Costituito finalmente un proprio quartetto stabile nel 1960, Coltrane attraversa una nuova fase critica a cavallo fra 1961 e '62. Dalle pagine di "Down Beat," John Tynan attacca con violenza la sua musica, che arriva a definire anti-jazz. Coltrane replica che sarebbe bene non gettar fango su ciò che non si è in grado di capire, e invita i suoi detrattori a un faccia a faccia, che nella realtà non avrà mai luogo. E' l'epoca del sodalizio con Eric Dolphy, giustiziato da feroci stroncature, allargatesi anche al di qua dell'Atlantico a seguito di un peraltro largamente celebrato (in seguito) tour nel Vecchio Continente, ma anche da maldestre insinuazioni sulla natura dell'amicizia fra i due musicisti. "Un vero inferno," ricorderà Coltrane anni dopo [Nota 22]. Come se non bastasse, anche il rapporto con la moglie s'incrina. A Don De Micheal di "Down Beat," che gli offre l'opportunità di dire la sua e sfidare la critica avversa [Nota 23], Coltrane precisa tuttavia in questi termini quelle che sono ormai saldamente le coordinate del suo credo artistico: restituire a chi ascolta l'immagine quintessenziata di un mondo meraviglioso, e in tal modo rendere omaggio a Dio.
La musica, dunque, come mezzo di espressione universale, ma al tempo stesso terreno d'incontro fra culture differenti. Tutti del 1961 sono brani come "Olé," "Africa," "India," in cui Coltrane raccoglie echi di ovvia provenienza extrajazzistica, mentre in altri titoli, per lo più successivi, compaiono dediche di esplicito referente mistico: "A Love Supreme," "Ascension," "Meditations," "Offering," eccetera. In altre opere dell'ultimo periodo quali "Om" e "Kulu Sè Mama" i due rimandi si fondono [Nota 24]. Ma, soprattutto con gli anni, il canto coltraniano si fa ringhioso e squassante. Le immagini evocate sono spesso cruente e laceranti. Il mondo che vi si specchia è tutt'altro che meraviglioso.
(1 - continua) [Per leggere la seconda parte clicca qui]
______________________________________
1) POLILLO, Arrigo, Stasera jazz, Milano, Mondadori, 1978, p. 119. 2) In Libri nuovi, "Musica Jazz," maggio 1976. 3) Andrà ricordato al proposito che quella che è un po' la miccia di un quindicennio di aspre lotte razziali risale al dicembre 1955, allorché una neroamericana, Rosa Parks, su un bus di Montgomery (Alabama) rifiuta di cedere il posto a sedere a un bianco, finendo arrestata. La reazione dei neri è decisa e clamorosa: i bus di Montgomery vengono boicottati per ben 382 giorni, finché la Corte Suprema non sancisce l'illegittimità della discriminazione sui bus. Ma la vittoria del movimento nero - condotta da un giovane pastore battista destinato a far molto parlare di sé: Martin Luther King - sta soprattutto nell'aver messo in campo una determinazione e una coesione che il mondo bianco segregazionista non prevedeva. All'epoca, singolarmente, anche Coltrane è al suo battesimo di fuoco: il primo ingaggio con Miles Davis. Al tempo del suo sodalizio con Monk, poi, ci sarebbero da ricordare i moti di Little Rock (Arkansas), dove nove studenti si ribellano alla segregazione scolastica de facto che disattende la legge del 17 maggio 1954, scatenando la reazione del governatore Orval Faubus, al quale Mingus dedicherà il celeberrimo "Fables of Faubus". E si potrebbe continuare, fino alla stessa scomparsa di Coltrane, avvenuta proprio in quella medesima estate di morte del 1967 che, sul fronte della Black Revolt, inanella qualcosa come 164 sommosse, in particolare a Detroit, Cincinnati e Newark.
4) Coltrane è stroncato da un tumore al fegato appena prima di compierne quarantuno, mentre poco prima dei quaranta vengono assassinati sia Malcolm X che Luther King. Il primo, nato a Omaha il 19 maggio 1925, è abbattuto da sedici proiettili il 21 febbraio 1965 durante un comizio all'Audubon Ballroom di Harlem. Il secondo, nato ad Atlanta il 15 gennaio 1929, è raggiunto da un solo colpo mortale, al collo, mentre è affacciato al balcone della sua stanza all'Hotel Lorraine di Memphis. E' il 15 aprile 1968.
5) KILLIAN, L.M., Una rivoluzione impossibile? Black Power, Milano, Il Saggiatore, 1969, pp. 54/5.
6) Malcolm Little si ribattezza Malcolm X nel 1952 una volta convertitosi all'Islam ed entrato nei Black Muslims di Elijah Muhammad. La X, comune a tutti i Muslims, intende sostituire il cognome dato a suo tempo al nero dal padrone bianco, spesso stupratore delle donne nere, come appunto nel caso della nonna (materna) di Malcolm, al quale da questo fatto deriva il colore più rossiccio che nero sia della pelle che della capigliatura.
7) La descrizione è dello stesso Malcolm X, ed è riportata a p. 12 dell'Autobiografia scritta in collaborazione con Alex Haley (prima edizione italiana: Torino, Einaudi, 1967). La morte per mano dei bianchi è una tragica costante nella famiglia Little: oltre che al padre, a ben cinque dei sei zii di Malcolm (il quale scrive: "Ho sempre avuto la convinzione che anch'io morirò di morte violenta," p. 4) tocca identica sorte.
8) E' opinione diffusa che proprio questa ritrosia a esternare le proprie ansie stia alla base della sua fine improvvisa. Se fu un tumore al fegato a ucciderlo, infatti, è noto che fino all'ultimo Coltrane non rivelò a nessuno le proprie pene, accettando il ricovero in ospedale soltanto quando era ormai in fin di vita. Da vari mesi aveva diradato l'attività; poi, in maggio, aveva cancellato un lungo tour europeo programmato per il novembre successivo. Pur dichiarandosi esaurito, la ragione che addusse ufficialmente fu un'altra: Alice era incinta e lui preferiva starle vicino.
9) Vedi al proposito il rilievo di Berendt in nota 13.
10) FREUD, Sigmund, L'avvenire di un'illusione, in Opere, Torino, Boringhieri (trad. C.L. Musatti), vol. X, 1978, p. 443/4.
11) LAMI, Guido, Le condizioni psicoanalitiche, in AA.VV., Il valore della musica, "Quaderni di San Giorgio," Firenze, Sansoni, 1965, pp. 80/1.
12) FREUD, S., La scissione dell'Io nel processo di difesa, in Opere, cit., vol. XI, 1979, p. 558.
13) BERENDT, Joachim Ernst, Il libro del jazz, Milano, Garzanti, 1973, p. 126.
14) TENOT, Frank, John Coltrane, "I grandi del jazz," Milano, Fabbri, 1981.
15) POLILLO, A., Stasera jazz, cit., p. 122.
16) COMOLLI, Jean-Louis, Antibes 65, "Jazz Magazine," settembre 1965.
17) Autobiografia di Malcolm X, cit., p. 228.
18) Ben più di facciata che effettiva, in realtà. L'allontanamento di Malcolm X da Elijah Muhammad, ad esempio, trae origine proprio dalla scoperta dei rapporti adulterini intrattenuti per anni da quest'ultimo con due sue segretarie, madri l'una di tre figli, l'altra di uno, tutti frutto di tali ménage. C'è da sottolineare al proposito come il fratello minore di Malcolm, Reginald, fosse stato espulso dai Muslims intorno al 1950 per immoralità. Il ragazzo, completamente abbandonato dalla famiglia in ossequio alla regola Muslim, finì per uscire di senno ed essere rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Tale fanatismo si sarebbe del resto ritorto contro lo stesso Malcolm una volta caduto in disgrazia presso gli ex-confratelli. Sul piano sociale, inoltre, la potenziale forza catalizzatrice del malcontento nero fu regolarmente congelata da Muhammad, legato da interessi economici addirittura al Ku Klux Klan! Si comprende, in quest'ottica, il pericolo rappresentato da un Malcolm X e il suo defenestramento dai Muslims. Muhammad intendeva creare un polo alternativo, ostico per il bianco, tale da indebolire gli integrazionisti neri, capaci di guadagnarsi quella solidarietà che avrebbe favorito l'ascesa del movimento nero a tutto danno dei suoi alleati dietro le quinte. Sull'argomento, vedi GIAMMANCO, Roberto, Introduzione, in Autobiografia di Malcolm X, cit., pp. XXVI/XXVIII.
19) FREUD, S., Azioni ossessive e pratiche religiose, in Opere, cit., vol. V, 1972, pp. 341/9.
20) FREUD, S., L'avvenire di un'illusione, cit., p. 474.
21) KRIS, Ernst, Ricerche psicoanalitiche sull'arte, Torino, Einaudi, 1967, p. 41.
22) KOFSKY, Frank, John Coltrane: une interview inédite, "Le Jazzophone," novembre 1983 (l'intervista risale al novembre '66).
23) Cfr. DE MICHEAL, Don, John Coltrane and Eric Dolphy answer the jazz critics, "Down Beat," 12/4/62. 24) Sarà appena il caso di notare, a rimarcare l'importanza di tutte queste pagine nell'estetica coltraniana, come dei nove titoli fatti, ben sette (salvo "India" e "Offering") siano gli stessi di altrettanti album.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.