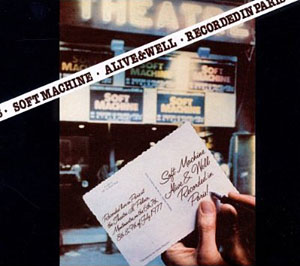Home » Articoli » Lyrics » L'orchestra d'improvvisazione: Ancient to the Future
L'orchestra d'improvvisazione: Ancient to the Future
Non è mia intenzione stilare qui una sorta di albero genealogico delle orchestre d'improvvisazione, o orchestre creative, o comunque vogliamo chiamarle, attività che finirebbe col somigliare alla compilazione di un elenco del telefono e comporterebbe antipatiche scelte di attribuzione: questa orchestra è creativa, quest'altra no. Vorrei invece soffermarmi su alcuni elementi che emergono dal passato e che ritengo possano essere utili nella concreta attività di chi fa musica.
Nonostante parecchi luoghi comuni, se osserviamo la storia delle big band nel suo svilupparsi attraverso i decenni, incontriamo in primo luogo una difficoltà nel definire il «tipico» suono orchestrale. Certo, alcune sue formalizzazioni sono ormai proverbiali: il «suono Swing» (tanto quello della direttrice che da Fletcher Henderson va a Benny Goodman quanto quello che rimane ben inserito nei moduli di Harlem, diciamo la linea Luis Russell - Jimmie Lunceford - Chick Webb); il «suono Kansas City» degli anni Trenta e Quaranta; la grande tradizione moderna concretizzata da Count Basie negli anni Cinquanta (con arrangiatori del resto tanto diversi e originali quanto Ernie Wilkins, Quincy Jones, Neal Hefti: l'immagine mentale che oggi ci facciamo di «quel» Basie è in effetti un'arbitraria astrazione delle sue varie, benché sostanzialmente contemporanee, incarnazioni), via via aggiornata ma mai messa radicalmente in discussione dai vari Thad Jones - Mel Lewis, Kenny Clarke - Francy Boland o Clark Terry.
Ma molte di più sono le grandi orchestre rimaste nella storia che non danno vita a vere e proprie scuole (pur destando magari enorme ammirazione): un ridotto ma già significativo elenco potrebbe comprendere Stan Kenton, Boyd Raeburn, il Woody Herman degli anni Quaranta, Gil Evans, George Russell, la Concert Jazz Band di Gerry Mulligan, la coppia Eddie Sauter - Bill Finegan, Oliver Nelson, Don Ellis, Charles Mingus, Carla Bley, per arrivare alla constatazione che quasi tutte le incisioni più importanti di Ellington (qualche esempio? East St. Louis Toodle-O, Concerto for Cootie, A Tone Parallel to Harlem, Madness in Great Ones, La plus belle Africaine, che a un orecchio vergine potrebbero parere testimonianze di cinque diverse formazioni) difficilmente possono essere considerate capostipiti di una solida tradizione.
Dunque, in un certo senso, l'imprevedibilità della big band è connaturata alla sua sostanza. Questo rende difficile definire, diciamo così, per contrasto rispetto a un preciso modello (come esse sicuramente vorrebbero) quelle che abbiamo convenuto di chiamare le «orchestre d'improvvisazione» attuali. Certo l'imprevedibilità non è l'unico elemento che le caratterizza; ma mi pare ne costituisca un tratto saliente. Se dobbiamo ipotizzarne un identikit, credo che queste formazioni si basino su tre componenti di base: la struttura eterodossa dei suoi ranghi strumentali; il desiderio di uscire dalle convenzioni compositive; la libertà data ai solisti. Però, se è vero che un «canone orchestrale» è difficilmente rintracciabile nella storia delle big band jazzistiche, questi elementi finiscono col basarsi su fondamenta abbastanza fragili. Osserviamoli più nel dettaglio.
La struttura. È vero che la formazione «abituale» di una big band è quasi un luogo comune. Schematizzando molto e tentando una sintesi che abbracci tutta la storia del jazz, consta di una sezione ritmica (pianoforte, contrabbasso e batteria, cui si aggiungono più o meno correntemente chitarra, vibrafono, percussioni) affiancata da due gruppi di fiati, ottoni e ance, con i primi (in numero solitamente superiore ai secondi) suddivisi fra trombe e tromboni a creare una sorta di modello scalare: le trombe più numerose dei tromboni ma meno delle ance. Naturalmente tutto questo è dettato da esigenze (e abitudini) di equilibrio timbrico e di dinamica complessiva. Per lo stesso motivo le ance sono il più delle volte dei sassofoni, con preminenza dei suoni acuti sui gravi, e i loro esecutori sono chiamati, dove necessario, ad alternarli con i clarinetti (o i flauti).
Però questa struttura è già messa in discussione, o quanto meno subisce decisive correzioni, da una cinquantina d'anni. Quelli che oggi vengono considerati i «classici» dischi di Gil Evans con Miles Davis propongono una sovrabbondanza di ottoni, sbilanciati sui suoni gravi (tromboni bassi, corni, tuba), e una sezione d'ance nella quale i sassofoni sono assolutamente minoritari se non assenti, mentre la sezione ritmica è ridotta all'osso (e magari, invece del piano, prevede un'arpa); e questi dischi nascono da un ricco humus di esperienze timbriche orchestrali. Ci sono gli esperimenti third stream di Gunther Schuller, John Lewis, J.J. Johnson, Jimmy Giuffre; ci sono, già all'aprirsi degli anni Cinquanta, gli eccessi kentoniani (cinque trombe, cinque tromboni, due corni, tuba, cinque sax che affiancano clarinetti, flauti e ance doppie, sedici archi, più chitarra pianoforte contrabbasso batteria e congas!).
Veniamo alle formule compositive. Qui l'esempio di Gil Evans (e della third strema, e di Kenton) ci soccorre meno, basato com'è su una complessa ambizione strutturale difficilmente etichettabile. Però c'è una lunga tradizione di pattern per big band che sembra sorprendentemente confermata dalle orchestre d'oggi. Mi riferisco a due artifici d'ampio uso fin dagli anni Trenta: la struttura a riff, che in sostanza qualifica l'Età dello Swing, e l'alternanza fra «pieni» e «vuoti» orchestrali (cioè, in pratica, fra momenti scritti, corali, e momenti improvvisati, individuali).
Va notato che questi due paradigmi espressivi non sono vere e proprie indicazioni di scrittura, ma concetti dinamici ed espressivi, che lasciano un'enorme libertà d'azione al loro interno. Un'orchestra che dimostra, ancor oggi, quanto creativi possano essere è quella dei secondi anni Quaranta di Dizzy Gillespie, vera fucina (forse troppo poco ascoltata, allora come oggi) di modernità: basterà ricordare le idee contenute in Things to Come, Cubana Be Cubana Bop, Manteca, One Bass Hit o Ow.
Rimane la libertà dei solisti. Non c'è dubbio che quella presente nelle «orchestre d'improvvisazione» sia molto ampia, e si appropri delle grandi conquiste avvenute con le diverse avanguardie degli anni Sessanta e Settanta, distanziandosi recisamente dalla routine delle big band tradizionali, nelle quali gli assoli sono incastonati rigidamente nel tessuto dell'arrangiamento. Ma sarebbe da verificare quanto questa libertà sia coerente con il concetto di grande orchestra e tenga conto delle diverse variabili che il rapporto fra collettivo e individuo ha conosciuto nel corso della storia passata; del resto non sarebbe difficile ricostruire un lungo percorso di piena libertà solistica anche all'interno di molte tappe orchestrali ormai lontane nel tempo, per esempio in Africa di John Coltrane.
Ma se dobbiamo citare una singola personalità che profetizza nitidamente le formazioni che oggi ci interessano, credo sia inevitabile fare il nome di Sun Ra e della sua Arkestra. Diversi motivi ne fanno un uomo chiave nello sviluppo delle attuali «orchestre d'improvvisazione»: il suo ruolo pionieristico fin dagli anni Cinquanta; la consonanza fra i suoi musicisti, legati da uno strettissimo rapporto umano prima ancora che musicale; l'estrema variabilità della formazione, anche a distanza molto ravvicinata nel tempo; l'uso di strumenti eterodossi (etnici, elettronici, autocostruiti...) come pratica esplicita del reinventare la musica; il polistrumentismo di tutti gli esecutori; l'eclettismo nelle scelte stilistiche; l'esplosiva inclusione delle percussioni, che ribalta la dimensione sonora dell'orchestra (per la quale però rimando ancora a certe straordinarie intuizioni gillespiane). Molti di questi elementi, è inutile sottolinearlo, sono al centro della ricerca odierna.
Inoltre Sun Ra, nel suo anomalo percorso stilistico, mette quasi fra parentesi la rivoluzionaria svolta del bebop: i maggiori parametri di questo stile sono sostanzialmente ignorati nella gran diversità di invenzioni orchestrali proposte dall'Arkestra in quarant'anni di incisioni, che affondano le loro radici piuttosto nelle logiche della Harlem anni Venti, della Chicago anni Quaranta, di un esotismo fantastico e sempre più radicale (c'è anche qualcosa di Tadd Dameron, che è comunque il meno boppish di tutti i bopper). Chi si è ispirato al caporchestra di Birmingham ha dunque avuto una sorta di lasciapassare nel considerare la tradizione bop, con tutto il suo sciame di atteggiamenti ormai convenzionali, troppo ingombrante.
Così, l'esempio di Sun Ra sembra centrale in molti esperimenti ormai storici: direttamente, come nei primi documenti della Globe Unity (i due brani contenuti nel suo primo disco, del 1966, s'intitolano Globe Unity e Sun), nelle rare uscite orchestrali di Bill Dixon, nell'ampia produzione di Muhal Richard Abrams; o mediato, come nel caso di un disco che a rigore non è orchestrale ma ha un impatto decisamente «denso» e comunque ha segnato profondamente la ricerca europea in questa direzione, «Machine Gun» di Peter Brötzmann (1968), che evoca «Ascension» di Coltrane, disco a sua volta influenzato dall'Arkestra.
Anche un'esperienza difficilmente classificabile come la Jazz Composer's Orchestra ha parecchi agganci con le idee di Sun Ra, il quale, non a caso, era fra i membri fondatori di quella Guild da cui sarebbe nata la formazione «aperta» di Michael Mantler e Carla Bley: per stabilire questo legame, o meglio per identificare il tessuto connettivo che lega i maggiori esponenti del jazz newyorkese nella seconda metà degli anni Sessanta, si potrebbero ricordare il brano Circus '68 '69 nell'album d'esordio di Charlie Haden o il classico «Mama Too Tight» di Archie Shepp. Non c'è dubbio che le idee dell'arrangiatrice californiana, ben presto divenuta l'anima trainante dell'orchestra fondata con Mantler, siano per molti versi agli antipodi di quelle del caporchestra dell'Alabama; ma almeno un fattore forte li unisce, il pronunciato eclettismo. E questo è un elemento chiave, che merita un approfondimento a sé, nella scena attuale delle «orchestre d'improvvisazione».
Fino all'avvento a metà degli anni Sessanta della scuola di Chicago, ovvero del primo movimento che storicizza il free, superandolo, i grandi protagonisti del jazz non parevano cercare una visione sincronica della loro musica. Naturalmente avevano salde radici nel passato (questo è un dato imprescindibile in particolare della cultura afroamericana, che non è mai interessata a rotture con i propri ancestors), ma lo integravano organicamente, direi senza detriti visibili, nelle proprie conquiste tecnico-espressive.
L'AACM, invece, pone (fra l'altro) al centro della propria ricerca un enciclopedico richiamo agli stili precedenti, un orgoglioso recupero di climi e modalità «alla maniera di».
I tanti slogan dell'Art Ensemble of Chicago, «Great Black Music», «Ancient to the Future», «From the Roots to the Source», «Dreaming of the Masters», così come vari titoli di album di Muhal Richard Abrams quali «Things to Come from Those Now Gone», «Family Talk» o «Think All, Focus One» raccontano proprio questa scelta che corrisponde a una presa di coscienza: l'avanguardia si fa anche appropriandosi della lettera del passato.
Si può dire che ogni movimento stilistico successivo abbia tenuto conto di questa indicazione (e forse, alla luce di quanto ho esposto, andrebbe rivista e relativizzata anche la demonizzazione di tante recenti esperienze tacciate di manierismo). Senz'altro le idee di «avanguardia di sintesi» sviluppate dagli anni Ottanta da una nuova generazione di ricercatori focalizzano e modificano la concezione chicagoana, passando da un atteggiamento per così dire ecumenico a una sorta di selettività trasversale, che unisce e, appunto, sintetizza sotto forme nuove echi stilistici appartenenti alle più diverse stagioni del passato.
Insomma, a mio parere l'eclettismo è oggi un fattore che contiene forti motivazioni estetiche, non soltanto scelte di moda: paradossalmente, nonostante possa comunicare l'accidioso rifiuto di una precisa presa di posizione stilistica, esso è a sua volta saldamente radicato in una ben definita epoca storica. Naturalmente è qualcosa di diverso dall'eclettismo, cui prima facevo riferimento, di Sun Ra e di Carla Bley (che ha motivazioni più «militanti» e in linea con l'epoca cui appartengono, di ironia quando non addirittura di aperto sberleffo alle «regole» dettate dalla critica); ma è ragionevole riconoscere che a quegli esempi storici possano rifarsi, su un piano formale, i più giovani interpreti, cresciuti in una temperie estetica che non rimanda a un monolitico criterio esecutivo.
Riassumendo, e concludendo. Le attuali «orchestre d'improvvisazione» si contrappongono a un modello sclerotizzato di big band; ma questo modello è l'immagine molto semplificata, per quanto vincente sul piano comunicativo, di un processo storico nel quale sono quantitativamente preminenti (beninteso, se si tien conto delle esperienze basilari del genere) formazioni di grande originalità stilistica o anche semplicemente sonora. Ignorare la varietà delle loro indicazioni può involontariamente costringere gli organici attuali a modalità espressive ingiustamente ridotte.
Tanto più che le formule dinamiche e più in generale di organizzazione del suono collettivo, in questi ensemble, sono troppo spesso basate su un'attualizzazione un po' banale di antichi artifici: i riff si sono trasformati in pedali, gli spettacolari stacchi da piano a forte hanno lasciato il posto a più sofisticati crescendo e diminuendo, le parentesi destinate alle improvvisazioni accompagnate dalla sezione ritmica sono state magari sostituite da ampi episodi solitari o d'improvvisazione a più voci, ma è ancora troppo raro un radicale ripensamento dell'uso creativo della piena voce orchestrale e della scrittura stessa, come accade nelle conductions di Butch Morris o nella decisione istantanea di scegliere fra più parti opzionali, come può avvenire in certi lavori di David Murray o di Anthony Braxton.
Ancora, l'eterodossia negli organici mi sembra sia divenuto un fine anziché un mezzo. Non c'è nessun motivo perché un'orchestra senza ottoni, sostituiti magari da una sezione di strumenti a corda, sia per ciò stesso più stimolante e creativa di una big band tradizionale; l'importante è inventare una logica compositiva (cioè: di scrittura e di improvvisazione) coerente con la formazione data, e questo può essere tanto difficile (e tanto stimolante) con un'orchestra «ortodossa» quanto con una «eterodossa». Rimando ancora una volta alle molteplici soluzioni genialmente ideate da Gillespie e dai suoi arrangiatori nel breve arco di due o tre anni.
E infine: l'eclettismo stilistico è un'ottima freccia all'arco delle nuove orchestre, a patto che non si appiattisca a mero espediente di varietà esecutiva, utilizzato allo scopo di tener desta l'attenzione del pubblico (o, peggio ancora, di realizzare un «prodotto» valido, almeno in parte, per ogni ascoltatore). Va cioè anch'esso fatto emergere alla coscienza degli esecutori, perché diventi materiale coerente con la loro poetica: così come aveva una funzione ideologica, di scavo e chiarificazione delle radici, per i protagonisti dell'AACM e una funzione espressiva e stilistica, d'identificazione di un fil rouge a un capo del quale orgogliosamente collegarsi, nella successiva «avanguardia di sintesi».
Foto di Claudio Casanova (Butch Morris) e Jacky Lepage (Art Ensemble of Chicago).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.