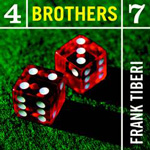Home » Articoli » Lyrics » Liberare il free: oltre la dialettica tra avanguardia e mainstream
Liberare il free: oltre la dialettica tra avanguardia e mainstream
La domanda che Farnè ci pone, se alcune attuali esperienze del linguaggio afroamericano possano costituire una "nuova avanguardia" [con tutte le approssimazioni tassonomiche e i distinguo che il maneggiare determinati termini presenta] o si debbano invece considerare come esiti di una rilettura "classicista" - più o meno creativa - accomunabile a altre "corsie" del mainstream, è in fondo solo un'altra faccia dell'infinito trabocchetto che la musica ci tende. Dolcissimo gioco di specchi, tempestato di meravigliose gemme, ma quasi impossibile da districare, dal momento che variabili e componenti sempre nuove si aggiungono.
Uno dei primi punti chiave da cui partire è, a mio modo di vedere, da rinvenirsi in quel movimento quasi "carsico" che determinate istanze creative - in particolar modo afroamericane - hanno percorso a partire dalla morte di Coltrane [momento simbolico per più di un motivo] fino alla relativa rinascita - su cui torneremo a breve - di questi ultimi anni.
Se durante gli anni Settanta - complice anche una concomitanza di circostanze storiche e politiche - alcuni esiti della ricerca "nera" [una ricerca che si apriva a 360 gradi a suggestioni folkloriche, di composizione contemporanea colta, incominciando ad "annusarsi" con i colleghi improvvisatori europei] ebbero una certa popolarità, penso all'Art Ensemble, a Braxton che riempiva i palasport, ben presto queste esperienze sono state obliate e hanno dovuto sopravvivere in modo più o meno underground.
Una prova? Nell'epoca in cui si ristampa anche il gorgheggio inascoltabile trovato nel fondo dell'ultimo cassetto del jazzista di turno, sono da anni indisponibili, magari mai ristampati in CD o comunque di difficile reperibilità alcuni capolavori del jazz di quel decennio, cose magari di Julius Hemphill o di Henry Threadgill, dello stesso Braxton.
E nelle scuole di jazz? Dare agli studenti anche solo qualche accenno alle strategie compositive e di improvvisazione post-coltraniane è una mera utopia, per un sistema educativo che prende il canone a ghirlanda "bop-hardbop-modale" come punto di riferimento quasi esclusivo per torme di allievi che chiedono di imparare a "scongelare il pesce" invece di imparare a "pescarlo".
L'oblio del cosiddetto jazz "creativo", di quella musica che fa domande [scomodissime talvolta] invece che fornire risposte, assume un significato ancora più ricco [non senza un amaro retrogusto] se si sposta il fuoco su un altro punto chiave di tutta la vicenda: quello del pubblico.
A contribuire alla cosiddetta "rinascita" del free ha contribuito infatti per una parte non trascurabile un pubblico che non veniva dal jazz e che, in molti casi, di altre forme di jazz non si interessa, un pubblico che viene dal rock indipendente, dall'elettronica, dal noise, un pubblico curioso e aperto, per cui la "forza" dell'evento sonoro ha ben maggiore importanza rispetto alla sua evoluzione formale.
Non a caso, uno dei primi libri che ha tentato di "fotografare" la new wave del free, New York Is Now! [2001, The Telegraph Company] è stato scritto da un giornalista, Phil Freeman, che scriveva principalmente per riviste di heavy metal. Non a caso troviamo improvvisatori come Joe McPhee e Braxton collaborare con gruppi rock o noise come i Wolf Eyes, non a caso a dare un importante impulso alla scena ha contribuito il chitarrista dei Sonic Youth, Thurston Moore, così come la rivista inglese The Wire, nata come jazz-magazine e trasformatasi negli anni in una sorta di "bibbia" di quel che c'è di più interessante nelle musiche d'oggi.
Quello che è emerso negli ultimi anni è che alcuni artisti e alcune correnti della musica afroamericana hanno trovato un seguito vero e intenso presso un pubblico che non veniva da una "educazione sentimentale" jazz, un pubblico per cui l'energia di David S. Ware o di Mats Gustafsson ha un significato immediato e istintivo.
Poi, come sempre, c'è la necessità di guardare alle cose in modo più vasto e se in Italia questa "rinascita" del free è stata percepita in modo particolare è stato anche grazie al lavoro di alcuni operatori: pensiamo a rassegne come il Musicus Concentus a Firenze, quella del Centro D'Arte a Padova o Risonanze a Venezia, per non dire del grandissimo supporto che Pino Saulo e la sua redazione a Radio3 ha fornito ai migliori artisti della scena, sia nelle sue trasmissioni che nei concerti [uno su tutti la benemerita tre giorni del festival romano "New York Is Now!"].
Ma a livello di stampa una buona parte dei giornalisti di casa nostra si è accorta dei vari Matthew Shipp e William Parker [santificandoli con il rito annuale del Top Jazz] solo in concomitanza di uscite di loro dischi per etichette italiane, dischi che magari non erano nemmeno tra i più rappresentativi del loro "stato dell'arte".
In realtà la maggior parte degli artisti citati da Farnè rimangono comunque musicisti di nicchia, che in manifestazioni come Umbria Jazz, per esempio, è davvero improbabile trovino posto, così come negli scaffali di tanti negozi [ma tanto i dischi, chi li compra più?].
Sono dunque lecite e non prive di una loro coerenza le riflessioni che sottolineano come anche molte esperienze di derivazione free siano in un certo senso affette da un certo "classicismo", utilizzando linguaggi e tecniche di quarant'anni fa.
Ma rimane la sensazione che si possa superare questa impostazione, frutto di una tendenza, tipica dell'analisi critica occidentale, a una dialettica che razionalizzi l'irrazionale, le tensioni, le ansie rivoluzionarie, attraverso la sintesi, mettendo ordine, facendo rientrare l'eccezione nella regola.
Penso che una delle possibili ricchezze della musica di oggi [jazz in testa] sia proprio quella di non doversi piegare a questa sintesi dialettica e che sia più interessante affrontare la storia [le storie] del jazz non più in termini di sintesi, ma sottolineando le eccezioni, le traiettorie irriducibili di ricerca e tensione, facendo nuovamente aprire la possibilità dialogica dell'opera.
Ecco allora, tentando di giungere a qualche punto d'appiglio, che l'affiorare [e il riaffiorare] in alcune musiche di quella urgenza espressiva, di quello stato di coinvolgimento e di dissidio permanente rispetto al reale in cui il linguaggio artistico evidenzia ciò che è nascosto o rimosso [quella che Rosalind Krauss chiama la "condizione postmediale"], riporta alla luce del sole parte di quelle esperienze che si erano "carsicizzate" nei decenni precedenti.
[Anche per questo motivo non ci sentiamo di condividere l'accostamento - pur posto con la consueta arguzia espositiva - che il direttore di Musica Jazz Filippo Bianchi ha fatto tra Mats Gustafsson che rilegge "Mopti" di Don Cherry e Micheal Bublè che canta "Mondance": altri i presupposti, altri i significati, altri i contesti]
Se n'è già riflettuto nell'ambito della critica d'arte e mi sembra che il ragionamento funzioni anche in ambito musicale: il nostro tempo che si apre dopo la "fine dell'arte" è riuscito a scoperchiare quelli che sono stati definiti efficacemente come i "sotterranei bui" della modernità, offrendoci un quadro veritiero dell'illusione di unità, di ragionevolezza tipica della tradizione umanista e idealista che aveva assegnato alla musica il compito di rispecchiare la propria ambizione di perennità.
In uno scenario saturo di significati "dati", ecco che la lezione del free [e direi in modo ancora maggiore quella del post-free], così come figure sottovalutate e difficilmente ingabbiabili come Lennie Tristano, Thelonious Monk, Jimmy Giuffre, Herbie Nichols [solo per dirne alcuni] assumono un'importante valenza di riferimento per un pubblico [anche nuovo] e una generazione di musicisti che voglia trarre dallo smarrimento conseguente alla perdita dell'identificazione idealistica una serie di spunti creativi.
Non si vuole qui necessariamente sposare in toto una visione "antropologica" della musica - tantomeno di una musica come quella afroamericana così ricca di intrichi di significato - ma non c'è dubbio che il ruolo della ricezione dei musicisti e delle loro opere è in grado di "aprire" relazionalmente la musica, attivando così una pluralità di prospettive, di situazioni percettive, di riflessioni emotive che altrimenti rimarrebbero appiattite dalla pervasività dei media e dall'utilizzo "promozionale" che di qualsiasi discorso critico si può fare.
Penso dunque che la rilevanza della crescente attenzione da parte di una fetta del pubblico e della critica nei confronti di alcuni linguaggi musicali - la scena nera creativa attorno a William Parker, ma anche il brulicare di idee e musicisti downtown, così come alcune imprescindibili esperienze europee - stia proprio nella ricchezza degli spunti e delle idee individuali che diventano terreno di confronto.
E questo assume una valenza ancora più importante in uno scenario in cui lo stesso "oggetto disco" sta perdendo il proprio valore identitario, in cui la mancanza di figure centrali - giustamente evidenziata da Claudio Sessa nel suo intervento nel dibattito su Musica Jazz - invita a lasciare le comode sponde della dialettica tra modernismo e avanguardia per cogliere la complessità dei linguaggi del jazz in una prospettiva in cui le stesse ambiguità della condizione artistica ci parlano con onestà della musica, di noi stessi.
Forse, dopotutto, la beffa migliore che possiamo architettare ai danni di chi ha tumulato il jazz dentro la definizione [terribile] di "musica classica del Novecento", è quella di fargli aprire la cassa e accorgersi che il corpo non c'è, è fuggito, vivo e ancor più vegeto e pronto a ballare sotto la luna sottobraccio a chi lo vuole ancora ascoltare.
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.